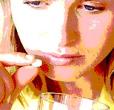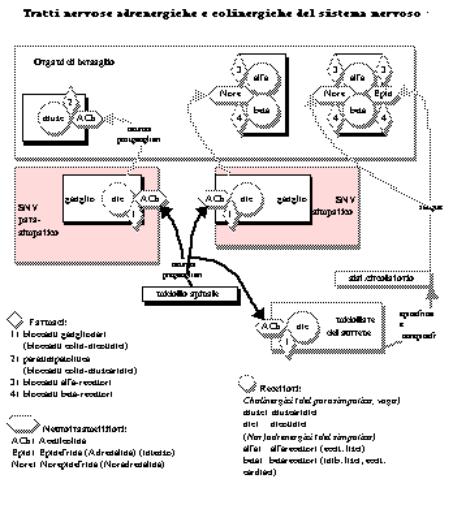|
|
Medicina popolare
per autodidatti
settembre 17, 2005 |
|
INDICE PTO 1: Elementi di psicoterapia
1.0 Natura
e cultura
1.1 Natura
e biologia
1.2 Socialità
1.3 Cultura
1.3.1 Cultura sociale
1.3.2 Cultura e interessi individuali
1.3.3 Spiritualità
1.4 Anima
e psiche
1.4.1 Sequenze e insiemi
1.4.2 Coordinazione, correlazione,
disposizione
1.4.3 Insiemi e sequenze sensoriali
1.4.4 Gestione psichica di insiemi e
sequenze
1.4.5 Insiemi e sequenze comportamentali
1.4.6 Implicazioni terapeutiche
2.0 Sociologia
2.1 Concetto
di sociologia
2.2 Temi
e argomenti della sociologia umana
2.3 Psiche
umana nel contesto sociale e ambientale
3.0 Psicologia
3.1 Psicologia
generale
3.1.1 Percezione e osservazione
3.1.2 Apprendimento e modificazione
3.1.3 Emozione e compimento
3.1.4 Motivazione e collaborazione
3.2 Psicologia
empirica
3.2.1 Valutazione e giudizio
3.2.2 Descrizione
3.2.3 Ipotesi, supposizioni, regole e
leggi
3.2.4 Teorie e modelli
3.2.5 Previsioni e mutamenti
3.3 Approccio
di psicologia analitica e di profondità
3.3.1 Aspetti dinamici: pulsazioni
3.3.2 Aspetti topografici: cosciente,
inconscio, preconscio
3.3.3 Aspetti strutturali: Es, Ich,
Ueber-Ich
3.3.4 Aspetti evolutivi personali (orale,
anale, genitale, latente)
3.3.5 Aspetti energetici-economici
3.3.6 Critica della psicologia analitica
e di profondità
3.3.7 Applicazione della psicologia
analitica
3.4 Approccio
alla psicologia umanistica
3.4.1 Natura dell¹uomo
3.4.2 Teorie della personalità
3.4.3 Comportamento e motivazioni
3.4.4 Conflitti e disturbi
3.4.5 Guida del discorso terapeutico
3.4.6 Critica alla psicologia umanistica
3.5 Psicologia
applicata
3.6 Approccio
della psicologia ³biologistica²
3.6.1 Temi di biologia
3.6.2 Gestione di organismi
3.6.2.1 Gestione di organismi monocellulari
3.6.2.2 Gestione di organismi
multicellulari
3.6.2.3 Policellulari e sostanze messaggere
(ormoni)
3.6.2.4 Concatenamento di ³sensori² e
³attivatori² con ³nervi² e neurotrasmettitori
3.6.2.5 Integrazione di ³nervi² in un
³sistema nervoso²
3.6.2.6 Differenziazione del ³sistema
nervoso² in vegetativo e motorio
3.6.2.7 Differenziazione del sistema
nervoso centrale in funzioni emotive e mentali
3.6.3 Gestione biologica dell¹organismo
umano
3.6.3.1 Gestione emotiva/mentale
nell¹organismo umano
3.6.3.2 Gestione nervosa
3.6.3.2.1 Cervello e
sistema nervoso centrale
3.6.3.2.1.1 Funzioni della
corteccia cerebrale
3.6.3.2.1.2 Funzioni del sistema
limbico-ormonale
3.6.3.2.1.3 Rete neuronale
3.6.3.2.1.4 Neurotrasmettitori e
sostanze messaggere
del
sistema nervoso centrale
3.6.3.2.2 Sistema nervoso periferico e
vegetativo
3.6.3.2.2.1 Neurotrasmettitori del
sistema nervoso periferico
3.6.3.2.3 Cellule nervose (neuroni)
3.6.3.2.3.1 Costruzione di neuroni
3.6.3.2.3.2 Funzionamento di
cellule nervose
3.6.3.2.3.3 Metabolismo di neuroni
3.6.3.2.3.4 Scambio di
neurotrasmettitori
3.6.3.3 Gestione ormonale
3.6.3.3.1 Nesso
neurovegetativo-ormonale
3.6.3.3.2 Ormoni,
neurotrasmettitori, sostanze messaggere
3.6.4 Biologia gestionale
3.6.4.1 Modello psicofisico
3.6.4.2 Fisiologia dello ³stress²
4.0 Medicina
³gestionale² umana
4.1 Dolore
e analgesici
4.1.1 Dolore e analgesici nella medicina
tradizionale
4.1.2 Oppiacei
4.1.3 Analgesici antipiretici
4.1.4 Integratori alimentari/antidolorifici
4.2 Neurologia
e relativa neurofarmacologia
4.2.1 Antiepilettici
4.2.2 Farmaci contro il morbo di
Parkinson
4.2.3 Tonificanti muscolari
4.2.4 Parasimpatomimetici
4.2.5 Farmaci contro l¹emicrania
4.2.6 Farmaci contro il morbo di Alzheimer
4.2.7 Farmaci contro la sclerosi laterale
amiotrofica
4.3 Psichiatria
e relativa psicofarmacologia
4.3.1 Psicofarmacologia
4.3.1.1 Neurolettici
4.3.1.2 Sali di litio
4.3.1.3 Antidepressivi
4.3.1.3.1 Antidepressivi
tri- e tetraciclici
4.3.1.3.2 Inibitori del
riassorbimento di serotonina
4.3.1.3.3 Altri
antidepressivi
4.3.1.4 Psicofarmaci combinati
4.3.1.5 Disintossicazione
4.3.1.6 Psicostimolatori
4.3.1.7 Inibitori d¹appetito
4.4 Psicosomatica
e relativa farmacologia ³sintomatica²
4.4.1 Diagnostica e trattamento di
disturbi psicosomatici
4.4.2 Farmacologia ³psicosomatica
sintomatica²
4.4.2.1 Benzodiazepine (sedativi)
4.4.2.2 Cloralidrati (sonniferi)
4.4.2.3 Sedativi e sonniferi
4.4.2.4 Preparati combinati
5.0 Psicoterapie
5.1 Modelli
terapeutici
5.1.1 Modello comportamentale-adattivo
5.1.2 Modelli relazionali terapeutici
5.1.2.1 Io nel mio ruolo in un gruppo
5.1.2.2 Io in relazione con un altro
5.1.2.3 Io tra me e me (relazione con me
stesso)
5.2 Psicoterapie
corporee
5.2.1 Esempio: Trattamento kinesiologico
degli attacchi di panico secondo Callahan
5.2.1.1 Trattamento principale (esercizio
da eseguire in caso di un attacco)
5.2.1.2 Trattamento esteso (esercizio da
ripetere 3 volte al giorno)
5.2.1.3 Visualizzazione (parte del
trattamento esteso)
5.2.1.4 Trattamento dello stress (come
aiuto nelle situazioni di tentazione, rischio)
5.2.1.5 Invertimento psichico (in caso di
difficoltà nell¹esercizio principale)
5.2.1.6 Invertimento psichico fluttuante
(in caso di difficoltà nell¹invertimento psichico)
5.3 Psicoterapie
farmacologiche
5.3.1 Micronutrienti e funzionamento
cerebrale
5.4 Psicoterapie
verbali (discorsive)
5.4.1 Terapie analitiche
5.4.2 Terapie umanistiche
5.4.3 Terapie comportamentali
5.4.3.1 Esempio: modello di terapia
comportamentale secondo Grossarth
5.4.3.1.1 Questionario
sull¹autoregolazione
5.4.3.1.2 Questionario per
rilevare il grado del piacere e del benessere
5.4.3.1.3 Questionario per la classificazione della
tipologia comportamentale
5.4.3.1.3.1 Tipo 1
³altruistico-inibito²
5.4.3.1.3.2 Tipo 2
³scontroso-agitato²
5.4.3.1.3.3 Tipo 3
³narcisistico-autocentrato²
5.4.3.1.3.4 Tipo 4 ³adeguato²
5.4.3.1.3.5 Tipo 5
³razionalizzante-antiemotivo²
5.4.3.1.3.6 Tipo 6
³antinormativo²
5.4.3.1.4 Questionario
differenziato per distinguere i tipi 1, 2 e 4
5.4.3.1.5 Terapia
comportamentale: allenamento all¹autonomia
5.4.3.1.5.1 Traguardo
5.4.3.1.5.2 Approcci
all¹esito
5.4.3.1.5.3 Principi
terapeutici
5.4.3.1.5.4 Procedura
terapeutica
5.4.3.1.5.5 Attivazione
dell¹auto-osservazione e nessi tra comportamento e conseguenze
5.4.3.1.5.6 Stimolazione
dell¹autoattività per gestire meglio i problemi
5.4.3.1.5.7 Discorso sui
comportamenti alternativi in base a modelli
6.0 Strumenti
didattici per il seminario
6.1 Test
sull¹autoregolazione e il benessere
6.1.1 Test sull¹autoregolazione
6.1.2 Test sulle risorse del piacere e
del benessere
6.2 Tipologia
comportamentale
6.2.1 Questionario per la classificazione
della tipologia comportamentale
6.2.2 Valutazione di tipi comportamentali
6.3 Terapia
comportamentale
6.3.1 Stereotipi comportamentali
6.3.2 Concetto comportamentale empirico
6.3.3 Allenamento all¹autonomia
6.4 Autotrattamento
³kinesiologico² delle fobie e dipendenze
Psiche:
³farfalla², anima Terapia:
cura
Con i tempi
che corrono e negli ambienti ³alternativi², ³complementari², ³olistici²,
³naturali² c¹è tanto abuso del termine ³terapia², in quanto, essendo ³la
salute² diventata di moda, pregio e mercato, viene definito un po¹ tutto con il
termine ³terapia², anche quando si tratta chiaramente di:
- Dietetica.
- Stile di vita.
- Igiene.
- Prevenzione.
- Riabilitazione.
- Pedagogia.
- Ideologia..
- Sviluppo mentale e spirituale.
-
Nel
seguente testo, il termine ³terapia² è inteso come ³cura², cioè un insieme di
misure diverse per poter affrontare dei ³disturbi² o delle malattie.
Evidentemente ciò che concerne gli argomenti sopraelencati, esse possono essere
degli ³ingredienti² per una terapia, ma non sono per questo motivo delle
³terapie² (come per es. la pasta, il brodo, il sale e l¹acqua possono essere
degli ingredienti in una minestra ma non per questo sono la minestra).
Con il
termine psiche intendo:
- Funzioni gestionali, dispositive e
regolative individuali,
- tra un organismo autonomo, vivente in
stati modulati,
- eventuali altri organismi altrettanto
vacillanti
- in un ambiente naturale e culturale
variabile.
Sensazioni, emozioni, intento, incentivo, memoria
Secondo
questa definizione, anche un microrganismo autonomo dispone di un¹anima, perché
riesce ad adattarsi, e a muoversi alla perfezione nel suo contesto ³ambientale²
e ³sociale² e sicuramente dispone anche di funzioni con delle ³emozioni
primitive² e ³l¹intento, la spinta² perché si avvicina, cerca, attacca gli
stimoli ³promettenti² mentre sfugge, evita, si allontana dagli stimoli
³ricattanti². Cosa sia la sua ³memoria², che per deduzione deve anche esserci,
perché altrimenti come potrebbe reagire in modo coerente agli stimoli uguali,
non è ancora molto chiaro. Se fosse anche ³intelligente² ciò dipenderebbe dalla
definizione di intelligenza.
Individui, società, movimento, cognizione,
comunicazione
Andando
avanti nell¹evoluzione e ciò fino a un certo punto, suddette doti primitive di
organismi aumentano con la complessità degli organismi. Quelli ³stabili² come
le piante non devono evolvere delle proprietà gestionali di movimento, ma
piuttosto di difesa e adattamento al territorio (non possono sfuggire) mentre
altri come certi insetti o pesci evolvono ad altissimi livelli delle capacità
³sociali² (e quindi comunicativamente attive e passive, con un ruolo, un rango
e una gerarchia) delle relazionali bilaterali (di corteggiamento), perché hanno
delle divisioni di lavoro molto differenziate e vivono in grandissime comunità.
Tutti i rami evolutivi seguenti a questi, perfezionano l¹asse
sensoriale-cognitivo specializzato per l¹ambiente e il grado di
socializzazione.
Dislocazione, apprendimento, riflessione, coscienza allerta
Altri rami evolutivi come negli uccelli o nei
mammiferi, per capacità la dislocazione o la socializzazione evolvono
sorprendenti capacità di apprendimento, il che richiede doti di memoria e
cognizione elevate e almeno tracce di ³riflessione² (paragone, deduzione,
induzione, conclusione, giudizio) e forse anche di ³coscienza² (di se stesso
e/o ³allerta²). Il gioco nella loro infanzia è la scuola dove apprendono queste
cose e poi viene mantenuto come esercizio, distrazione e cura di relazioni
bilaterali e sociali, che servono anche alla conferma o al riorientamento di
ruoli, ranghi, alleanze, inimicizie
Arrivando
ai nostri parenti, primati e mammiferi oceanici, vediamo che si evolvono
ulteriormente le capacità comunicative (pare anche per distrazione o estetica)
presso gli uni e gli altri si notano anche delle prime tracce d¹uso di
attrezzi. Per gestire tutto questo occorrono delle capacità psichiche
differenziate e altamente sviluppate, anche ³intelligenza². È anche evidente
che delle ambivalenze ³biologiche² non solo sono ³normali² ma la ³psiche
biologica² è fatta appositamente per gestirle e anche bene. Dove ciò funziona
male o non funziona del tutto (troppi sbagli gestionali), è difficile che
continui la procreazione.
Attrezzature, cultura, lingua, astrazione, etica
Cosa ci
distingue dai nostri parenti:
- La genesi parla del frutto della
discriminazione del ³bene² e del ³male² (uno dall¹albero della conoscenza). La
tradizione mistica chassidica ebraica vi aggiunge che ³l¹albero della vita² e
³l¹albero della conoscenza² hanno le stesse radici. Questo approccio aggiunge
una componente ³etica² ai sottili meccanismi relazionali e sociali ³biologici²
ed è evidentemente un elemento culturale.
- Una differenziazione del genere è
pensabile solo su un retroscena linguistico con alti parametri di astrazioni
terminologiche, sintattiche e semantiche nonché di deduzioni, induzioni e
concetti, di giudizi, sentenze e verdetti. Il racconto del vecchio testamento
li illustra tutti. Questa parte ³linguistica² è senz¹altro una componente
evoluta della cultura che si spinge oltre ai ³primitivi meccanismi comunicativi
e informatici² e permette ulteriori sfumature relazionali e sociali sia
espressive sia impressive.
1.0 Natura e cultura
FREUD
ha descritto quasi cent¹anni fa e a quanto ne sappia io per la prima volta, il
complicato funzionamento della psiche umana come il risultato di ambivalenze
tra la ³natura² e la ³cultura umana² nel suo saggio: ³Das Unbehagen in der
Kultur² (Il disagio nella cultura). È rimasto un testo che è assolutamente da
leggere anche nei nostri tempi.
Vale
la pena come introduzione al tema di soffermarsi un attimo sulla definizione
dei due termini contrastanti: viene definito come ³natura² tutto quello che è
la creazione ³non umana² mentre la ³cultura² viene definita ³coltivazione,
trasformazione e creazione umana² sia materiale che emotiva o mentale.
Questa
definizione (per deviare un attimo nella tradizione zingaresca e dei mistici
ebraici) assomiglia tanto al significato delle due carte dei tarocchi ³XIII La
morte 40² e ³XV La torre 60² che, sintetizzando il discorso significano (sempre
con criterio di inizio e fine, quindi includendo il tempo, quindi una sequenza
e non un ³insiemistica²):
- XIII
La morte 40 (mem): l¹evoluzione di creazioni (e creature) ³procreate² tra la
nascita e la morte.
- XV La torre 60 (ajin): il percorso di
creazioni ³costruzioni umane² tra la produzione, la distruzione e lo
svanimento.
Vengono
trattati i seguenti temi:
Ci
si chiede cosa nel contesto è naturale. Non ho usato questo termine, ma diversi
altri per designarne il contrasto o l¹ambivalenza con la ³cultura²:
- Biologico: seguendo dei meccanismi
naturali più che culturali.
- Somatico, corporeo, organico: riferendosi
più alla costruzione e al funzionamento del corpo che a dei criteri culturali.
- Metabolico, fisiologico: seguendo più dei
meccanismi funzionali ³naturali² che controllabili culturalmente.
- Vegetativo: dei processi gestionali e
regolativi più naturali che culturalmente controllabili.
Tutto
questo non vuol dire che sia ³naturale² nel senso di essere ³privo di influenze
culturali², ma indica che è in contrasto o in ambivalenza con essi. Vuol dire
solo che, in un discorso ³psichico² viene coinvolta una componente biologica e
di natura altrettanto come una componente ³sociale² e/o ³culturale².
1.2 Socialità
Il
concetto di ³sociale² e quello di ³culturale² spesso non sono ben distinti e
forse non riesco a esporli in questo testo. Quindi, sarebbe opportuno chiarire
almeno l¹intenzione.
Sociale
indica ³associato² ed è una proprietà primordialmente ³naturale²: la capacità
dei singoli viventi di associarsi ad altri ³individui² o gruppi per un
principio ³economico².
Non
tutti fanno tutto, ma:
- Compiti, responsabilità e competenze
vengono ripartite,
- in maniera che ³il funzionamento assieme²
sia più efficace e con meno spese² per ogni singolo.
- Questa ³organizzazione² richiede
evidentemente che il funzionamento complessivo sia coordinato e correlato in
qualche maniera e richiede delle capacità integrative a livello di controllo,
regolazione, disposizione, gestione
Gerarchia
si chiama la struttura dei compiti, responsabilità e competenze in un contesto
della ³divisione dei compiti² riferita alle attività:
- Gestionali (produce poco, maneggia
tanto).
- Dispositive (produce qualcosa, maneggia
parecchio).
- Operative (produce tanto, maneggia poco).
Mia
moglie lo definisce come un ³Teamwork²: Io work, tu team.
L¹individuo
e la specie non hanno necessariamente gli stessi interessi. La sopravivenza
della specie o l¹interesse del gerarchicamente superiore può essere in
contrasto agli interessi individuali.
Il grado e l¹ambito dall¹autonomia individuale verso i
doveri sociali correlati a determinate funzioni gerarchiche, determinano
essenzialmente la struttura e il funzionamento di una ³società².
Nelle
società umane le relative dinamiche possono essere complesse. Come
³barzelletta² si diceva nella Berlino settecentesca, che lo Stato della
Borussia era comandato dal cagnolino della Signora Quantz, perché il cagnolino
faceva filare la Signora, la Signora suo marito, il maestro Quantz in funzione delle sue lune, questo (come
insegnante di flauto e direttore della reale orchestra) faceva filare il suo
discepolo Federico il Grande, e quest¹ultimo la Borussia. La cultura pare che
permetta delle sfumature che in uno stato di termiti è sconosciuto.
1.3 Cultura
GOETHE
ha espresso bene il contenuto e i nessi culturali, anche se la deduzione e la
conclusione è discutibile e il consiglio mi sembra arrogante:
³Wer
Wissenschaft und Kunst besitzt der hat auch Religion. Wer diese beiden nicht
besitzt, der habe Religion!²
(Colui
che conosce la scienza e l¹arte è anche religioso. Chi è privo dei due, che
abbia almeno la religione!).
Cita
come elementi culturali individuali la scienza, l¹arte (artigianato) e la
religione.
In
un testo da leggere di FREUD: ³Das Unbehagen in der Kultur² (Il disagio nella
cultura) viene esposta in modo esemplare l¹ambivalenza tra:
- Convenzioni, costrizioni, abitudini,
attitudini, restrizioni culturali e
- necessità, esigenze, bisogni, desideri,
³naturali² (cioè vitali).
FREUD
elenca sotto ³culturale² tutte le attività (espressioni) e sentimenti
(impressioni) che sono esclusivi per la specie umana (e non solo ³quelle
nobili²), quindi tutte le caratteristiche delle civilizzazioni, politiche,
economiche, professionali, familiari, di distrazione o interesse individuale.
Egli
interpreta come conseguenza quei ³disturbi psichici individuali² come:
- Gli effetti di ambivalenza tra la ³natura
individuale² e la ³cultura sociale².
- Ciò a scapito della ³natura² (vitale) e
dell¹ingegnosità di ogni singolo.
- Quella capacità di ³sublimare degli
impulsi vegetativi² trasformandole in ³opere, comportamenti o sentimenti
coltivati² cioè socialmente accettabili.
Quello
di Freud è stato un approccio geniale, anche se cento anni di distanza hanno
relativizzato parecchi dettagli. In certi tratti mi sembra però una visione
³triste², se penso all¹entusiasmo e alla soddisfazione che mi danno tante delle
mie imprese anche ³futili², o ³scomode². Ma forse ho interpretato
unilateralmente il suo punto di vista o sono semplicemente più fortunato di
lui, o più superficiale, perché non m¹interessa esclusivamente ³il fondo del
sacco² ma anche i dolciumi che si trovano a galla. Probabilmente sono meno
analitico e più empirico di lui.
Il
titolo di una famosa trasmissione televisiva della BBC tratta dei ³Fenomeni
sovrannaturali² che sono tutti naturali, perché sono delle capacità innate
nelle bestie, sorprendenti per l¹osservatore umano che ha difficoltà a
spiegarsele, strane per la sua povera mente. Si tratta quindi di capacità
³sovrumane², difficilmente accessibili alla nostra limitatissima mente e quindi
classificate come ³miracolose².
In
questo senso sono ³naturali² e solo ³sovra-umane².
Per
me, l¹autogestione di ogni singola cellula, dei 100 miliardi di cui è composto
il mio organismo è più sorprendente, misteriosa, miracolosa e mistica di tutto
il resto. Non riesco poi a paragonare queste mie scarse capacità mentali alla
illimitata e neanche percepibile ricchezza della realtà. Questo in me provoca anzitutto
sentimenti di rispetto per la realtà ³naturale² (in maggior parte non
percepita) e per la creatura. Provo anche dei sentimenti di ³inferiorità²,
impulsi di curiosità ed entusiasmo nei loro confronti.
Per
quanto concerne ³l¹opera umana² ho già molto meno rispetto. Ammiro un muretto
ben fatto, perché mi parla dell¹ingegnosità culturale dell¹uomo che l¹ha
concepito e realizzato, ma non rimango impressionato da uno stupido discorso
spirituale senza arte né parte. Voglio bene a parecchie persone per le loro
debolezze umane e provo rispetto per altri per le loro virtù. Ma anche questi
sono solo poveri giudizi umani. Mi diverto ogni tanto con dei ragionamenti
fatti a regola d¹arte e mi commuovono espressioni umane autentiche di ogni tipo
(anche religiose) e quanto mi fanno schifo le opere malfatte nonché le mosse
bugiarde.
È
evidente che arte (artigianato, industria, sport), scienza (ricerca,
istruzione, applicazione) e ³spiritualitಠ(religione, ideologia, dottrina)
sono i campi d¹impiego culturali (in maniera crescente) più distanti dalla
³natura vegetativa² umana. Se non si ritengono delle ³sublimazioni sostitutive²
a degli impulsi vegetativi; chi li pratica si trova spesso in un¹ambivalenza
con questi ultimi e deve curare anche loro per raggiungere un equilibrio.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
1.3.2 Cultura
e interessi individuali
1.3.1 Cultura
sociale
Rendiamoci
conto che:
Fantasticando sulla libera natura
intendiamo normalmente i suoi lati coltivati: un bosco curato con dei sentieri,
dei prati coltivati, il fiume arginato sono il frutto di un centinaio di anni
di cultura agricola.
Quando la natura sfugge al
nostro controllo con delle tempeste, dei fuochi, delle valanghe, delle frane,
delle buzze, delle inondazioni ne siamo più intimoriti che entusiasti.
I fiori, i legumi, i cereali, la frutta
(anche se vengono prodotti sotto delle condizioni strettamente biologiche) sono
³bastardati². Se tutto crescesse in modo ³selvatico², nessuno oserebbe
consumarli.
Le nostre case, istallazioni idrauliche,
elettriche, termiche, canalizzazioni, fognature e vie di comunicazione come il
telefono, la radio, la televisione, l¹informatica sono prodotti di altissima
cultura che chiamiamo poi civilizzazione.
Le
infrastrutture di trasporto, approvvigionamento, smaltimento, comunicazione,
e i relativi veicoli, aggeggi e istallazioni sono di altissimo livello tecnico,
civilizzato, culturale.
La produzione degli alimenti, dei
vestiti, delle scarpe e dei beni di ogni genere, delle infrastrutture e
informazioni, lo scambio di soldi, merci, prestazioni e relativi servizi è
altamente industrializzato, tecnicizzato, civilizzato, culturale.
Idem è per i prodotti, le prestazioni, i
servizi sanitari, igienici, cosmetici, medici, terapeutici.
Idem é per i prodotti, le prestazioni, i
servizi che servono al ricupero, la distrazione, lo svago e il riposo come il
turismo, i passatempi, lo sport, i film, il teatro, la televisione, la radio, i
locali di ristoro.
Idem è per la scienza e l¹istruzione con
tutte le relative strutture, le infrastrutture, i servizi e i mezzi di
comunicazione.
Idem è per l¹arte, l¹artigianato con
tutte le relative strutture, le infrastrutture, i servizi e i mezzi di
comunicazione.
Idem è per la ³religione²
(fondamentalista, ecumenica, multiculturale, polietica, eclettica,
neoreligiosa, esoterica, qualunquista), ideologia, politica, ³spiritualitಠcon
tutte le relative strutture, infrastrutture, servizi e mezzi di comunicazione.
Idem è per la gestione e
l¹amministrazione privata e pubblica con tutte le relative strutture,
infrastrutture, servizi e mezzi di comunicazione.
1.3.2 Cultura e
interessi individuali
Pare
che la cultura umana abbia soprattutto delle fonti individuali più di quelle
relazionali e sociali:
- Nell¹uso
dei colori e degli strumenti a scopo di ornare il proprio corpo e l¹abitazione,
- nel farsi gli abiti e le scarpe oltre
alla loro funzione e
- di estetica figurativa, linguistica
(racconto, poesia), musicale (voce, ritmi, strumenti) e di movimento (ballo),
elementi che si ritrovano anche nelle prime testimonianze della cultura umana
cosiddetta ³primitiva². Tutto questo è altamente ³sviluppato² dalla creatività
umana, probabilmente prima dello sviluppo delle forme sociali ed evolute nonché
differenziate.
È
pensabile che l¹esperienza della riflessione e della memoria ³astratta², non
più riferita all¹immediatamente percepibile e le capacità di premeditazione con
una dinamica intrinseca abbiano creato la curiosità, le domande e le risposte
ipotetiche che integravano da una parte il singolo ³pensatore² nel suo contesto
sociale e naturale, ma nel medesimo tempo lo identificavano anche come
individuo diverso dagli altri. L¹esperienza di sentirsi non solo fautore di
quelle proprie mosse (e delle altrui), ma di essere anche soggetto di impulsi
altrui, ha forse indotto sentimenti e idee relazionali ³spirituali² e
filosofiche, che portate a livello di discorso relazionale e consultazione
sociale divennero magiche, e nel corso delle generazioni, ³religiose² del tipo
³animistiche² con dei rituali, delle credenze, immaginazioni, idee e poi con
dei culti.
La
³cultura individuale² non consiste nella contrapposizione ³antietica² alla
natura, ma nel vivere tutti gli ³impulsi naturali² in modo coltivato, cioè, con
arricchimento estetico ed etico:
- Nutrirsi nelle forme del mangiare e del
bere.
- Copulare in forme erotiche e rispettose
per la/il compagna/o.
- Dormire nei contesti scelti.
- Abitare in un ambiente piacevole.
- Relazioni bilaterali colte.
- Relazioni sociali sopportabili.
- Igiene, abbigliamento e cosmetica
piacevole.
- Operare a regola d¹arte.
- Distrarsi e svagarsi esteticamente.
- Non disturbare più di tanto e non
lasciarsi disturbare, né da telefoni, né da idee, né da proposte.
-
Come
negli altri settori nell¹ambito della ³ripartizione dei compiti² e della
specializzazione individuale sono intuibili anche delle funzioni in merito ai
rituali, alla tradizione, alla guarigione,
1.3.3 Spiritualità
La
spiritualità è la dote umana di muoversi in costrutti mentali astratti, non
impedita da fatti concreti o persino in contrasto con essi, talvolta cercando
in stati d¹animo ³mutati² delle visioni oltre alle realtà percepibili tramite i
sensi. Al posto dei fatti vengono stipulate delle ipotetiche ³verità²,
³credenze², ³convinzioni², dei dogmi e/o esperienze più o meno eterne e immutabili.
Questi costrutti servono per:
- Interpretare e poi organizzare,
strutturare, impostare, formare, creare:
- provenienza, senso e indirizzo
dell¹esistenza umana,
- comportamento, relazioni e regole sociali
dei singoli, gruppi e società,
- stipulare valori e la loro gerarchia sia
individuali sia sociali,
- giustificare sentimenti, intenzioni e
mosse.
Innumerevoli
sono i relativi tentativi animistici, ³pagani², magici, giudei, cristiani,
islamici, induistici, buddistici, taoistici, fino al qualunquismo esoterico
contemporaneo, che non dispone neanche più di ³un costrutto base² ma solo di un
guazzabuglio di elementi incoerenti e incompatibili con tutti quelli precedenti
e un po¹ di credenze di modernismo e postmodernismo; sacrilegio per ciascuno
dei singoli. L¹unico elemento rimasto è l¹atteggiamento inquisitorio verso
tutti quelli che non la pensano allo stesso modo. Così diventano quasi tutti
³bisognosi di spiritualità².
Spesso
sono poi le stesse persone che se ne intendono più dei diritti del loro cane
che della ³Convenzione dei diritti umani², che non sarà molto spirituale, ma
potrebbe essere almeno una base d¹accordo maggioritario sulle minime regole di
convivenza umana, non facile da raggiungere come concetto e ideale, ma per me
condizione ³sine qua non² di ogni ³diritto alla spiritualità².
Non
ho niente contro una ³vita spirituale² (neanche neoreligiosa), basta che sia e
rimanga privata e intima. Portata a livello sociale mi sembra più un ³terrore
psichico², normalmente poi da quelle persone che di ³spiritualitಠhanno
all¹incirca l¹idea che ha una mucca della contabilità. Con tutto il rispetto
che ho personalmente verso le grandi opere e i grandi pensatori di tanti tempi
e culture, quello che spesso si sente dire in merito, lo percepisco come un dispetto
e una bestemmia.
Beato
chi:
- Non ha una ³necessità mentale² né di
³reincarnazione², né di ³risurrezione², né di ³redenzione².
- Non si lascia determinare da ³karma² o
³kismet² e
- non deve sentirsi onni(im)potente
³fautore del proprio destino², ma
- riesce a vivere l¹incertezza sulla
valutazione del passato e di controllo del futuro, senza tanti scrupoli per
l¹uno e con poca ansia verso l¹altro
- a crearsi ogni tanto condizioni
soddisfacenti (con grazia e fortuna non meritate, ma accadute) e
- ad evitare le peggiori condizioni
frustranti (disgrazia e sfortuna) con più fortuna che creanza,
in
modo, che dopo tutti questi ³compiti fatti² (e non al loro posto) e se sente la
curiosità, la voglia o il piacere, possa dedicarsi come uno svago, curiosità o
per fede e con serenità alla preghiera, contemplazione, meditazione e allo
studio delle grandi opere spirituali.
Tanti
tentativi spirituali (o tutti) mirano a ³superare² la natura (umana), di avere
accesso a ³mondi superiori², di raggiungere l¹³illuminazione divina², il
sostegno di ³forze superiori² e così via. Da tempi remoti si insegnano a questo
scopo, in parallelo alle relative dottrine, delle tecniche e degli esercizi che
alterano gli stati d¹animo come dietetiche, respiratorie, movimentali, di impassibilità,
delle regole comportamentali, ascetiche, l¹uso di sostanze psico attive e
tant¹altro. Queste forme ³pedagogiche² sociopsicosomatiche alterano
notevolmente l¹economia psichica e richiedono salute e stabilità sia fisica che
psichica. Chi le propaga come ³alternative terapeutiche² è irresponsabile se
non criminale: le cliniche psichiatriche sono piene di pazienti nei quali delle
³esperienze spirituali² hanno modificato ³gli stati d¹animo² in maniera
pericolosissima.
Degli
studi epidemiologici dimostrano che le persone con una fede fondata dispongono
di capacità autoregolative sociopsicosomatiche elevate. Ma sicuramente la loro
fede non l¹hanno acquistata da un qualche santone come terapia alternativa
spirituale.
1.4 Anima e psiche
Interpretando
la ³psiche² come un aggregato di gestione e regolazione tra un organismo e il
suo ambiente, rispettivamente tra questo organismo e altri organismi associati
si pongono da subito una serie di domande non solo relazionali ma di funzionamento
dell¹organismo, in quanto:
- La sua dipendenza dall¹ambiente e dagli
³associati² è organizzata?
- L¹integrazione delle vicissitudini e la
trasformazione in comportamenti funziona?
- Il suo intervento sull¹ambiente e gli
³associati² è organizzato?
Come
compito gestionale si tratta di organizzare tanti elementi sia
contemporaneamente (insiemistico) che in modo processuale (sequenziale). Per
questo si arriva al seguente discorso sulla gestione (correlazione e
coordinazione di insiemi e sequenze).
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
1.4.2 Coordinazione,
correlazione, disposizione
1.4.3 Insiemi
e sequenze sensoriali
1.4.4 Gestione
psichica di insiemi e sequenze
1.4.5 Insiemi
e sequenze comportamentali
1.4.6 Implicazioni terapeutiche
1.4.1 Sequenze e
insiemi
Vi
sembrerà strano trattare ³spazio² e ³tempo² e la loro coordinazione in un
trattato di psicoterapia. Personalmente farei molta fatica a spiegarmi in modo
plausibile tanti fenomeni psichici senza disporre di questo strumento. La
letteratura ³psichica² anche più remota si batte spesso con questa ambivalenza.
Anche Freud in un trattato noto spiega ³il ricordo dell¹anima² in un¹immagine
geniale, dicendo che l¹anima non ha tempo: come se nel medesimo quadro di Roma
ci fossero contemporaneamente e intatti tutti gli edifici mai costruiti.
Quando
vi parlo, il filo del discorso si evolve come una linea nel tempo, andando
avanti con un ordine sequenziale di fonemi con un prima e un dopo di parole e
frasi.
Quando
guardate un dipinto, l¹ordine che vi rivela la sua ³intenzione² invece, è
basato su una disposizione insiemistica di macchie e colori ordinati secondo
dei criteri come sopra-sotto, la destra-sinistra, il davanti-dietro,
contenuto-separato, comune-differenziato,
Quando
ascoltiamo un brano d¹orchestra ci sono tutti e due gli ordini:
- La sequenza della melodia dei singoli
strumenti e
- il suono complessivo ³momentaneo come un
insieme di timbri, armonie e dissonanze a un determinato volume (ponderanza) in
un momento.
La
duplice disposizione ³sequenziale² e ³insiemistica² dei singoli strumenti (che
partecipano o tacciono, si ³uniscono² e si ³separano² in continuazione) è
coordinata (sempre nel caso del brano musicale) secondo delle ³regole²:
- ³Armoniche² come intervalli di suoni
contemporanei (accordi che si alterano nel tempo).
- Contrappuntistiche (intreccio di temi e
melodie).
- Ritmiche (accenti e ripetizioni nel
tempo).
- ³Tempistiche² (velocità di progresso
melodico o ritmico).
- ³Volumetriche² (volume di singoli
strumenti o voci e complessivo).
1.4.2 Coordinazione,
correlazione, disposizione
Questa
³insiemistica dinamica² coordinata crea una dimensione oltre all¹insieme, ma
anche oltre alla sequenza, è la correlazione stessa come ³terza qualità², (non
deducibile né dalla sequenza né dall¹assieme); la disposizione nel ³passare del
tempo²:
- ³Insiemi² di elementi scelti
(contemporaneamente diversi, da una scorta di ³suoni², ³strumenti² e ³volumi²
da un pozzo ³memorativo associativo insiemistico²) disposti come un assieme
³armonico² (tensione, distensione).
- ³Sequenze² di ³insiemi²
(contemporaneamente diversi ³temi² e ³melodie², da una scorta di sequenze,
ripetizioni, ritornelli, filastrocche, ³circoli², per diversi strumenti, da un
pozzo ³memorativo sequenziale²).
- Gestiti
secondo dei criteri di dinamica (contemporaneamente diversi, da una scorta di
velocità, ripetizione e accento per diversi strumenti, da un pozzo ³memorativo
ritmico²).
1.4.3 Insiemi e sequenze
sensoriali
Vi
sembra complesso? Anche a me. Ma mi è sembrata un¹analogia maneggevole e semplicistica
per ³la fisiologia dell¹anima² (funzionamento). In realtà ha tante dimensioni
in più:
- La visiva (come un film), l¹olfattiva (la
sequenza di odori in un locale per buongustai), la gustativa (le portate e gli
ingredienti di un pasto), la ³tattile² (percezioni cutanee) della camicia di
seta sulla pelle e le mutande che stringono, l¹equilibrio dopo una bottiglia di
un eccellente vino rosso.
- Diverse altre più o meno coscienti di
autopercezione e stimoli interni come il dolore, la fame,
- Emotive fluttuanti in un momentaneo stato
d¹animo.
Tutte
si aggiungono a quelle ³acustiche² e sono tutte da coordinare, correlare e
gestire (integrare) per poi finire in un comportamento (gesti, mimica,
movimenti, discorso sensato). Questo per me è l¹opera dell¹anima che oggigiorno
si chiama psiche.
È
evidente che anche una bestia deve gestire tanto di questo (non la forchetta e
il coltello) e lo fa spesso meglio di me; la differenza è che non si fa tanti
scrupoli sofisticati. L¹usignolo giù alla ³Maggia² davanti alla finestra della
mia camera da letto da bravo beffeggiatore canta indistintamente il segnale
della mia sveglia elettrica (alle due di mattina) come un tema di una sonata di
Mozart e non si lascia impressionare dal mio commento.
1.4.4 Gestione psichica
di insiemi e sequenze
Tantissimi
fenomeni psichici si riescono a intuire con un modello che non separa solo
l¹aspetto sensoriale, l¹integrazione correlata regolativa e l¹attivazione (con
relativi approvvigionamenti, consumi e smaltimenti) ma anche la parte
gestionale psichica: insiemistica/sequenziale/coordinativa:
- Il maniacale logorreico eccitato,
inondato di ³associazioni² non controllabili con l¹inizio di sempre nuovi temi
(o anche nel mio caso, quando sono sbronzo e qualcuno mi provoca).
- La ripetitiva filastrocca monotona a
ritornello di una debole melodia depressiva (la mattina dopo la sbronza con un
magone).
- L¹intrusione di un tema prepotente
dissociato (in tutti i brani del resto anche ben gestiti), di idee coatte
quando assolutamente voglio qualcosa.
- La persecuzione di un paranoico
disturbato durante il suo ³concerto² dalla ostinata intrusione di un avversario
musicista interno.
- L¹ostinato bisogno di uno, con le idee
prevalenti, di sottoporre a tutti la sua ultima melodia trovata e di invitarli
a suonarla anche loro.
- La cacofonia sregolata nel panico e
l¹arresto totale momentaneo di chi è rimasto di stucco.
- Le esigenze sovraumane in uno
schizofrenico di dover contemporaneamente vivere e commentare due film diversi.
- Le capacità memorative
insiemistiche/associative/emotive (corticale destra), quelle
sequenziali/proceduralmentali (corticale sinistra) e quelle
coordinative/correlative/dinamiche nelle parti di gestione neurovegetative e
del ponte.
- La corteccia cerebrale e il sistema limbico
come antipodi di sequenze (limbus) e di insiemi (cortex) correlati per il resto
dal sistema nervoso centrale (sensoriale, vegetativo, motorio).
1.4.5 Insiemi e sequenze
comportamentali
La
gestione psichica, se tutto va bene, fornisce come ³risultato² un intento, un
volere, una volontà che deve essere trasformato da ultimo in un ³comportamento²
(attivo, reattivo, di appetenza, finalizzato, ).
Questo
dipende essenzialmente:
- Dalla spinta o incentivo momentaneo per
avviare l¹intento.
- Dalle risorse attualmente disponibili per
concretizzare l¹intento.
- Dall¹accoglienza/resistenza di associati,
avversari e ambiente alla mossa.
1.4.6 Implicazioni
terapeutiche
Sforzando
un po¹ l¹analogia dell¹orchestra mi sento spesso il direttore d¹orchestra,
ponendomi molte domande:
- Per quale pubblico suono e qual¹è il
concerto.
- Quale repertorio ho da offrire.
- Quanti concerti e quante prove faccio.
- Che musicisti, con quali strumenti ho a
disposizione e che capacità hanno.
- Che rapporto ho con il pubblico,
l¹impresario, le autorità, i critici.
- Quanto chiedo ai miei musicisti e quanta
autonomia, distrazione, tempo contem-plativo lascio loro.
- Cosa faccio per compensarli,
gratificarli, stimolarli, sanzionarli.
- Come mi comporto in situazioni di
contrasto e ambivalenza o se uno è di malumore.
-
Le
stesse questioni me le pongo anch¹io e cerco di scoprirle con il mio cliente.
Essendo anche lui direttore della sua orchestra (o squadra o officina) ci
troviamo abbastanza facilmente come ³colleghi² e questa è una buona base di
collaborazione accessibile a ognuno di noi senza alcuna formazione sofisticata.
2.0 Sociologia
La
³sociologia² tratta le relazioni tra gli esseri viventi nel loro contesto
naturale. Si può trattare di piante, di animali o di esseri umani nei relativi
contesti cosiddetti³naturali².
Vengono
trattati i seguenti temi:
2.2 Temi e argomenti della sociologia
umana
2.3 Psiche
umana nel contesto sociale e ambientale
La
sociologia umana tratta le relazioni tra:
- Individui, coppie, famiglie.
- Stirpi, gruppi, società.
- Etnie, culture e nazioni.
Nei
relativi contesti cosiddetti ³naturali².
Visto
che queste relazioni possono essere di tanti tipi e sfumature, le scienze
sociali hanno tante specializzazioni come la politica, il diritto, l¹economia
pubblica e quella privata, la religione,
La
sociologia nel senso stretto della parola tratta soprattutto il coinvolgimento
dell¹individuo in queste molteplici relazioni, dalle più formalizzate e
gerarchizzate alle più informali, emotive e di interessi. In pratica definisce
l¹individuo dal punto di vista della sua integrazione nei diversi contesti
relazionali.
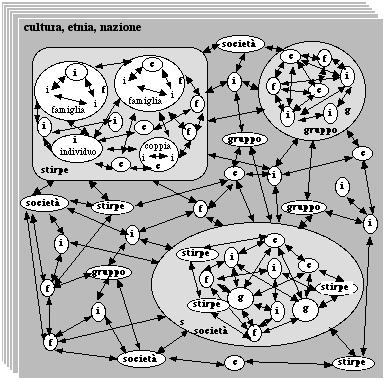
2.2 Temi e argomenti della sociologia umana
Può
sembrare strano occuparsi nell¹ambito di un tema ³psichico² e ³terapeutico² di
fatti sociali. In realtà non lo è perché i nessi sono molteplici. Fra l¹altro,
la ³psicologia² ufficiale è molto spesso non solo individualistica ma
relazionale e anche sociale. Un addetto servizio pubblico nel Canton Ticino si
chiama con giusta ragione ³Servizio psicosociale².
- Essendo l¹uomo non (solo) una ³bestia
solitaria² ma anche ³sociale² (come tanti altri animali) conviene tener conto
dei ³fabbisogni sociali e relazionali primitivi² oltre che a quelli
³vegetativi², di sopravivenza individuale e di specie nei determinati ambienti
e contesti naturali. I risultanti e le ³pulsioni² spesso ambivalenti richiedono
una notevole ³capacità di autogestione². Fino a questo punto, la sociologia è
³naturale² e potrebbe essere anche la ³sociologia di un branco di cani².
A
partire da qui, ³la sociologia umana² diventa ³civilizzata, culturale². Spesso
si dimentica che questo fatto non è una ³sostituzione² ma, o, ³un ampliamento²
o ³una trasformazione formale² oppure ambedue, che non rende superfluo il
substrato primitivo, anzi.
- Poiché questi ³impulsi primitivi² sono
stati elaborati a livelli di civilizzazione e di cultura sia individuali che
relazionali (dei quali siamo fieri), non solo è aumentata l¹esigenza di
autogestione psichica di certe ambivalenze cresciute esponenzialmente, ma anche
di richieste di scelta, coordinazione e disposizione sia individuale che
relazionale.
- L¹esperienza (culturale) che il benestare
dei ³gruppi² non si basa prevalentemente
- né sul ³diritto del più
rozzo²,
- né sul dispotismo del più
³pazzo² (libertà),
- né sulla dittatura della
maggioranza (uguaglianza),
ha
portato le nostre società civilizzate a equilibri delicatissimi tra:
- Solidarietà con il debole e
- responsabilità individuale per se stesso
e
- il funzionamento sociale (fratellanza)
- che stipula nuove ambivalenze individuali
da gestire, ma anzitutto impegni e costi di solidarietà, specialmente se la
fratellanza volontaria diventa assicurazione sociale obbligatoria.
Per
l¹operatore nel settore ³psicoterapeutico² diventa quindi indispensabile
l¹istruirsi almeno superficialmente nel settore ³sociologico². Per illustrare i
temi e per fare una proposta concreta, di seguito l¹indice di un metodo
scolastico di sociologia:
BARLEY,
Delbert: Grundzüge und Probleme der Soziologie, Luchterhand 1975
Elementi
di sociologia
Basi
della società
Geografia
Biologia
Uomo
e bestia
L¹apertura
umana
Trasformazione
di esigenze biologiche
Tensione
esistenziale
Struttura
della società
Processo
di strutturazione
I
ruoli e la loro ripartizione
Ruolo
sociale
Sistemi
di ripartizione
Incertezze
dei ruoli nelle trasformazioni sociali
Disturbi dei ruoli
Norme
sociali
Meccanismi
di controllo, sanzioni, privilegi
Ruolo
e posizione sociale
Posizione
come aspetto di rango (del ruolo)
Posizione
come prestigio nell¹ambiente
Autorità
e potere istitutionalizzato
Forme
e interazioni di gruppi
Gruppo
Relazioni
tra gruppi e obiettivi di gruppi
Cultura
come termine sociologico
Cultura
e delimitazioni
Etnocentrismo
Stratificazione
sociale
Stratificazione
e controllo
Stratificazione
e mobilità
Teorie
delle strutture di potere
Domande
critiche al potere
Personalità
come organismo socializzato
Forze
formative
Esclusività
e tipo
Fattori
formativi
Società
e ³proprio io²
Ruolo
e identità
L¹alternativa
di Freud
Omogeneità
e scissione della personalità
Valori
e orientamento
Terminologia
Classi
di valori
Valori
astratti della società
Norme
dirette del gruppo
L¹autoimmagine
ideale
Proprietà
organiche e valori indirizzanti (carattere)
Orientamento
di ³principi² (di concetto)
Orientamento
³situativo² (di adattamento)
Conflittualità
della personalità
Conflittualità
dei valori e d¹³impulsi²
Frustrazioni
e la loro gestione
Reazioni
ai conflitti interni
Privazione
e anomia
La
famiglia
Istituzione
della società
La
famiglia in un mondo che cambia
Tecnica,
burocrazia, divisione del lavoro
Ripartizione
lavorativa e relazioni sociali
Burocrazia
Società
di massa
Ripartizione
dell¹ordine gerarchico
Produzione
e consumo di massa
Fattore
di calcolo
Massa
come destino
Perdita
delle strutture comunitarie
Fenomeni
della popolazione
Terminologia
Struttura
di norme
Norme
sociali come conseguenza della struttura della popolazione
Quota
di nascita differenziale
Cambiamento
sociale
Cause
Evoluzione
obiettivistica
Problemi
sociali
Fenomeni
del deterioramento sociale
2.3 Psiche umana nel contesto sociale e ambientale
³Psiche²
è per me una funzione (auto)gestionale altamente dinamica tra tanti bisogni e
desideri ambivalenti, contrastanti e variabili, sia biologici che culturali, di
una persona con una propria storia, vivente in un determinato e momentaneo
contesto naturale e culturale (sociorelazionale).
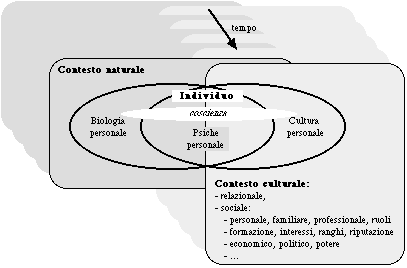
3.0 Psicologia
La
psicologia è una scienza empirica (di esperienza) che si occupa del
funzionamento dei processi gestionali degli individui umani nei loro contesti
relazionali, sociali e ambientali.
Come
testo base per questo capitolo ho usato:
SCHERMER,
Franz, J.: Grundlagen der Psychologie, Kohlhammer 1999
PLATONE
(discepolo di Socrate): Polarità metafisica dello ³spirito² (mente, cognizione)
e della ³pulsazione² (emozione) si ritrova fino alla ³dottrina delle istanze²
psicoanalitica (conflitti tra ³Io e Super-io² ³Es² e ³Ueber-Ich²) fino ai
nostri tempi nei rami della psicologia con degli indirizzi più concettuali
europei che empirici.
ARISTOTELE
³De anima²: Definisce l¹anima come il principio e concetto del vivente. In
contrasto con il non vivente questo è dotato di ³percezione² e ³movimento²,
differenziato in:
- vegetale: nutrizione, crescita,
procreazione (piante, animali, umani),
- animale: percezione, emozione,
locomozione, desiderio (animali, umani),
- razionale: cognizione, riflessione,
intenzione (umani).
Si trovano fino ai nostri tempi nei rami della psicologia
dell¹orientamento più empirico che concettuale.
Il
900 ha messo gli accenti psichici piuttosto su dei parametri come:
- coscienza,
- esperienze/vicissitudini,
- inconscio,
- comportamento,
così
che la psicologia fu anche definita come scienza di vicissitudini e
comportamenti.
³ZIMBARDO,
P.G.: Psychologie, Springer 1995² riassume ³Oggetto della psicologia sono il
comportamento, le vicissitudini e la coscienza umana e le loro condizioni e
origini localizzate all¹interno (nell¹individuo) e all¹esterno (nell¹ambiente)
dell¹uomo.²
Vengono
trattati i seguenti temi:
3.3 Approccio di
psicologia analitica e di profondità
3.4 Approccio alla
psicologia umanistica
3.6 Approccio
della psicologia ³biologistica²
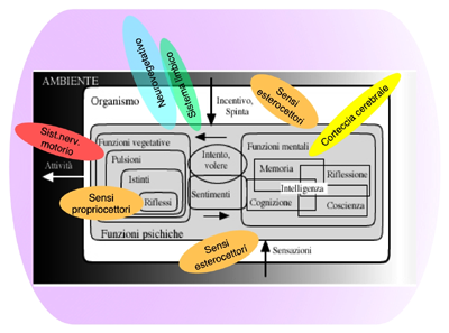
Si
occupa in generale dei seguenti temi:
3.1.1 Percezione
e osservazione
3.1.2 Apprendimento
e modificazione
3.1.4 Motivazione e collaborazione
Sotto
diversi aspetti.
Schermer
usa il seguente modello funzionale nell¹ambito della psicologia:
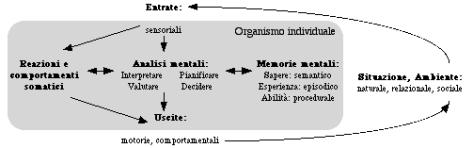
3.1.1 Percezione
e osservazione
Percezione
come un processo controllato da:
- informazioni e dati,
- concetti,
- comportamenti e attività.
Osservazione
come una forma di percezione valutata/descrittiva:
- completa immutata o
- ridotta simbolica o
- ridotta a categorie o
- di valutazione ridotta (rating).
3.1.2 Apprendimento
e modificazione
- rispondente (reattivo) o
- operante (autoattivo) o
- sociale (per osservazione e modelli).
3.1.3 Emozione e
compimento
Emozioni
e nessi con:
- vissuto e sentimenti,
- fisiologia e modifiche corporee,
- cognizione e valutazione,
- comportamenti ed espressioni.
Compimento
e elaborazione delle emozioni (coping) con dei criteri di:
- salute fisica,
- benestare psichico,
- funzionamento sociale.
3.1.4 Motivazione
e collaborazione
Tradizionalmente
interpretato ed esclusivamente come eventi dovuti all¹attrazione e alla
pressione:
- di intenti e incentivi interni e
autonomi;
- di stimoli e incentivi specifici esterni.
Attualmente
interpretate anche come un orientamento delle attività sotto i seguenti
aspetti:
- cognitivi e
- di intenti volontari.
La
collaborazione (relazionale terapeutica) con un interlocutore (paziente) viene
valutata dal terapista secondo i seguenti criteri:
- Presentazione e ripresentazione: termini
e scomodità.
- Disponibilità di comunicazione: risposte
a domande, notizie sugli eventi.
- Disponibilità
per dei tentativi di modifiche: proposte per modifiche, provare l¹insolito.
- Disponibilità per dei tentativi di
intervento: fare i relativi compiti.
- Disponibilità di cooperazione aperta,
fiduciosa, che mira alla riduzione delle tensioni.
La
psicologia empirica come scienza stipula per il proprio lavoro delle norme,
delle condizioni metodologiche e dei traguardi basilari concernenti i seguenti
argomenti:
3.2.3 Ipotesi,
supposizioni, regole e leggi
3.2.1 Valutazione
e giudizio
La
valutazione e il giudizio nella vita pratica ³precritica² non sono accertati ma
controllati intuitivamente e accompagnati dalle convinzioni. Questo ci facilita
la vita pratica e le decisioni da prendere, si riferisce a un contesto
particolareggiato e privato.
La
valutazione e il giudizio della scienza empirica devono essere fatti secondo i
criteri più severi, visto che si tratta di un contesto ³intersoggetivo e
pubblico²:
- Nesso con dei modelli e delle teorie
provate (anche falsificandoli).
- Esame critico per valutare l¹incidenza e
le probabilità.
- Trasparenza e immedesimabilità.
- Possibilità di ripetizione da parte di
altri scienziati.
3.2.2 Descrizione
Una
descrizione scientifica empirica necessita della precisione terminologica.
Questa si raggiunge con definizioni che devono essere precise e consistenti.
Preciso significa un discernimento esatto da altri termini, la consistenza si
verifica se diversi osservatori arrivano allo stesso discernimento.
Nella
psicologia empirica molte definizioni sono ³operazionali², ciò che vuol dire
che diversi criteri fissati definiscono un termine, p.es. il grado di
³sicurezza di sé² definito secondo i seguenti criteri:
- Contatto visivo.
- Richieste.
- Voltato verso l¹interlocutore.
- Voce chiara e voluminosa.
Diventa
precisa e consistente e rimane discutibile come definizione (non è vero in
senso assoluto, ma utile nel contesto di un lavoro specifico).
3.2.3 Ipotesi,
supposizioni, regole e leggi
La
psicologia empirica tenta di dedurre ipotesi in una continua alterazione di
idee creative e ragionamenti da una parte, paragonati con fatti reali
dall¹altra. L¹intuito, la creatività e la ricchezza di idee lasciano sospettare
prima una supposizione che va poi formulata come ipotesi.
Le
ipotesi vengono formulate:
- In modo che valgono in generale
(generalizzazione).
- In una frase condizionale (se , ).
- Che potenzialmente è falsificabile.
Quando
un¹ipotesi così formulata nell¹esperienza pratica viene sempre nuovamente
confermata, si parla di nessi regolari, regole o di legge.
3.2.4 Teorie e modelli
Una
teoria aggiunge ad una regola un postulato per una causa o una ragione (secondo
criteri severi) (se, , perché ). Vengono aggiunte delle istruzioni esatte che
permettono l¹esame (falsificazione) qualitativo e/o quantitativo. Costrutti di
teorie si chiamano anche modelli.
Le
teorie vengono spesso ³ampliate², ³ridotte², ³scartate², sostituite o in esse
si trovano diversi ³concorrenziali² che all¹osservatore non scientifico
appaiano confusionari. In realtà si evolve così la ³comprensione², in una
eterna ricerca che non soddisferà mai il ³bisognoso di credenze e convinzioni².
In questo senso la scienza empirica è umile, in contrasto con l¹arroganza dei
presuntuosi della verità, ma non mira a quest¹ultima né la promette. Concede
solo un po¹ più di comprensione.
I
modelli poi non sono reali, ma servono come strumenti di lavoro (spesso
riflessivo). Spesso si tratta di scegliersi il modello adatto al compito, come
lo scultore si sceglie lo scalpello adatto per la sua opera.
3.2.5 Previsioni e
mutamenti
Oltre alla ³descrizione² e alla ³comprensione² e ai
risultanti ragionamenti, consigli e ³interventi², nella psicologia come in
tutti gli aspetti della vita pratica sono importanti le previsioni
³prognostiche² e possibili mutamenti. È evidente che i modelli utilizzabili
dovrebbero contenere degli aspetti dinamici per poter sospettare o estrapolare
l¹evoluzione di un processo (con tutti gli imponderabili), che permette il
paragone con il fatto prospettato e la valutazione del modello stesso in funzione
delle divergenze prospettate e avvenute.
3.3 Approccio di psicologia analitica e di profondità
Introdotto
da FREUD al di fuori dei cerchi accademici, curato e sviluppato dai suoi
seguaci, ha trovato attenzione nella seguente psicologia:
- Accademica.
- Della personalità.
- Clinica e psichiatrica.
Nell¹opinione
pubblica, quando si pensa alla psicologia in senso lato, spesso ci si riferisce
alla psicologia freudiana, il che non corrisponde minimamente alla realtà,
anche se esistono pochi rami della psicologia che non si fanno inspirare dalle
teorie freudiane (³inconscio, individuale²) negli aspetti trattati quì di
seguito:
3.3.1 Aspetti
dinamici: pulsazioni
3.3.2 Aspetti
topografici: cosciente, inconscio, preconscio
3.3.3 Aspetti
strutturali: Es, Ich, Ueber-Ich
3.3.4 Aspetti
evolutivi personali (orale, anale, genitale, latente)
3.3.5 Aspetti
energetici-economici
3.3.6 Critica
della psicologia analitica e di profondità
3.3.7 Applicazione della psicologia analitica
3.3.1 Aspetti
dinamici: pulsazioni
Postulato
di istinti, passioni, pulsioni umane elementari come una fonte di comportamento
e attività umana:
- Autoconservazione.
- Sessualità (eros) come base (libido) di
spinta energetica per lo sviluppo umano.
- Autodistruzione (thanatos).
Come
³pulsione² è definita una ³onda energetica² continua e ripetitiva che fluttua
ma non si esaurisce.
3.3.2 Aspetti
topografici: cosciente, inconscio, preconscio
Si
definiscono le aree psichiche nel seguente modo:
- Inconscio come ³area psichica² con
accesso diretto impedito. Per Freud l¹area dominante dei processi psichici.
- Cosciente come area momentaneamente
accessibile del vissuto.
- Preconscio come area momentaneamente non
conscia, ma accessibile in ogni momento con il direzionamento dell¹attenzione.
I
meccanismi regolativi di conscio e inconscio sono diversi:
- Conscio: orientato in un sistema
tempo-spaziale e indirizzato secondo dei criteri di ³realtà².
- Inconscio: orientamento extemporale e
indirizzato a ³soddisfare bisogni/desideri²
(siano essi naturali che
culturali).
3.3.3 Aspetti
strutturali: Es, Ego, Super-ego
La
dottrina delle istanze postula:
- ³Es² come istanza di meccanismi biologici
innati.
- ³Super-ego² come un¹istanza delle
condizioni culturali esterne e interiorizzate formatesi con dei processi dello
sviluppo personale (comandamenti, divieti, valori, morale, autoideale,
coscienza).
- ³Ego² come istanza arbitraria tra i due
contraenti che tenta di ³trasformare² le pulsioni originali dell¹³Es² in una
forma accettata dal ³Super-ego² e di metterla in atto compatibilmente con la
³realtà².
3.3.4 Aspetti
evolutivi personali (orale, anale, genitale, latente)
La
dottrina postula delle fasi evolutive di personalità legate alle funzioni
primordiali delle pulsioni e alla loro soddisfazione:
- Fase orale nel primo anno di vita:
succhiare.
- Fase anale nel secondo anno di vita:
controllo della defecazione.
- Fase genitale dal terzo al sesto anno di
vita: interesse per i genitali.
- Fase latente: fino all¹inizio dell¹adolescenza:
altri interessi.
3.3.5 Aspetti
energetici-economici
La
dottrina postula, che ³l¹energia di pulsioni² non va persa ma deve essere
consumata. Se il ²Super-ego² o la dura realtà impediscono la soddisfazione
(scarica, distensione):
- Si
tenta di sostituirli con delle attività ³infantili² orali, anali o genitali
(rifiuto esterno).
- Se i desideri (per motivi di vergogna o
autodispetto) non diventano coscienti il ²Super-ego² blocca l¹accesso al
cosciente e crea uno scostamento nell¹³Es² dove sviluppa una dinamica
caratteristica (rifiuto interno) in modo che si trasforma in altri significati
o verso altri oggetti per raggiungere l¹accesso all¹³Ego² cosciente. Il
risultato di questo processo Freud lo chiamava ³nevrotico² o ³sintomatico² come
³panico², ³fissazioni², ³isteria², ³narcisismo²,
3.3.6 Critica
della psicologia analitica e di profondità
La
critica si riferisce a tre aspetti:
- Teorici/scientifici.
- Di senso/valutazione.
- Metodici.
La
critica teorica si attacca al modo di riflessione spesso ³analogico² e
³metaforico². È di grande estetica e cultura, ma comporta una terminologia poco
determinata a degli scopi ³scientifici². Permette il libero accesso
all¹interpretazione. Permette anche all¹applicatore dialetticamente istruito
un¹interpretazione dei fatti avvenuti, ma raramente una previsione. Parecchie
basi sono per definizione non falsificabili (sempre e in ogni caso vere) il che
rende il sistema immune alla possibilità di dimostrarle come false. Le eterne
verità non sono il campo del lavoro scientifico, ma delle ideologie di ogni
tipo.
La
critica del senso della valutazione si riferisce soprattutto ³all¹idea della
sopravvalutazione² nell¹ambito della sessualità, che nel contesto sociale di
Freud e di quell¹epoca si capisce benissimo, ma non è generalizzabile
oggigiorno.
La
critica metodica si riferisce alla riproducibilità delle informazioni e dei
dati (meno di Freud che dai suoi discepoli) che inibiscono ogni controllo
empirico e sistematico.
3.3.7 Applicazione
della psicologia analitica
La
quarta critica non concerne Freud e i suoi discepoli, ma le condizioni e le
pretese sociali e individuali della nostra cultura:
- Come formazione psicologica è molto
individuale e intensa come impegno emotivo, temporaneo e materiale (autoanalisi
di apprendimento).
- Indicazioni e controindicazioni per l¹uso
terapeutico e l¹impegno ideale e materiale da parte degli utenti la limitano in
pratica a una clientela benestante con delle nevrosi clinicamente non critiche
(fasi latenti).
Negli
stati acuti è controindicata come metodo.
Ciononostante
ritengo d¹obbligo lo studio dell¹opera freudiana per tutti coloro che si
occupano di ³anime². Come scrive ZIMBARDO: Quello che ha fatto Picasso per le
arti figurative, Freud l¹ha reso per la psiche umana: ha modificato i nostri
modi e maniere di riflettere e le loro possibilità, molteplicità
3.4 Approccio alla psicologia umanistica
ROGERS,
C.: Entwicklung der Persönlichkeit, Klett-Cotta 1976
La
psicologia umanistica pone un¹alternativa ³positiva² al ³pessimismo
dell¹analitica immagine umana² (che interpreta le vicissitudini e i
comportamenti delle persone come effetto un del controllo sulle loro pulsioni).
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
3.4.2 Teorie
della personalità
3.4.3 Comportamento
e motivazioni
3.4.5 Guida del
discorso terapeutico
3.4.6 Critica
alla psicologia umanistica
3.4.1 Natura dell¹uomo
Nella
descrizione di Rogers l¹uomo è di natura:
- Spinto all¹autonomia (indipendenza
dall¹esterno).
- Orientato positivamente: di stampo
sociale, prospettivo, ragionevole e realistico.
- Capace di capirsi e autorealizzarsi nel
senso che aumenta il proprio benessere tramite una tendenza intrinseca di
autoattualizzazione.
- Possiede un comportamento sensato
indirizzato a una meta.
- È dotato di valori interni come la
libertà, la dignità, la giustizia.
- Possiede un¹integrità personale come
³gestalt² (figura) olistica (unità) di ragione, emozione, corpo e anima.
3.4.2 Teorie
della personalità
La
teoria della personalità di Rogers si basa sul principio del ³Sé² (concetto del
sé, struttura del sé) come ³figura² organizzata, consistente e terminologica,
potenzialmente cosciente (Gestalt), composta da:
- Percezione delle caratteristiche
dell¹²Io² e ³Mio².
- Percezione delle relazioni dell¹²Io² e
³Mio con gli altri e il mondo.
- Valori relativi.
3.4.3 Comportamento
e motivazioni
Il
comportamento e la percezione delle persone sarebbero orientati maggiormente
con la propria ³Gestalt², nel comportamento come indirizzo, nella percezione
come filtro. L¹orientamento mira all¹interno del ³processo di valutazione
organismico² a:
- Riduzione della tensione.
- Crescita.
- Sviluppo.
- Autorealizzazione.
Tutti
i comportamenti innati e oltre a questi:
- La dedizione positiva (accettazione,
amore, rispetto) acquisiti nel processo della socializzazione.
3.4.4 Conflitti e disturbi
I
conflitti sono interpretati come contrasto tra valutazione organismica attuale
(reale) e dedizione positiva mirata (ideale). Il conflitto crea una deviazione
del ³Sé reale² e del ³Sé ideale². Questa deviazione può essere elaborata in
diversi modi:
- Assimilazione e integrazione del reale
nell¹ideale: si adatta a un processo evolutivo l¹ideale al reale con una nuova
congruenza.
- Ignorare la realtà: l¹incongruenza
persiste.
- Distorcere la realtà: l¹incongruenza
persiste.
Incongruenze
rilevanti, persistenti e ripetitive causano disadattamenti psichici che possono
creare:
- Sensi di colpa, ansia. -
Diminuzione dell¹autodignità.
- Depressioni. -
Fobie, idee e azioni coatte.
-
3.4.5 Guida del
discorso terapeutico
Come intervento Rogers applica il discorso terapeutico
che mira a far rifunzionare l¹autoattualizzazione del ³Sé ideale² irrigidito o
bloccato (non il disturbo attuale che in questa ottica è ³solo² sintomo). La
conduzione del discorso da parte del consulente deve essere:
- Autentica: sincerità, priva di
bigotteria, che crea fiducia.
- Di stima positiva: rispetto e dignità,
non invadente, atta a creare un ambiente privo di paura e ricatto, che stimola
il cliente ad affrontare le proprie emozioni e esperienze.
- Dedizione comprensiva: darsi da fare per
vedere il mondo con gli occhi del cliente, chiedere se le sospettate emozioni
erano presenti, verbalizzare le emozioni.
Fornire al cliente un modello
di trattamento ³autoesplorativo².
3.4.6 Critica alla
psicologia umanistica
Come
l¹approccio della psicologia analitica e altri approcci ideati da singoli
grandi ricercatori, si tratta di un sistema chiuso, principalmente
inaccessibile a nuove scoperte elementari. In più la precisione dei termini
chiave crea l¹impossibilità di dimostrare o falsificare postulati importanti
(p.es. il postulato della tendenza all¹autorealizzazione).
Il
modello è stato integrato spesso e volentieri nel repertorio dei metodi
sociopedagocici per l¹affinità delle due direzioni riguardanti il veicolo di
mutamento (relazione), le prospettive di traguardo, l¹emancipazione, inoltre
non pretende studi approfonditi. La parte della ³guida del discorso
terapeutico² invece è diventato uno strumento efficace, controllabile e
ripetibile nelle diverse terapie discorsive specialmente per i clienti con
delle capacità sociali e relazionali sviluppate.
LIEBEL,
Hermann, J.: Angewandte Psychologie; Kohlhammer 1999
La
psicologia applicata (non terapeutica) si dedica a processi gestionali di
individui e gruppi nel contesto di importanti attività e a percezioni umane
(soprattutto sociali). Trova il suo campo d¹impiego soprattutto nelle relative
grandi strutture e istituzioni.
Psicologia
di:
Scuola
Lavoro, imprese, organizzazione:
- grafologia
Mercati e relativa comunicazione
Propaganda e marketing
del denaro
Diritto e giurisprudenza
Politica
Clinica/sanitaria
Sanità, ambiente
Architettura
Circolazione e traffico
Turismo
Sport
Gioco e svago
Musica
Religione
...
3.6 Approccio della psicologia
³biologistica²
La
psicologia ³biologistica² studia l¹interazione dei processi metabolici da una
parte, vicissitudini e comportamenti dall¹altra. Malauguratamente, si trova
quasi esclusivamente nelle mani della psichiatria clinica e di medici con
un¹inclinazione alla ³psicosomatica² e si serve per lo più di ³psicofarmaci²
con una differenziazione scarsa e non da ultimo gode di una pessima reputazione
sociale.
Questo
è un grande peccato, proprio l¹effetto degli psicofarmaci (e altri medicamenti)
dimostra senza dubbio che il funzionamento psichico ha una dimensione
biologica/metabolica (scambio di sostanze). Come terapista non capirò mai
perché a una psiche, che deve garantire il funzionamento biologico in un
contesto culturale, si dedica tanta attenzione alla sua cultura, trascurando
quasi completamente la biologia. Sarà la classica formazione e specializzazione
che rende ciechi da una parte i medici e dall¹altra gli psicologi e gli
psicoterapeuti, sempre a discapito del povero paziente.
Non
potendo pretendere delle conoscenze di ³gestione biologica², nelle prossime
pagine elencherò diverse nozioni a riguardo, importanti per poter intuire il
funzionamento delle sostanze ortemolecolari e degli psicofarmaci.
Nell¹introduzione
ho tentato (come contrappunto) di sintetizzare:
- I contesti concreti biologici e
culturali.
- I substrati organici come il sistema
ormonale e nervoso di queste funzioni e disfunzioni.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
3.6.3 Gestione biologica dell¹organismo umano
3.6.4.2 Fisiologia
dello ³stress²
3.6.1 Temi di
biologia
La
biologia studia gli ³aggregati viventi², dai più semplici (virus) ai più
complessi (mammiferi) a tanti livelli strutturali e funzionali:
- Biofisici:
diffusione, osmosi, scambi energetici elementari e termodinamici, elettrici ...
- Biochimici: elementi e sostanze,
trasformazioni chimiche e catalittiche, forme di molecole, ...
- Organuli: struttura e funzionamento di
unità specializzate cellulari come il nucleo, i mitocondri, i ribosomi, il
reticolo endoplasmatico,
- Cellulari: struttura e funzionamento di
cellule: unità viventi autonome come composizione architettonica e
funzionamento materiale (metabolismo), energetico e gestionale.
- Tessutali: struttura e funzionamento di
aggregati cellulari di simili funzioni e materia e funzionamento intracellulare
(matrice basale, plasma, fibre, ), la loro organizzazione e gli scambi
materiali, energetici e informatici.
- Organi: aggregati di tessuti con una
funzione specializzata strutturale (anatomica) e funzionale (fisiologica) come
i muscoli, il fegato, il cervello,
- Sistemi e apparati: insieme di organi e
tessuti con una funzione vegetativa complessa come l¹apparato digerente, il
sistema cardiovascolare, il sistema immunitario, il sistema di escrezione,
l¹apparato motorio/tegumentario, il sistema procreativo, il sistema gestionale,
- Organismo: insieme di sistemi coordinati
e sintonizzati come unità autonoma di funzionamento in un eventuale contesto
sociale e ambientale.
Le
discipline sono molte (p.es. nella microbiologia, genetica, zoologia, biologia
umana, fitologia, ) e specializzate in innumerevoli rami specialmente durante
gli ultimi decenni, ciò comporta:
- Che non si nota più il bosco a cusa degli
alberi.
- Si sono diffuse ³idee fisse e di
sopravvalutazione sociali² secondo l¹attuale tema specializzato e riportato dai
mass-media.
- Diminuiscono gli studi generalistici dei
giovani, perché la materia è difficile, complessa e laboriosa; promette di
studiare più materie ³sociali² che di ³scienze².
3.6.2 Gestione
di organismi
Le
funzioni psichiche fanno parte del ³sistema di gestione² dell¹organismo
(sistemi ormonali e nervosi).
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
3.6.2.1 Gestione
di organismi monocellulari
3.6.2.2 Gestione
di organismi multicellulari
3.6.2.3 Policellulari
e sostanze messaggere (ormoni)
3.6.2.4 Concatenamento
di ³sensori² e ³attivatori² con ³nervi² e neurotrasmettitori
3.6.2.5 Integrazione
di ³nervi² in un ³sistema nervoso²
3.6.2.6 Differenziazione
del ³sistema nervoso² in vegetativo e motorio
3.6.2.7 Differenziazione del sistema
nervoso centrale in funzioni emotive e mentali
3.6.2.1 Gestione
di monocellulari
La
gestione di monocellulari come i flagellati si pensa sia determinata
prevalentemente dalla natura genetica. I circuiti regolativi devono essere
comunque parecchio complessi, perché riescono a muoversi in una determinata
direzione discriminando concentrazioni ³attraenti² e ³respingenti²
(chemiotassi). Anche gli spermatozoi umani dispongono di questa dote (di
movimento). Ma tutte le cellule nel contesto di un ambiente variabile entro
certi limiti riescono perfettamente ad autogestirsi per quanto riguarda le loro
capacità metaboliche.
3.6.2.2 Gestione
di organismi multicellulari
Evolutivamente
già gli organismi multicellulari primitivi hanno bisogno dei meccanismi di coordinazione
tra le loro cellule, che funzionano con ³sostanze messaggere² sintetizzate a
certe condizioni dalle cellule, ³esportate², percepite da altre cellule e usate
per regolare le proprie funzioni.
3.6.2.3 Multicellulari
e sostanze messaggere (ormoni)
Le
piante, anche le più grandi, funzionano ancora per lo più secondo questo
principio, con una grande varietà di sostanze che permettono di regolare le più
diverse funzioni e specializzazioni. Negli animali e anche nell¹uomo, alcuni di
loro si chiamano ormoni, ma anche ³fitoormoni² è diventato un termine corrente
per certe sostanze di questo genere.
3.6.2.4 Concatenamento di ³sensori² e ³attivatori² con ³nervi² e neurotrasmettitori
Negli
organismi animali più complessi, alcune cellule si sono specializzate nella
produzione di queste sostanze, e più tardi anche nella trasmissione di segnali
elettrici lungo i loro corpi filiformi. Si sono formate così le cellule nervose
(neuroni) capaci di:
- Percepire condizioni ambientali
(sensoriale).
- Elaborare e integrare diverse condizioni
variabili durante un certo tempo.
- Trasmettere un segnale a grande velocità
lungo il loro corpo filiforme come impulso elettrico.
- Sintetizzare e immagazzinare certe
quantità di ³sostanze messaggere² (che si chiamano adesso neurotrasmettitori).
- Esportarle velocemente e in grande
quantità in funzione di un segnale trasmesso a una seguente cellula (nervosa o
di altro tipo) o nella matrice basale tra le cellule.
3.6.2.5 Integrazione
di ³nervi² in un ³sistema nervoso²
Con
l¹aumentare della complessità queste cellule nervose sono andate organizzandosi
nelle reti di cavi (nervi), e poi le reti si sono concentrate in ³gangli²
(gruppi di corpi cellulari nervosi) e plessi (centrali di smistamento di
cellule nervose). I nervi si sono organizzati nel midollo spinale e si è
sviluppata una centrale di coordinazione delle reti e dei cavi: il cervello. A
questo punto, diventava importante la coordinazione dei tanti ³messaggi
entranti² diversi e contrastanti da una parte, e la sintonizzazione e sincronizzazione
dei ³messaggi uscenti² nel senso di una direzione comune di tante mosse. Il
criterio di valutazione o decisionale era (in linguaggio umano):
- ³buono² per tutto ciò che era
l¹utilizzabile e carente, con la relativa ³risposta di avvicinamento²;
- ³non buono² per ciò che era
l¹inutilizzabile e eccedente, con la relativa ³risposta di ritiro²;
quindi una specie di
sentimento e reazione sensata.
3.6.2.6 Differenziazione
del ³sistema nervoso² in vegetativo e motorio
Aumentando
ulteriormente la complessità si formarono delle specializzazioni nel sistema
nervoso centrale (cervello e midollo spinale) e del sistema nervoso periferico,
di pari passo con lo sviluppo degli organi specializzati per:
- Procreazione, approvvigionamento,
digestione, distribuzione (circolazione) ed escrezione da una parte (sistema
neurovegetativo).
- Movimento e organi sensoriali esterni,
specializzati dall¹altra (sistema nervoso somatico) ma aumentano anche le
necessità di coordinazione e di sintonizzazione tra i diversi sistemi nella
massa cerebrale, che non solo si raggruppavano secondo il vegetativo e
sensoriale/motorio, ma anche con un centro ³emotivo² (chiamato limbico) per
valutare il piacevole e lo spiacevole in cooperazione con dei sistemi ormonali
(per diversi tipi di attività come stato di veglia (recupero, giorno e notte),
integrando anche delle funzioni difensive (immunitarie).
3.6.2.7 Differenziazione
del sistema nervoso centrale in funzioni emotive e mentali
Si
può far risalire a quel momento l¹organizzazione di una funzione di ³memoria
nervosa² alla periferia del cervello primitivo,che permetteva qualcosa che
possiamo chiamare ³esperienza² (anche se non nel senso umano di ³cosciente²).
Un arricchimento funzionale da una parte che permetteva di evitare o cercare situazioni
pericolose o soddisfacenti e dall¹altra parte in netto contrasto all¹istanza
decisionale ³emotiva² approvata (piacevole/spiacevole). Deve essere stato
allora, quando fu istaurata un¹istanza ³arbitraria² (intento, volere, volontà)
e molto prima dell¹evoluzione di funzioni come coscienza, riflessione,
intelletto che pare siano state inventate come programmi di applicazione
sofisticati della vita, riservati a organismi evoluti come i coccodrilli, le
oche e i mammiferi come l¹uomo.
3.6.3 Gestione
biologica dell¹organismo umano
Il
seguente grafico raggruppa sistemi, organi, funzioni e nessi principali di un
organismo umano, coinvolti nella gestione di quest¹ultimo.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
3.6.3.1 Gestione
emotiva/mentale nell¹organismo umano
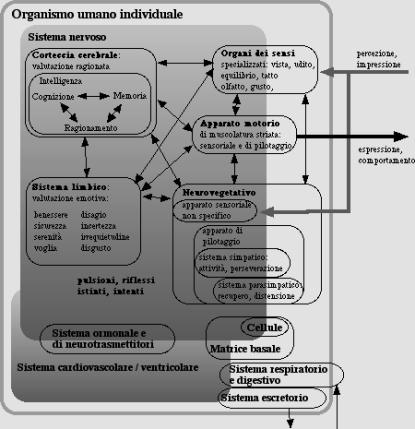
3.6.3.1 Gestione
emotiva/mentale nell¹organismo umano
Il
seguente schizzo indica i circuiti di regolazione tra le percezioni ambientali
e l¹attività interna ed esterna. Si notano due proprietà evidenti:
- Le elaborazioni e le conseguenze interne
a stimoli esterni sono notevoli.
- Il funzionamento interno dell¹organismo
produce altrettanti stimoli che vanno elaborati e non necessariamente chiamano
un¹attività esteriorizzata, ma altre interne.
- La maggior parte degli stimoli non
raggiungono mai la corteccia cerebrale e rimangono ³inconsci².
- La maggior parte degli stimoli passa
attraverso le funzioni emotive prima di raggiungere le funzioni mentali dove
possono diventare ³coscienti² (se l¹attenzione è indirizzata a loro e non ad
altro e se non dormiamo).
- Le funzioni emotive e le funzioni mentali
possono essere ambivalenti, contrastanti, concorrenziali, il che richiede
importanti processi decisionali.
Tanto
per il momento.
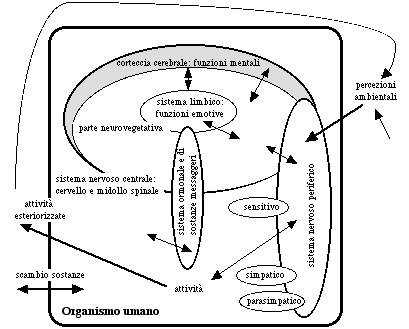
3.6.3.2 Gestione
nervosa
Il
sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) è formato da ca. 10
miliardi di cellule nervose, ciascuna concatenata con migliaia delle loro
sorelle. La minima parte di esse è accessibile alla coscienza.
Come
abbiamo visto prima, la maggior parte del lavoro gestionale viene eseguito dai
sistemi ormonali e neurovegetativi. Questa parte determina:
- Riflessi muscolari e secretori (come
salivazione, arrossamento, di tendini/muscoli).
- Istinti come l¹aggressione, l¹alleanza,
la covata.
- Pulsioni di autoconservazione,
procreazione,
le
quali in parte sono ³coscientemente percepibili² ma non (direttamente)
influenzabili.
Un¹altra
parte è nettamente dominata da fattori ormonali e neurovegetativi. L¹emotività
tramite il sistema limbico.
Un¹altra
parte ancora fa da arbitro tra le porzioni ³vegetative²/²emotive² e quelle
³mentali² (non segnata sullo schizzo) e sembra abbastanza controllabile.
Inganna però, perché sembra controllabile se il vegetativo funziona alla
perfezione, alla presenza di disturbi vegetativi invece quest¹ultimo prende
subito il sopravvento e agisce al di fuori o contro la nostra ³volontà². Per
questo fatto lo denominiamo ³volere² o ³intento².
La
corteccia cerebrale consiste in uno strato sottile di pochi millimetri di
tessuto nervoso che copre la massa della sostanza cerebrale ³vegetativa². È
responsabile delle funzioni di:
- Memoria.
- Cognizione.
- Coscienza.
- Riflessione.
- Intelligenza.
Di
queste funzioni siamo fieri e per noi, megalomani antropocentrici,
rappresentano il culmine della creazione. Ripeto che si tratta di una ³vernice
sottile² e poco miracolosa rispetto a quello che sta al di sotto (inconscio in
eterno).
Una
parte della corteccia cerebrale comunicante con il sistema limbico è
responsabile della percezione delle emozioni, degli affetti e dei sentimenti
ivi prodotti in base a chi sa quali criteri.
Un¹altra
parte sempre della medesima corteccia percepisce (o meno)
- dalla grande massa cerebrale vegetativa i
messaggi di necessità vitali (primari e funzionali, spesso chiamati pulsazioni,
istinti, brama, voglia, desideri) e
- da un¹altra parte corticale gli impulsi
dei desideri sociali e di interessi culturali.
Essendo
spesso contrastanti, concorrenziali e ambivalenti, questi impulsi in un¹altra
parte sempre della stessa corteccia pare che ci sia un arbitro chiamato spesso
³volere² o ³intento² che non sempre si accorda con il più forte, ma confronta
la soddisfazione momentanea ma breve con quella rimandata ma più compiacente.
Per questo gli serve l¹³esperienza² che è pensabile solo in base a una memoria
(cosciente o inconscia).
Qui
di seguito vengono trattati i seguenti argomenti:
3.6.3.2.1 Cervello e sistema nervoso centrale
3.6.3.2.2 Sistema nervoso periferico e vegetativo
3.6.3.2.3 Cellule nervose (neuroni)
3.6.3.2.1 Cervello
e sistema nervoso centrale
KAUTZMANN,
Gabriele: Das Wunder im Kopf, Zabert Sandermann, München 1999.
Il
seguente schizzo può dare una vaga idea circa la costruzione del marchingegno
cerebrale. Si noti che la corteccia cerebrale è esagerata come spessore, in
compenso copre (grazie alle tantissime pieghe) una superficie maggiore di
quanto appare. Si noti anche che il sistema limbico, come centro di
elaborazione degli ³affetti² e di coordinazione e di sintonizzazione con il
sistema vegetativo è molto sviluppato.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
3.6.3.2.1.1 Funzioni
della corteccia cerebrale
3.6.3.2.1.2 Funzioni
del sistema limbico-ormonale
3.6.3.2.1.4 Neurotrasmettitori
e sostanze messaggere
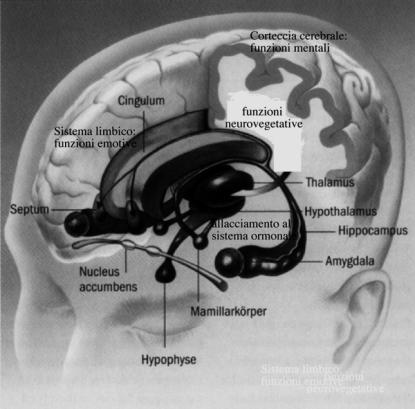
3.6.3.2.1.1 Funzioni della
corteccia cerebrale
In
psicopatologia e anche in psichiatria si usa spesso una terminologia
funzionalmente più differenziata e orientata (più verso ³il comportamento²) che
nell¹anatomia e fisiologia del sistema nervoso (e gli altri ³regolativi² come
endocrino, immunitario e basale).
Nel
seguente modello ho sovrapposto a un modello ³primitivo fisioanatomico² una
terminologia basilare della psicopatologia descrittiva (in grassetto).
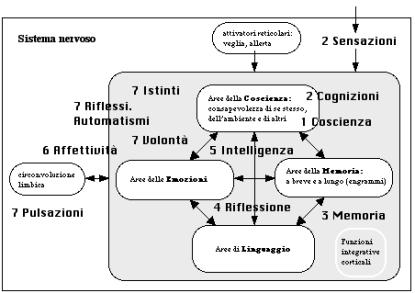
3.6.3.2.1.2 Funzioni del
sistema limbico-ormonale
Il sistema limbico è una
centrale di smistamento emotivo nei due sensi:
- da una parte, e se lo ritiene indicato,
annuncia alla corteccia
cerebrale e quindi a una parte potenzialmente cosciente, la presenza di
un¹emozione ³primitiva²;
- dall¹altra parte fa scattare una reazione
a catena di risposta/reazione al sistema ormonale.
Il
seguente grafico mostra una piccola parte dell¹ultima funzione collegata
specialmente agli ormoni sessuali:
1. Maturazione di ovociti nelle ovaie e di
spermatozoi nei testicoli provocata da ormoni sessuali.
2. L¹ormone di accrescimento controlla la
crescita e la distribuzione di lipidi (grassi).
3. L¹ormone tiroideo controlla le attività
metaboliche.
4. La vasopressina regola l¹attività renale
e stimola le ghiandole surrenali alla produzione di cortico-steroidi
(cortisole, aldosterone, testosterone).
5. Ormoni
per la produzione lattea (prolattina, ossitocina, ).
6. Ossitocina per l¹orgasmo (maschio &
femmina).
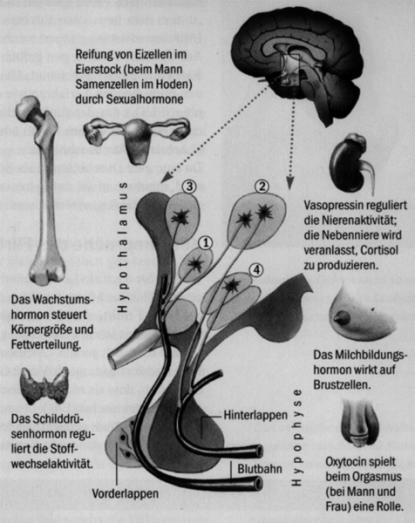
3.6.3.2.1.3 Rete
neuronale
Il
grafico da un¹idea del concatenamento di cellule nervose. Si tratta del concatenamento
di 4 cellule (dei 10 miliardi del sistema nervoso centrale). Si pensa che la
continua neoformazione e lo staccamento di connessioni oltre alla produzione di
neurotrasmettitori e ormoni siano i processi elementari alla base di tutte le
nostre capacità gestionali vegetative, motorie e psichiche. Ma gli enigmi sono
più numerosi della conoscenza.
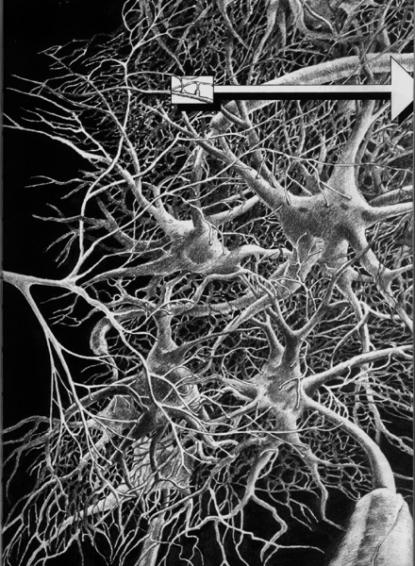
3.6.3.2.1.4 Neurotrasmettitori
e sostanze messaggere del sistema nervoso centrale
In
psicopatologia si parla dell¹organismo come se si trovasse sempre in uno stato
medio di allerta. Questo non rispecchia un fatto fisiologicamente
importantissimo. La gestione dell¹organismo conosce tanti stati di
funzionamento che non sono aleatoriamente cambiabili:
- Diverse fasi del sonno e sogno (ricordato
o meno).
- Dormiveglia.
- Percezione/coscienza
acuta senza associazioni (stato alfa).
- Apatia.
- Distrazione, riposo e recupero.
- Preparazione, avvio e attesa.
- Veglia e attività coscienti normali.
- Altissima attività o concentrazione.
- Stati di confusione e panico.
- ...
In
tutte queste e altre fasi il nostro sistema neurovegetativo fa lavorare in modo
molto differenziato i nostri organi e questo non è tutto, in diversi momenti
della giornata (giorno, notte) del mese (ciclo mestruale) e dell¹anno
(stagioni) nonché nelle fasi di vita (dalla prole al cadavere) gestisce alla
perfezione ³l¹andamento della baracca² (secondo le necessità ambientali e le
risorse momentanee).
Spesso
invadiamo come gli Unni questo sistema con le nostre pretese coscienti e poco
fisiologiche ma molto coltivate, altre volte ci illudiamo di dover insegnare al
vegetativo come deve fare il suo mestiere e se sbaglia (secondo i nostri
ignoranti critici) siamo indulgenti. E ci manca ogni comprensione se dopo anni
di intrusioni ignoranti da parte nostra, ³benevolente², esso si rassegna o
comincia a fare il matto in un disperato tentativo di farsi sentire, Poi
andiamo dal medico, cercando un alleato.
Uno
degli strumenti per l¹organizzazione di questo sistema sono i
³neurotrasmettitori², sostanze a ormoni che nella loro composizione e
concentrazione relativa, determinano materialmente questi stati. Parecchi di
loro sono elencati con le loro funzioni note nella seguente tabella:
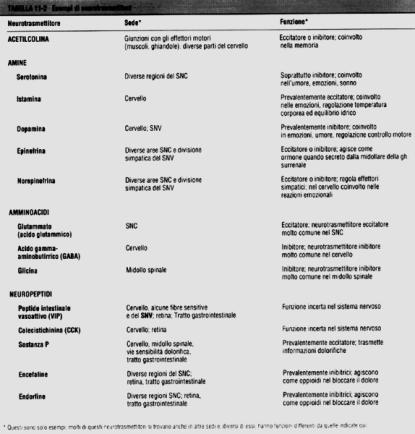
3.6.3.2.2 Sistema nervoso periferico e vegetativo
Il
seguente schizzo illustra il funzionamento del sistema nervoso periferico. Si
noti la sua funzione intermediaria tra i sensori degli organi dei sensi e di
organi, il sistema nervoso centrale e gli effettori (sulle cellule muscolari e
secernenti) come la parziale autonomia negli ³archi dei riflessi² (regolativi
tra i sensori ed effettori) senza che debba intervenire il cervello. Una parte
delle funzioni regolative è quindi
³delegata². Questa forma organizzativa ³decentrata, federalistica²
sembra una caratteristica dell¹organismo, perché si trova a tutti i livelli
fisiologici.
Si
noti anche che il sistema nervoso vegetativo oltre ai tratti sensitivi (segnali
da sensori) dispone di due rami nervosi distinti di controllo:
- Il ramo del ³simpatico² che stimola
l¹attività degli organi vegetativi necessari per ³attivitಠal di fuori della
muscolatura motoria (che dispone di un separato sistema di comando e
controllo).
- Il ramo del ³parasimpatico² che
stimola il recupero o il riposo dellefunzioni vegetative.
Questa
costruzione permette di controllare gradualmente la prevalenza dell¹una o
dell¹altra funzione, ma nel medesimo tempo ³il fervore² o la spinta, in quanto
tutte e due possono trovarsi a un livello basso (spinta minima) o a un livello
alto (spinta massima).
Molti
disturbi psichici provenienti dal neurovegetativo sono disfunzioni di questo
tipo:
- Simpatotonia: iperfunzioni di
allerta, ipofunzioni recuperative, sindrome di stress cronico.
- Vagotonia (parasimpaticotonia):
ipofunzioni di allerta, iperfunzioni recuperative, noia cronica.
- Spinta esagerata instancabile:
forme maniacali: simpatotonia & vagotonia esagerata.
- Spinta diminuita, apatia: forme
depressive gravi, esaurimento: ³simpatopenia² e ³vagopenia².
Viene
trattato il seguente argomento:
- Neurotrasmettitori del sistema
nervoso periferico.
Il grafico illustra la costruzione e il
concatenamento del sistema nervoso
periferico (all¹infuori del cervello e del midollo spinale).
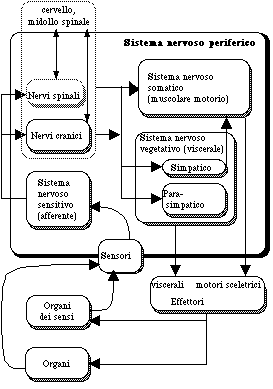
Vengono trattati i seguenti temi:
3.6.3.2.2.1 Neurotrasmettitori
del sistema nervoso periferico
3.6.3.2.2.1 Neurotrasmettitori
del sistema nervoso periferico
Il
seguente schizzo mostra come esempio la complicata relazione tra i
neurotrasmettitori e ricettori cellulari di organi per il ramo simpatico e
parasimpatico e il meccanismo di amplificazione nelle ghiandole ormonali
surrenali.
Nel
linguaggio medico si chiamano:
- Adrenergici (adrenalina) gli stimolanti
del simpatico, anche
simpatotonico.
- Colinergici
(acetilcolina) gli stimolanti del parasimpatico, anche vagotonico.
Sono
marcati anche i punti e i tipi di intervento per diverse sostanze farmaceutiche
³psicoattive².
3.6.3.2.3 Cellule
nervose (neuroni)
Le
cellule nervose in gergo medico si chiamano neuroni.
Qui
di seguito vengono trattati i seguenti argomenti:
3.6.3.2.3.1 Costruzione
di neuroni
3.6.3.2.3.2 Funzionamento
di cellule nervose
3.6.3.2.3.3 Metabolismo
di neuroni
3.6.3.2.3.4 Scambio di
neurotrasmettitori
3.6.3.2.3.1 Costruzione
dei neuroni
Lo
schizzo mostra schematicamente la costruzione di un neurone (cellula nervosa):
- Da una parte i dendriti, sensori per
determinate sostanze ³neurotrasmettitrici² che conducono al
- corpo cellulare (pericario) con la
struttura interna di nucleo e organelli di vario tipo. Integra i messaggi
³elettrici² mandati dai ³sensori² dentritici e li valuta, oltre a produrre
delle sostanze usate all¹interno della cellula e da esportare. A certe
condizioni di integrazione di segnali, si decide di far scattare un segnale
³elettrico² lungo l¹assone filiforme.
- L¹assone (pochi centesimi di millimetro
di diametro ma lungo fino a mezzo metro) conduce questo impulso molto
velocemente nella direzione dei bottoni sinaptici. Per non perdere l¹impulso
elettrico, gli assoni sono elettricamente isolati con una guaina mielinica
(grassosa). All¹interno dell¹assone si trovano microtubuli che trasportano in
continuazione le sostanze neurotrasmettitrici ai bottoni sinaptici.
- I bottoni sinaptici immagazzinano le
sostanze neurotrasmettitrici in vescicole. Sono allacciati a:
- dendriti (sensori) di altre cellule
nervose susseguenti,
- cellule muscolari o
- cellule secernenti (ghiandolari).
Quando
un impulso elettrico dal corpo cellulare raggiunge i bottoni sinaptici, questi
liberano immediatamente il contenuto delle vescicole immagazzinate verso
l¹esterno dove:
- stimolano dendriti di altre cellule
nervose susseguenti,
- provocano la contrazione di una fibra
muscolare o
- comunicano a una cellula ghiandolare di
produrre il suo prodotto preferito.
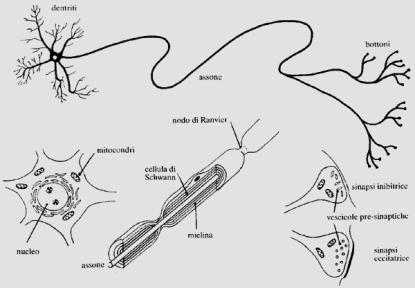
3.6.3.2.3.2 Funzionamento
delle cellule nervose
Il
seguente grafico illustra il funzionamento di una cellula nervosa più in
dettaglio. Come si vede è paragonabile a una grande impresa con ampie strutture
e infrastrutture atta a svolgere tantissime funzioni:
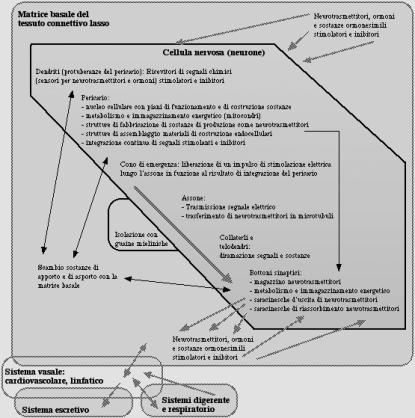
3.6.3.2.3.3 Metabolismo
dei neuroni
Il
seguente grafico dà una vaga e semplificata impressione dello scambio di
sostanze e processi biochimici in un neurone (metabolismo) e l¹allacciamento
agli altri sistemi tramite la matrice basale ambientale. Si distinguono spesso
questi processi in:
- Metabolismo energetico, che mette a
disposizione l¹energia per tutti i processi che ne assorbono (glucosio &
ossigeno trasformato in energia & acqua & anidride carbonica).
- Metabolismo strutturale per la produzione
di sostanze (sintetizzazione) che servono per la manutenzione e la crescita
della cellula stessa e lo smaltimento di sostanze eccedenti.
- Metabolismo funzionale per la produzione
di sostanze funzionali di importazione e esportazione.
Si
noti il coinvolgimento di ³minerali² sodio (Na) e potassio (K) per la
formazione e la propagazione dell¹impulso elettrico e di magnesio (Mg), calcio
(Ca) e cloro (Cl) per la regolazione di segnali e lo scambio di
neurotrasmettitori. Tante altre sostanze sono poi coinvolte nel metabolismo
strutturale e funzionale.
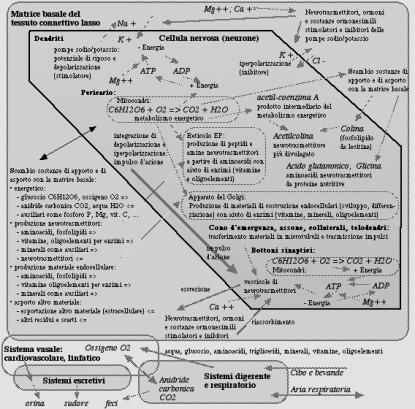
3.6.3.2.3.4 Scambio
di neurotrasmettitori
Il
seguente grafico mostra la costruzione di un bottone sinaptico. Per motivi
economici, i neurotrasmettitori non assorbiti dalla cellula allacciata possono
essere riassorbiti o lasciati nella matrice basale selettivamente.

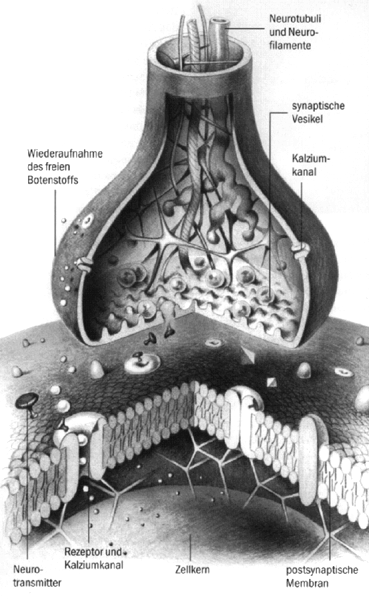
1
Riassorbimento di sostanza messaggera libera
2
Neurotrasmettitore
3
Ricettore e canale del calcio
4
Nucleo cellulare
5
Membrana postsinaptica
6
Canale del calcio
7
Vescicole sinaptiche
8
Tubuli e filamenti neuroni
3.6.3.3 Gestione
ormonale
Non
intendo approffondire il sistema ormonale e le sostanze messaggere. Di seguito
riporto un esempio, un¹illustrazione e un elenco di sostanze ormonali e
messaggere umane per dare un¹idea della complessità.
In
psicologia, psichiatria, psicopatologia e psicoterapia come in medicina
generale ³si sa² che gli squilibri e le disfunzioni ormonali causano grandi
disturbi psichici, specialmente di affetti e sentimenti, come affetti ed
emozioni d¹altronde modificano anche l¹economia ormonale. Le conclusioni sono
³quasi zero². In fondo lo sanno tutti che avvengono variazioni ormonali p.es.
durante il ciclo mestruale, nei disturbi tiroidali, durante l¹adolescenza, essi
modificano l¹umore, lo stato d¹animo, il comportamento delle persone, ma sembra
una strada terapeuticamente non accessibile. Si tenta poi di ³correggere² le
funzioni vegetative con il ragionamento e la coscienza, ciò è un tentativo
fallito prima di iniziare, se a monte vi è un disturbo ormonale.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
3.6.3.3.1 Nesso
neurovegetativo-ormonale
3.6.3.3.2 Ormoni,
neurotrasmettitori, sostanze messaggere
3.6.3.3.1 Nesso neurovegetativo-ormonale
Il
sistema limbico avvia delle reazioni a catena di liberazione o inibizione di
ormoni:
- o autonomamente in base a degli
impulsi di regolazione riflessiva,
- o in base a delle percezioni che la
corteccia cerebrale ³realizza² coscientemente e che provocano emozioni
frustranti o soddisfacenti.
3.6.3.3.2 Ormoni,
neurotrasmettitori, sostanze messaggere
Il
seguente grafico elenca, accanto alla regolazione ormonale sessuale, una serie
di altre sostanze messaggere giusto per dare una vaga idea.
La
regolazione digestiva, metabolica, immunitaria, escretoria, circolatoria, degli
stati di coscienza, funzionano secondo dei processi ormonali-cellulari
altrettanto complessi.
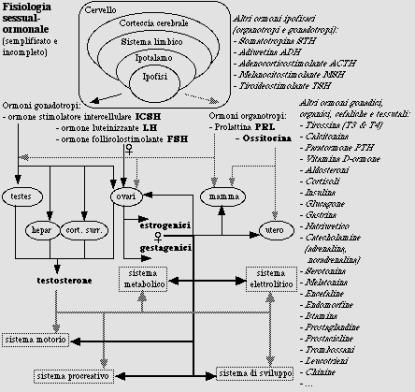
3.6.4 Biologia
gestionale
Sono
trattati i seguenti argomenti:
- Modello psicofisico.
- Fisiologia dello ³stress².
3.6.4.1 Modello
psicofisico
Il
seguente schizzo tenta di connettere dei criteri biologici e psichici che poi
sono distinti nella nostra riflessione, ma nella realtà di una persona sono
tutt¹uno:
- Il senso comune classifica le emozioni
come psichiche, mentre diventa moda nella medicina di vederle esclusivamente
come processi biochimici (ormonali e di neurotrasmettitori).
- La psicologia definisce anche percezioni,
sensazioni e impressioni come psichiche mentre il laico le classifica piuttosto
come ³corporee² (vista, udito, olfatto, gusto, tatto, equilibrio, dolore, ).
- La psicologia classifica come psichiche
anche delle prestazioni come la memoria, la cognizione, gli intenti, la volontà
(parte accessibile al cosciente) mentre il laico le percepisce più come
³mentali² o ³spirituali².
- La psicologia classifica come psichiche
anche le parti espressive umane, i ³comportamenti², mentre il laico tende a
classificarli come ³caratteriali² quando sono ³aberranti², scomodi e
ripetitivi.
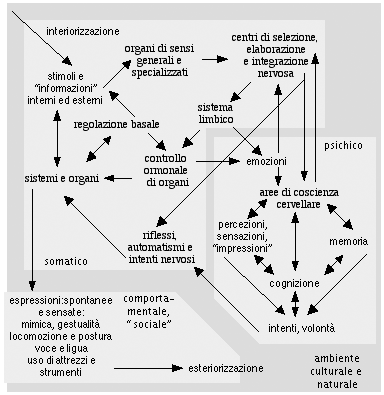
3.6.4.2 Fisiologia
dello ³stress²
Negli
ultimi decenni sono stati approfonditi diversi nessi e interazioni tra soma e
mente. Ciò permette di connettere anche mentalmente dei fatti comportamentali,
emotivi, fisiologici e anatomici. Dopo i lavori di Selye sullo stress e di
Pauling sul metabolismo e i ³micronutrienti² si sospetta che tantissimi
disturbi classificati ³sociali, comportamentali, psichici, percettivi, emotivi,
relazionali, ² abbiano anche una dimensione fisiologica/anatomica: che
scoperta!
Come
conosco la scienza e i mass-media, i prossimi anni saranno dedicati a
interminabili discorsi se la schizofrenia è causata da una massiccia mancanza
di vitamina B6 o se la schizofrenia potrebbe creare un esagerato fabbisogno di
vitamina B6. In realtà questa patologia ha probabilmente altre cause ancora
sconosciute (anche genetiche).
Il
seguente esempio di un modello scientifico (utile) indica la dimensione
organica/fisiologica di un fatto percepito come ³psichico: lo stress. Un altro
meccanismo non ancora trattato scientificamente, ma di simile importanza
³psichica² esistenziale, sarebbe la noia (troppo pochi stimoli, attività invece
troppa), che del resto provoca sintomi paragonabili.
Da
notare nel seguente esempio che cinque circuiti regolativi sono amplificanti
mentre solo uno (glucocorticoidi dalla corteccia surrenale a ipofisi e
ipotalamo) è smorzante.
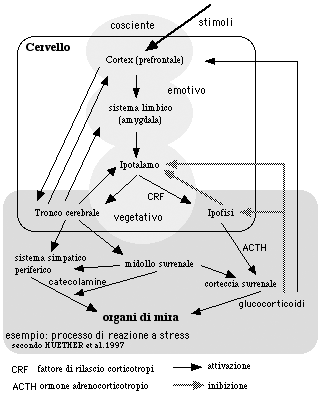
4.0 Medicina ³gestionale² umana
La
medicina è intensa prevalentemente come biologica e si serve oggigiorno
innanzitutto di ³farmaci² per curare delle aberrazioni funzionali (quelle
strutturali le tratta la chirurgia). Nel seguente capitolo sono quindi entrato
solo superficialmente nell¹argomento della farmacologia.
Vengono
trattati i seguenti temi:
4.2 Neurologia
e relativa neurofarmacologia
4.3 Psichiatria e
relativa psicofarmacologia
4.4 Psicosomatica e
relativa farmacologia ³sintomatica²
Il
dolore ha una dimensione:
- Neurologica in quanto si tratta di
segnali nervosi vegetativi ma anche
- una psichica in quanto è percepito
(amplificato o ammortizzato) coscientemente, influenzando notevolmente le
funzioni psichiche sia corticali (di controllo) sia limbiche (emotive).
Trattandosi
di circuiti nervosi regolativi che possono sia amplificare sia ammortizzare i
segnali originali, gli analgesici si servono di diversi meccanismi per
alleviare il sintomo:
- Gli oppiacei agiscono come inibitori sul
sistema nervoso centrale.
- Gli analgesici antipiretici servono per
ridurre i dolori del tipo infiammatorio.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
4.1.1 Dolore
e analgesici nella medicina tradizionale
4.1.4 Integratori
alimentari/antidolorifici
4.1.1 Dolore e
analgesici nella medicina tradizionale
La
medicina antica e popolare senza saperlo era più differenziata nella
classificazione e usava diverse sostanze (le più antiche medicine) per diversi
scopi:
- Gli oppiacei come sedativi di tutte le
funzioni vegetative e psichiche.
- Le cannabiacee come distensivi muscolari
³euforizzanti² e come inibitori del simpatico neurovegetativo.
- I derivati dalla coca come stimolanti del
simpatico neurovegetativo.
- Diversi ³simpatotonici² come l¹ephedrae,
la damiana,
- Diversi ansiolitici come la scutellaria,
- Diversi ³vagotonici² (parasimpatotonici)
come la lobelia,
- Diversi analgesici/miorilassanti come il
petasite,
- Analgesici locali come l¹aconito, la
menta, il garofano,
- Le solanacee (belladonna, giusciamo,
datura, ) come inibitori del parasimpatico neurovegetativo.
- Diversi fitoormoni come il luppolo,
- Diversi antiinfiammatori come la spira
ulmaria,
e
tante combinazioni tra queste sostanze per le raffinate sfumature di
dolore/stato d¹animo.
Anzitutto,
essi distinguevano gli stati dolenti tra l¹eccitazione/sedazione,
l¹infiammazione/nevralgia, e l¹iperveglia/apatia e l¹euforia/malumore.
Personalmente
uso tanti rimedi dei sopra citati, aggiunti alle seguenti sostanze:
- Vitamina B1, B6 e B12 in dosi massicce
per dei dolori prevalentemente ³nevralgici² (p.es. ANCOPIR).
- Enzimi proteolitici in dosi massicce per
dei dolori prevalentemente infiammatori (p.es. WOBENZYM).
Aggiungo
poi nella fase acuta e secondo i criteri citati sopra:
- Sedativi o stimolanti per
simpatico/parasimpatico.
- Rispettivamente combinazioni di tutte due
per
- aumentare
o abbassare il tono neurovegetativo
- e/o
intervenendo sullo stato d¹animo.
Il
tutto secondo ogni caso individuale e spesso anche correggendo il tiro secondo
l¹evoluzione. È evidente che questa parte del mestiere è indicata piuttosto a
degli ³esperti², sia per la complessità sia per l¹esperienza sia per il dosaggio
delle sostanze.
4.1.2 Oppiacei
Vengono
impiegati nel caso di dolori forti, acuti e cronici prevalentemente non
infiammatori. Effetti sedativi sul sistema nervoso centrale con tutti i
possibili effetti collaterali dei centralsedativi e le rispettive interazioni
con degli altri centrosedativi.
Gli
oppiacei sono spesso temuti dai laici per gli effetti collaterali e il
potenziale di dipendenza: la paura non è fondata, perché nelle mani di chi li
sa usare come la scelta, il dosaggio e la somministrazione sono i preparati con
meno effetti ³devastanti² sugli altri sistemi dell¹organismo. Certo che il
dilettantismo e l¹abuso, come per tutte le sostanze terapeutiche veramente
efficaci, li fanno diventare veleni.
4.1.3 Analgesici
antipiretici
I
più noti sono:
- Salicilati (es. ASPIRINA, ASA-TABS).
- Paracetamolo (es. CONTRA-SCHMERZ,
PANADOL, TREUPEL).
- Derivati di pirazolone (es. NOVALGIN).
- Derivati di acido antranilico (es.
PONSTAN).
- Derivati di acidi acetico, indolico,
propionico, di oxicame e diversi (es. VOLTAREN, FLECTOR, BRUFEN).
Gli
impieghi, effetti collaterali e le interazioni sono rilevabili dai rispettivi
foglietti illustrativi.
4.1.4 Integratori
alimentari/antidolorifici
Coinvolti
in processi di dolori possono essere i seguenti integratori alimentari:
Dolori AO,
PB, OE (antiossidanti,
proteine bassomolecolari, oli essenziali)
mal
di testa compl.B,
B1, B3, B6, AP, Fe, Cr, PABA
emicrania B6,
E, Mg, Se, o-3
crampi B6,
Na
dolori
muscolari, articolari BIO,
AP
neuropatie,
parestesie compl.B,
B1, B6, B12, AP, o-6, o-3, AL, LE, INO
bruciore,
torpidità B6
torpidità,
formicolio BIO,
AP
sindrome
del tunnel carpale B2,
B3, B6, Mg, o-6
dolori
cronici B1,
B6, B12, C, E, Se, dl-FA
(per le abbreviazioni vedi
PTO2)
4.2 Neurologia e relativa neurofarmacologia
La
neurologia sarebbe predestinata assieme con la psichiatria clinica a trattare
tanti disturbi psichici con una componente metabolica (praticamente tutte le
psicosi). Malauguratamente la divisione dei compiti non è (ancora) così chiara.
Il seguente capitolo non approfondisce la farmacologia medica, perché questi
pazienti vanno comunque trattati dal neurologo ed è criminale infilarsi nella
loro medicazione. In compenso, indico delle sostanze ortomolecolari coinvolte
nei relativi processi. Sono intese come proposte al neurologo, in nessun caso
per tentativi di automedicazione, perché possono avere delle serie interazioni
con i medicamenti neurologici.
Per
farsi un¹idea più chiara sulle relazioni tra neurologia e psicologia, vale la
pena di leggere tutti i libri di SACKS (un noto e divertente neurologo) p.es.:
SACHS, Oliver: -
Bewusstseinsdämmerungen; VLG Chemie
-
Migräne; Kohlhammer
-
Stumme Stimmen; rowolt
-
Der Tag an dem mein Bein fortging; rowolt
-
Der Mann der seine Frau mit einem Hut verwechselte; rowolt
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
4.2.2 Farmaci
contro il morbo di Parkinson
4.2.5 Farmaci
contro l¹emicrania
4.2.6 Farmaci
contro il morbo di Alzheimer
4.2.7 Farmaci contro la sclerosi laterale
amiotrofica
4.2.1 Antiepilettici
Lo
spettro di antiepilettici è molto largo e assolutamente di competenza del
neurologo; avendo effetti collaterali, indesiderati e di interazioni molto
variabili e dipendenti dalle dose, solo un esperto nel ramo è capace di
scegliere bene e correggere il tiro secondo il criterio del minor male.
Sostanze
ortomolecolari coinvolte possono essere:
epilessia
compl.min., B3(na), B6, E, Mg, Zn, Mn, Se, CIS, TAU, GLU, DMG
Sono
intese come proposte per il neurologo, in nessun caso per dei tentativi di
auto-medicazione, perché possono avere delle serie interazioni con i
medicamenti neurologici, in particolare gli aminoacidi e i metaboliti.
4.2.2 Farmaci
contro il morbo di Parkinson
I
due gruppi di medicamenti maggiormente usati sono:
- Levodopa (sostituisce la dopamina
mancante).
- Anticolinergici.
Sostanze
ortomolecolari coinvolti possono essere:
Morbo di Parkinson compl.B,
B3. B6, FOL, C, E, Se, o-6, ld-FA, l-MET
Sono
intesi come proposte per il neurologo, in nessun caso per dei tentativi di
auto-medicazione, perché possono avere delle serie interazioni con i
medicamenti neurologici, in particolare gli aminoacidi.
4.2.3 Miotonolitici
Sostanze
ortomolecolari coinvolte possono essere:
spasmi B6,
TRE
tremolio TF
scatti B6
Sono
intese come proposte per il neurologo, in nessun caso per tentativi di
auto-medicazione, perché possono avere delle serie interazioni con imedicamenti
neurologici, in particolare gli aminoacidi.
4.2.4 Parasimpatomimetici
(vagotonici)
Sostanze
ortomolecolari coinvolte possono essere:
iperattività
compl.B, compl.min., B1,
B6, Ca, Mg, Zn, o-3, o-6, LE, TRE, GLU
irritabilità B3,
B12, Cu, o-6, PABA
aggressività FOL
ipersensibilità compl.B,
B1, B6, B12, FOL, Ca, Mg, Zn, Fe, TRE, GLU premurosità B3
nervosismo B1,
B6, Fe, GLU
stress cronico *PB, A, Mg, FA, BCCA,ARG, HIS, GLU,
Q10, DMG
*
proteine bassomolecolari
Sono
intesi come proposte per il neurologo, in nessun caso per dei tentativi di
auto-medicazione, perché possono avere delle serie interazioni con i
medicamenti neurologici, in particolare gli aminoacidi e i metaboliti.
4.2.5 Farmaci
contro l¹emicrania
Sostanze
ortomolecolari coinvolte possono essere:
emicrania B6,
E, Mg, Se, o-3
4.2.6 Farmaci
contro il Mb. di Alzheimer
Sostanze
ortomolecolari coinvolte possono essere:
Mb. di Alzheimer compl.B,
B61, B6, B12, FOL, AP, E, Se, o-6, o-3, LE, l-CAR.
4.2.7 Farmaci
contro la sclerosi laterale amiotrofica
Sostanze
ortomolecolari coinvolte possono essere:
sclerosi laterale B12,
Cu, o-6, o-3, LE, BCCA, TRE
Sono
intesi come proposte per il neurologo, in nessun caso per dei tentativi di
auto-medicazione, perché possono avere delle serie interazioni con i
medicamenti neurologici, in particolare gli aminoacidi.
4.3 Psichiatria e relativa psicofarmacologia
La
psichiatria è il ramo ³medico-biologico² della psicologia, essa si occupa
soprattutto del lavoro clinico e dei disturbi che in fasi acute portano al
ricovero. Usano tutta la gamma di strumenti diagnostici e terapeutici
disponibili e applicabili in una clinica:
- Discorsivi.
- Farmacologici.
- Terapie di gruppo.
- Terapie di reintegrazione.
- Interventi ambutoriali e medicazioni
depositarie.
E
curano la collaborazione con le relative istituzioni e i servizi.
Viene
trattato il seguente argomento:
4.3.1 Psicofarmacologia
Il
seguente capitolo segue una classificazione dell¹Associazione dei medici
Svizzeri (FMH). L¹ho trattato un po¹ più per esteso perché girano vere fobie in
merito, assolutamente infondate. Per alternative e ³aggiunte² vedi ³Tavole
psico-ortomolecolari² aggiunte al testo PTO 3 del seminario.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
4.3.1.4 Psicofarmaci
combinati
4.3.1.1 Neurolettici
Impiegati
per:
- Schizofrenia acuta e cronica.
- Agitazione psicotica incluso delirio e
manie.
- Agitazione acuta generica.
- Ansia psicotica (non servono per altre
forme di ansia).
- Ogni tanto in casi di dolori cronici e
come antiemetico (nausea).
Effetti
anticolinergici (inibitori del ramo simpatico del sistema nervoso vegetativo),
inibitori del sistema dopaminergo del sistema nervoso centrale e quindi
sedativi nelle parti:
- della corteccia prefrontale e temporale,
- dei gangli basali,
- del sistema limbico.
4.3.1.2 Sali di litio
Impiegati:
- In fasi maniacali della malattia
maniacale-depressiva.
- Profilassi alla malattia
maniacale-depressiva.
- Malattie depressive unipolari ev. in
combinazione con antidepressiva.
4.3.1.3 Antidepressivi
Gli
antidepressivi sintetici hanno ingiustamente una bruttissima reputazione:
applicati a regola d¹arte sono ³il minor male² terapeutico e rendono la vita di
un tendenzialmente depresso meno ³difficile². Inoltre uno studio epidemiologico
famoso dimostra che in forme di depressioni costituzionali riducono
notevolmente il rischio di tumori (anche sotto il livello della media della
popolazione paragonabile senza inclinazione depressiva).
Sono
trattati i seguenti argomenti:
4.3.1.3.1 Antidepressivi
tri- e tetraciclici
4.3.1.3.2 Inibitori
del riassorbimento di serotonina
4.3.1.3.3 Altri
antidepressivi
4.3.1.3.1 Antidepressivi tri- e tetraciclici
Impiegati
contro tutte le forme depressive indipendentemente dalla classificazione
eziologica e dai sintomi accompagnanti come ansia, panico, insonnia,
agitazione, dolori,
Hanno
effetti molto simili (tri-e tetraciclici): sedativo sul sistema nervoso
centrale e anticolinergico. Il trattamento per certi preparati avviene in modo
progressivo. L¹effetto antidepressivo si nota dopo 24 settimane, gli effetti
sedativi e analgesici prima.
Effetti
collaterali possono essere cardiovascolari e di aumento del peso,
anticolinergici (bocca secca, costipazione, vertigini, palpitazioni, vista
turbata, ritenzione urinaria), alta tossicità acuta (rischio di suicidio) in
alte dosi.
Se
interagiscono con degli inibitori di enzimi, amplificano il loro effetto,
mentre con degli stimolatori di enzimi il loro effetto si riduce. La
combinazione con altri sedativi del sistema nervoso centrale, o con altri
anticolinergici o simpatomimetici, p.es. alcool, può potenziarne l¹effetto a
livello rischioso.
In combinazione con antipertonici, l¹effetto di questi
ultimi viene ridotto.
La
mia critica della medicazione con ³antidepressivi tri-e tetraciclici² da parte
di psichiatri e medici non è alle ³sostanze sintetiche² e neanche al fatto del
loro impiego; in ³forme agitate² può essere razionale l¹impiego di sostanze
sedative. Più critico è l¹impiego in casi dove l¹incentivo (spinta) e l¹intento
(volontà) sono già notevolmente ridotti (stati di esaurimento apatico): il
sedativo acutizza ancora questo stato e rende difficile il riacquisto di
energia. Questo non è a regola d¹arte (e lo incontro spesso nella prassi
terapeutica).
4.3.1.3.2 Inibitori
di riassorbimento di serotonina
Gli
inibitori di riassorbimento di serotonina presentano meno effetti collaterali
spiacevoli che gli antidepressivi tri-e tetraciclici e sono meno rischiosi sotto
il profilo delle intossicazioni; costano però molto di più.
Come
effetti collaterali possono causare dei disturbi gastrointestinali, mal di
testa, irrequietudine, ansia, difficoltà ad addormentarsi. Effetti
cardiovascolari e anticholinergici sono più rari che nei tri-e tetraciclici.
Come
alternative agli inibitori di riassorbimento di serotonina e in casi lievi
possono servire la triptofane, treonina e glicina (mai assieme con degli
antidepressivi sintetici), gli aminoacidi essenziali per la sintesi di
serotonina.
4.3.1.3.3 Altri antidepressivi
Degli altri tipi di antidepressivi servono per
sintomatologie specifiche.
4.3.1.4 Psicofarmaci
combinati
Servono per inibire prevalentemente o il sistema limbico
o il sistema corticale.
4.3.1.5 Disintossicazione
Ci sono dei preparati che aiutano alla disintossicazione
o alleviano i sintomi per:
- Alcool.
- Nicotina.
- Stupefacenti.
4.3.1.6 Psicostimolatori
Ci
sono pochissimi impieghi, perché il potenziale di dipendenza è notevole: narcolepsia
e sindrome ipercinetica nei bambini.
4.3.1.7 Inibitori
dell¹appetito
La
maggior parte è simpatomimetica. Il potenziale di dipendenza è alto, servono
raramente per la cura dell¹obesità, gli effetti collaterali sono numerosi.
4.4 Psicosomatica e relativa farmacologia ³sintomatica²
La
maggior parte dei medici di condotta, terapisti, naturopati e medici
naturalisti praticano una specie di psicosomatica. Questo metodo si è divulgato
anche tramite i mass-media ed è diventato una sorta di ³consenso comune²
sanitario anche se non si chiama così.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
4.4.1 Diagnostica
e trattamento di disturbi psicosomatici
4.4.2 Farmacologia ³psicosomatica
sintomatica²
4.4.1 Diagnostica
e trattamento di disturbi psicosomatici
I
medici trattano i disturbi ³funzionali² senza substrato biologico evidentemente
riconoscibile nei seguenti modi:
- consigliano uno psichiatra o
psicoterapista
- e/o prescrivono farmaci (anche ³naturali²),
contro dolori, ansia, insonnia, eccitazione.
Molti
di loro (con le vigenti restrizioni del tempo di consultazione da parte delle
casse malati) consigliano delle misure di modifiche relazionali o sociali,
comportamentali e ogni tanto prescrivono ³ricostituenti² anche di tipo
ortomolecolare.
4.4.2 Farmacologia
³psicosomatica sintomatica²
Disturbi
di sonno, ansia, stati di tensione nervosa, stress.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
4.4.2.1 Benzodiazepine
(sedativi)
4.4.2.2 Cloralidrati
(sonniferi)
4.4.2.1 Benzodiazepine
(sedativi)
Amplificano
l¹effetto inibitore dell¹acido gamma-aminobutirico (GABA) nel sistema nervoso
centrale e agiscono quindi come sedativi. Diminuiscono quindi gli stati di
tensione nervosa e stimolano il sonno. Certi preparati si usano anche per:
- Attacchi epilettici.
- Sindrome di astinenza alcolica.
- Attacchi di panico.
- Certe forme di schizofrenia.
Secondo
la dose possono crearsi degli effetti di ³troppo sedativo²: stordimento,
confusione, vertigini, amnesie anterogradi, atassia, debolezza muscolare.
In
combinazione con altri sedativi che agiscono sul sistema nervoso centrale
l¹effetto si può amplificare e può ledere delle funzioni vitali: p.es. alcool,
antidepressivi triciclici, antiistaminici, antiepilettici, cloralidrati e
oppiacei. Anche gli inibitori enzimatici possono amplificare l¹effetto. I
contracettivi possono o inibire o amplificare l¹effetto.
Controindicati:
specialmente miastenia gravis e insufficienza respiratoria. L¹applicazione a
breve è poco problematica, cronica può rendere dipendente.
Un
effetto simile alla benzodiazepina (con minimi effetti collaterali) per casi
leggeri è raggiungibile per somministrazione di glutamina (aminoacido),
precursore di GABA (p.es. L-Glutamina BURGERSTEIN).
4.4.2.2 Cloralidrati
(sonniferi)
Un
inibitore enzimatico che abbassa la risposta del sistema nervoso centrale;
usato come ipnotico (sonnifero) e in crampi infantili.
Rari
effetti collaterali possono esserci: nausea, diarrea, reazioni dermiche.
Interazioni
come con le altre sostanze sedative per il sistema nervoso centrale (=>
benzodiazepine).
Controindicazioni:
insufficienza renale, uso regolare.
Alternative
ortomolecolari in certi casi potrebbero essere la L-triptofane o melatonina.
4.4.2.3 Sedativi
e sonniferi
Certi
preparati vengono usati come alternative alle benzodiazepine (sedativi), altre
sostanze si usano prevalentemente in stati di ansia e tensione nervosa come i
sedativi/ipnotici. Anche un preparato fitoterapeutico di Piper methisticum F.
(kava-kava) viene usato con successo.
Controindicazioni:
uso regolare
4.4.2.4 Preparati
combinati
Quelli
inizialmente descritti sono in commercio in combinazione con i barbiturati, la
methaqualone, i fitoestratti e tante altre sostanze. Esistono anche
combinazioni con gli spasmolitici (specialmente per dei disturbi combinati
gastrointestinali).
5.0 Psicoterapie
Per
i vecchi medici il terapeuta disponeva di tre strumenti:
- il tatto, - il rimedio e - la parola.
5.3 Psicoterapie
farmacologiche
5.4 Psicoterapie
verbali (discorsive)
Le
psicoterapie moderne propongono diversi tipi di cura o trattamenti per i
disturbi e le malattie psichiche e/o psicosomatiche. Le forme più divulgate
sono:
- Bioenergetica.
- Terapie familiari.
- Terapie discorsive.
- Psicoterapie di gruppo.
- Terapie ³gestalt² (figura).
- Ipnosi.
- Psicoterapie movimentali.
- Terapie psicomotorie.
- Psicoterapie corporee.
- Musicoterapie.
- Percezione catatimica di immagini.
- Logoterapia.
- Psicoanalisi.
- Terapie sessuali.
- Terapie comportamentali.
- Terapie distensive come il training
autogeno.
- Biofeedback.
- Ergoterapia.
- Socioterapie.
- ...
Sono
trattati i seguenti temi:
5.1.1 Modello
comportamentale-adattivo
5.1.2 Modelli relazionali terapeutici
Vengono
trattati i seguenti temi:
- Modello comportamentale-adattivo.
- Modelli relazionali terapeutici.
5.1.1 Modello
comportamentale-adattivo
Il
seguente modello comportamentale segue una proposta di Grossarth-Maticek:
distingue grossolanamente cinque sistemi di criteri determinanti:
- Criteri dirigenti come le condizioni
biologiche, relazionali e sociali, la vitalità e il sistema sulle aspettative
personali.
- Criteri e caratteristiche
comportamentali.
- Criteri di effetto biologico, psichico,
sociorelazionale.
- Criteri sulla cognizione come la
percezione, la valutazione, l¹interpretazione, l¹immaginazione, la proiezione.
- Criteri sullo stato biologico, d¹animo,
sociorelazionale.
Si
noti che ci sono diversi circoli a diversi livelli che permettono:
- comportamenti di tipo vegetale-reattivo:
effetto-cognizione-comportamento (manca stato e adattamento dirigente),
- fino a ragionati circuiti di
apprendimento: effetto-cognizione-stato-dirigenti-comportamento,
- ma anche di adattamento pragmatico: effetto-cognizione-stato-comportamento
(manca adattamento dirigente),
- come l¹adattamento autolesionistico del
martire: effetto-cognizione-dirigente-comportamento.
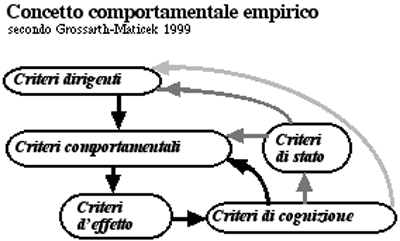
5.1.2 Modelli relazionali terapeutici
Personalmente
e per degli scopi terapeutici con dei temi sociali mi servo di tre mo-delli ³sociocentrati²:
- Io in gruppo.
- Io in relazione con un altro.
- Io tra me e me.
Faccio
terapeuticamente una netta distinzione tra le relazioni ³di coppia² e le
relazioni di gruppo (ruoli), perché sono spesso contrastanti tra di loro e se posso differenziare il ³ruolo² e
l¹³affezione² ciò facilita il discorso sulla complessità relazionale. Può
sembrare ricercato, ma ciò è veramente utile. Per me rappresenta l¹unicol¹unico
criterio per un modello di lavoro.
Faccio
anche notare (per giustificare l¹eresia), che la distinzione relazionale e
sociale deve essere molto vecchia, perché in molte lingue remote (e anche in
diverse recenti) oltre al singolare (io, tu, lui) e il plurale (noi, voi, loro)
viene usata una forma autonoma e distinta dialettica (noi due, voi due, loro
due).
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
5.1.2.1 Io nel mio
ruolo in un gruppo
5.1.2.2 Io in
relazione con un altro
5.1.2.3 Io
tra me e me (relazione con me stesso)
5.1.2.1 Io nel mio ruolo in
un gruppo
Chiamo ³di gruppo² ogni
relazione tra più
di due partecipanti per poter
distinguere e
discutere:
la partita da giocare o il brano da suonare,
o
la parte da recitare
i ruoli dei partecipanti, la parte da recitare
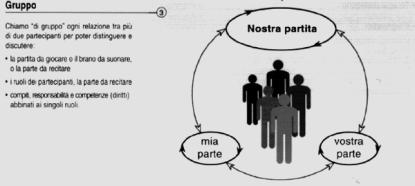
compiti, responsabilità e competenze (diritti)
abbinati
ai singoli ruoli.
5.1.2.2 Io in relazione con
un altro
Chiamo ³di coppia² ogni
relazione tra due
persone per discutere e poter
discutere di:
affari miei
affari tuoi
affari nostri
affari non correlati alla
relazione
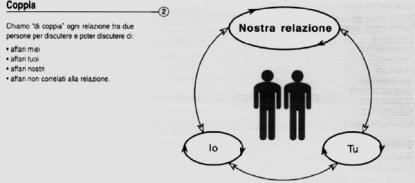
5.1.2.3 Io tra me e me
(relazione con me stesso)
Può
sembrare ³sofisticata² la distinzione di ³Io tra me (Battista) e me (Vaticano).
In realtà è molto utile nel discorso psicoterapeutico poter differenziare tra
³impulsi naturali², ³impulsi culturali² e ³Me² in tramezzo con i compiti di
correlazione, coordinazione e di disposizione.
- Tenerli separati per evitare una ³guerra
civile interna² fra natura e cultura.
- Lasciare a ciascuno le sue competenze
³innate² e non immedesimarmi senza necessità nei compiti sia dell¹uno che
dell¹altro (accettazione di esigenze concorrenziali e ambivalenti non
armonizzabili).
- Soddisfare la ³cultura² (il Vaticano) ma
solo fino al punto che non diventi ³inquisitorio².
- Soddisfare la ³natura² (il Battista) ma
solo fino al punto che non diventi ³bestiale².
Così
con poco sforzo mi tengo libere le spalle per poter tranquillamente terminare
le mie opere e seguire i miei interessi.
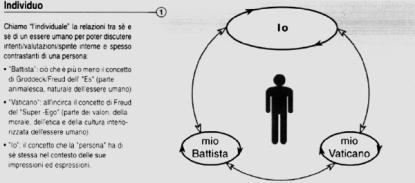
Chiamo ³l¹individuale² la
relazione tra sé e sé
di un essere umano per poter
discutere
intenti/valutazioni/spinte
interne e spesso
contrastanti di una persona:
³Battista²: ciò che è più o
meno il concetto
di
Groddeck/Freud dell¹³Es²
(parte
animalesca, naturale dell¹essere umano).
³Vaticano²: all¹incirca il
concetto di Freud
del
³Super -Ego² (parte dei valori, della
morale,
dell¹etica e della cultura
interiorizzata
dell¹essere umano).
³Io²: il concetto che la
³persona² ha di
sé
stessa nel contesto delle sue
impressioni
ed espressioni.
5.2 Psicoterapie centrate sul corpo
Le
psicoterapie centrate sul corpo usano metodi di tocco come l¹approccio alle
funzioni gestionali psichiche.
Note
come tecniche attive (da eseguire come esercizi da parte del cliente) sono
p.es.:
- Tecniche respiratorie.
- Tecniche distensive.
- Training autogeno.
- Bioenergetica secondo Mindell.
Queste
tecniche possono essere di aiuto in situazioni di stress. Malauguratamente
richiedono parecchio impegno per via dell¹istruzione e del controllo
preliminare e poi dell¹incentivo e della volontà per esercitarli. Clienti con
queste capacità e che hanno dei disturbi psichici sono rari. Esperienze simili
le ho fatte con gli esercizi di Yoga.
Altre tecniche piuttosto ³passive² e spesso applicate
anche per scopi psicoterapeutici sono:
- Vegetoterapia secondo Reich.
- Polarity secondo Stone.
- Integrazione strutturale secondo Rolf.
- Integrazione posturale secondo Painter.
- Massaggio Cranio-Sacrale secondo
Sutherland, Upledger.
- Bio-feedback, inesiologia applicata p.es.
secondo Goodheart.
- Touch for health secondo Thie.
-
L¹effetto
che provocano dipende molto dal terapeuta . Non sarà poi quasi mai la
³psicoterapia corporea² esclusiva, ma la combinazione con psicoterapie
discorsive e l¹uso di rimedi fitoterapeutici e/o ortomolecolari che porta al
successo. Vari di questi metodi non solo richiedono una formazione tecnica
professionale, ma anche un serio approfondimento psicorelazionale: in fasi
acute e latenti nevrotiche e psicotiche possono scatenare delle fortissime
emozioni che il terapeuta inesperto non regge, e questo sarebbe pericoloso.
Nelle forme non invasive, lente e dolci possono invece notevolmente scaricare e
distendere. Nel nostro esercizio ³psicoterapeutico² mancano raramente due ore
di terapie di questo tipo al mese.
Le
terapie processuali come il massaggio psicozonale, il lavoro processuale
(mindell), il rebirthing, regressione, le tecniche di trance, sono
controindicate per i disturbi psichici, in quanto di solito creano più problemi
di quelli che ne risolvono. Avranno un loro valore pedagogico o di sviluppo
spirituale, ma applicate per latenti o acuti seri disturbi psichici e su delle
persone altamente sensibili possono acutizzare i sintomi. Vengo a sapere ogni
anno di parecchi casi che dopo delle sedute simili sono finiti in cliniche
psichiatriche.
Intendo
utilizzare l¹esempio di una terapia mirata sul corpo:
5.2.1 Esempio:
Trattamento kinesiologico degli attacchi di panico secondo Callahan
5.2.1 Esempio:
Trattamento kinesiologico degli attacchi di panico secondo Callahan
Autotrattamento
di stati di panico a causa di fobie e dipendenze secondo Roger J. Callahan.
CALLAHAN,
Roger J.: Leben ohne Phobie, Verlag für angewandte Kinesiologie VAK, D-Freiburg
i.B.
(La
parte seguente si trova anche allegata al materiale didattico in formato A4)
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
5.2.1.1 Trattamento
principale (esercizio da eseguire in caso di un attacco)
5.2.1.2 Trattamento
esteso (esercizio da ripetere 3 volte al giorno)
5.2.1.3 Visualizzazione
(parte del trattamento esteso)
5.2.1.4 Trattamento
dello stress (come aiuto nelle situazioni di tentazione, rischio)
5.2.1.5 Invertimento
psichico (in caso di difficoltà nell¹esercizio principale)
5.2.1.6 Invertimento psichico fluttuante
(in caso di difficoltà nell¹invertimento psichico)
5.2.1.1 Trattamento
principale (esercizio da eseguire in caso di un attacco)
a) Classificare l¹ intensità
della fobia su una scala 1 a 10 (sono calmo, disteso => completamente
impanicato).
b) Battere il punto sotto
l¹occhio (stomaco 1) per 3040 volte immaginandosi che sarebbe bello perdere la
fobia. Se possibile anche il punto indicato sul secondo dito del piede (stomaco
45).
c) Classificare di nuovo
l¹intensità della fobia: se non è diminuita almeno di due punti, procedere con
³Invertimento psichico² 5.2.1.5

5.2.1.2 Trattamento
esteso (esercizio da ripetere 3 volte al giorno)
a) ³Visualizzazione²
(vedi dopo) 5.2.1.3
b) ³Trattamento
principale² (vedi sopra) 5.2.1.1
c) Battere
per 35 volte il punto tra l¹anulare e il mignolo della mano non dominante
(triplice riscaldatore 3) immaginandosi che sarebbe bello perdere la fobia.
d) Classificare
di nuovo l¹intensità della fobia: se non è diminuita almeno di due punti,
procedere con ³Invertimento psichico², se no:
e) Chiudere
gli occhi, guardare prima in basso a destra, poi in basso a sinistra.
f) Ruotare
gli occhi prima in una, poi nell¹altra direzione.
g) Canticchiare una melodia, poi contare fino a 35, poi
canticchiare di nuovo una melodia.
h) Aprire
gli occhi.
i) ³Trattamento
principale² (vedi sopra) 5.2.1.1
k) ³Visualizzazione²
(vedi dopo) 5.2.1.3

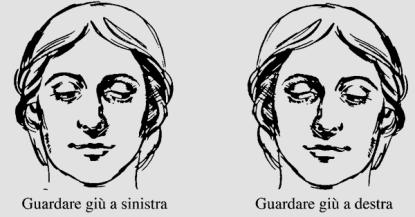
5.2.1.3 Visualizzazione
(parte del trattamento esteso)
a) Immaginarsi
una situazione di tentazione come sarebbe ad essere non fobico o dipendente.
b) Classificare
la difficoltà d¹immaginazione su una scala 1 a 10; se è meno di 3, tornare all¹
esercizio di partenza, se no:
c) Battere
per 10 volte i punti al lato del torace, altezza capezzoli; ev. anche punto
indicato sul ditone.
d) Classificare
di nuovo la difficoltà d¹immaginazione: se non è diminuita almeno di due punti,
procedere con ³Invertimento psichico², se no tornare all¹esercizio di partenza.
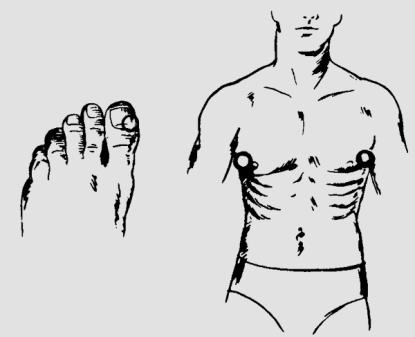
5.2.1.4 Trattamento
dello stress (come aiuto in situazioni di tentazione, rischio)
a) Posizione
eretta, occhi chiusi che guardano verso il basso.
b) Piegarsi
lentamente in avanti mentre contemporaneamente gli occhi fanno il movimento
contrario in modo che alla fine guardano verso l¹alto.
c) Erigersi
lentamente mentre contemporaneamente gli occhi fanno il movimento contrario in
modo che alla fine guardano di nuovo verso il basso.
5.2.1.5 Invertimento
psichico (in caso di difficoltà nell¹esercizio principale)
a) Battere
il punto al lato esterno della mano non dominante, due dita dietro la
protuberanza del mignolo (intestino tenue 3) con il suggerimento:
³Mi
accetto anche se non ho ancora superato la mia fobia².
b) Classificare
di nuovo l¹intensità della fobia: se non è diminuita almeno di due punti,
procedere con ³Invertimento psichico fluttuante², se no tornare all¹esercizio
di partenza.
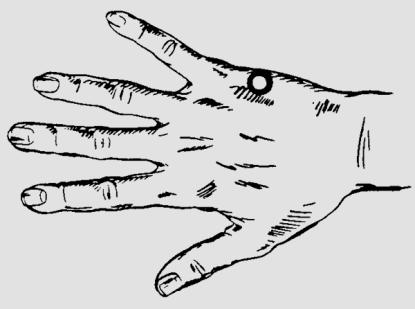
5.2.1.6 Invertimento
psichico fluttuante (in caso di
difficoltà nell¹invertimento psichico)
a) Sfregare i due punti immediatamente sotto la
clavicola sopra i capezzoli con
il suggerimento: ³Mi accetto
malgrado non abbia ancora superato la mia fobia².
b) Tornare
all¹esercizio di partenza.
5.3 Psicoterapie farmacologiche
La
psicosomatica medica, la neurologia e la psichiatria si servono prevalentemente
di questo strumento come descritto sopra. Hanno una bruttissima reputazione e
malgrado questo in forme gravi di psicosi e di nevrosi acute sono
indispensabili, perché rappresentano il minor male. Qui sbagliano spesso i
dilettanti perché non solo sostanze e dosaggio, ma anche introito e abbandono
di psicofarmaci vanno trattati dall¹esperto.
La
brutta reputazione degli psicofarmaci proviene probabilmente dal loro abuso
come medicamenti usati per delle situazioni di stress, noia, tristezza e
insonnia in fasi difficili della vita, interpretate erroneamente come dei
disturbi psichici e trattate smisuratamente e a lungo con dei medicamenti ad
alto potenziale del rischio alla dipendenza. Se penso quanti dei miei clienti
sono stati resi dipendenti dal Rohypnol vent¹anni fa, vado su tutte le furie!
Le
sostanze psicoattive terapeuticamente utilizzabili sono brevemente trattati nel
capitolo 4 di questo testo: ³Medicina gestionale umana².
5.3.1 Micronutrienti e funzionamento
cerebrale
5.3.1 Micronutrienti
e funzionamento cerebrale
È
poco conosciuto dalle nostre parti che molti disturbi psicotici e in rari casi
anche nevrotici sono connessi con dei disturbi metabolici del sistema nervoso
centrale. Essendo coinvolte in questi meccanismi delle sostanze ortomolecolari,
si riesce spesso, a migliorare notevolmente la situazione, il che è il tema
principale di questo seminario. Volendo tentare questa strada in processi
metabolici cerebrali, durante una medicazione con psicofarmaci (che attaccano i
medesimi meccanismi), è consigliabile consultarsi prima con il medico curante
che adatterà volentieri la sua medicazione se riconosce un effetto.
5.4 Psicoterapie verbali (discorsive)
Di
psicoterapie discorsive ce ne sono quasi tante quanti sono gli psicoterapisti.
Di seguito sono trattati tre approcci divulgati:
5.4.1 Terapie
analitiche
Le
terapie analitiche o di profondità si basano originalmente sui lavori di:
- Freud (1856-1939) e la sua psicoanalisi.
- Jung (1875-1961) e la sua psicologia
analitica o complessa o di profondità.
Il
modello di Freud è brevemente descritto sopra, il modello di Jung modifica,
varia e amplia il modello per i seguenti elementi:
- L¹animo (³Selbst², io stesso) si trova al
centro del cosciente tra l¹individuo e la società.
- I due tipi di comportamento:
introversione ed estroversione sono abbinati a quattro tipi funzionali:
riflesso, emozione, sentimento e intuito.
- L¹inconscio è differenziato in:
- Inconscio personale che
somma il dimenticato e lo scostato rimosso (personale) e
- inconscio collettivo
(archetipi) con determinanti comportamentali generali, innate.
- La psiche si crea un equilibrio di
conscio e inconscio tramite delle compensazioni.
- Secondo questa autoregolazione provocano
la formazione dei ³complessi².
Le
terapie analitiche tentano di comprendere dei processi individuali psichici nel
loro contesto culturale. I processi stessi vengono ³analizzati² (dal cliente,
terapeuta o tutte due) con lo strumento della libera ³associazione² e/o con
l¹interpretazione dei sogni. Anche aspetti scomodi e apparentemente
insignificanti o ³assurdi² sono tematizzati.
Le
terapie analitiche ³classiche²:
- Premettono una motivazione per via della
spinta causata dalla sofferenza e le capacità introspettive e di
verbalizzazione.
- Sono applicate a lungo termine da
terapeuti con una specifica formazione (analisi di apprendimento).
- Specialmente in caso di disturbi del tipo
nevrotico.
- Cambiamenti nel cliente sono trattati
allo scopo di renderlo cosciente, attraverso la rianimazione dello
scostato/rimosso e l¹elaborazione di proiezioni.
Applicazioni
modificate sono p.es.:
- Terapie ³focali²: per breve tempo si
resta concentrati su un determinato tema.
- Psicoterapie analitiche di gruppo.
- Neopsicoanalitica, catarsi,
psicodinamica.
5.4.2 Terapie
umanistiche
Il
modello di Rogers e della ³Gestalt²-psicoterapia è accennato sopra. Essendo
³antitetico² alle tradizioni analitiche e ³positivistico/pragmatico², il
modello è stato integrato volentieri nel repertorio dei metodi sociopedagocici
per l¹affinità delle due direzioni circa:
- il veicolo di mutamento (relazione),
- le prospettive di traguardo,
- l¹emancipazione,
- inoltre non pretende altri studi
preliminari.
La
parte della ³guida del discorso terapeutico² è diventata uno strumento
efficace, controllabile e ripetibile in diverse terapie discorsive specialmente
per dei clienti con delle capacità sociali e relazionali sviluppate.
Come
intervento Rogers applica il discorso terapeutico che mira a far
rifunzionare l¹autoattualizzazione
del ³Sé ideale² irrigidito o bloccato (non il disturbo attuale che in questa
ottica è ³solo² un sintomo). La conduzione del discorso da parte del consulente
deve essere:
- Autentica: sincerità, privo di
bigotteria, che crea fiducia.
- Di stima positiva: rispetto e dignità,
non invadente, che crea un ambiente privo di paura e ricatto, che stimola il
cliente ad affrontare le proprie emozioni ed esperienze.
- Dedizione comprensiva: darsi da fare per
vedere il mondo con gli occhi del cliente, chiede se le sospettate emozioni
erano presenti, verbalizza emozioni. fornisce al cliente un modello di
trattamento ³autoesplorativo².
5.4.3 Terapie
comportamentali
Le
terapie comportamentali hanno ancora spesso la reputazione di un primitivo
³behaviorismo² meccanistico e di riflesso condizionato dei cani di Pavlow nella
prima metà del secolo scorso. Daltronde non è negabile che delle mirate,
differenziate e individualizzate terapie comportamentali riescono spesso a
cambiare delle situazioni ³disperate² in delle situazioni vivibili in modo più
economico.
Di
seguito presenterò (in stile telegrafico) un approccio di:
GROSSARTH-MATICEK,
R.: (descritto fra l¹altro in: Systemische Epidemiologie und präventive
Verhaltensmedizin chronischer Erkrankungen, de Gruyter 1999).
5.4.3.1 Esempio: modello di terapia
comportamentale secondo Grossarth
5.4.3.1 Esempio:
modello di terapia comportamentale secondo Grossarth
Sembrerà
strano che un epidemiologo che da quasi quarant¹anni lavora sui nessi tra
comportamento/stile di vita e malattie croniche abbia sviluppato una specie di
³terapia comportamentale². Non lo è, perché per valutare scientificamente
l¹incidenza p.es. dello ³stress² sull¹evoluzione di una malattia cronica,
doveva:
- primo disporre dei parametri per
determinarla e
- poi di strumenti per influenzare
³economicamente² e a lunga durata (fino alla morte) lo ³stress² di tante
persone (decine di migliaia),
- per poterlo confrontare con delle persone
non ³trattate².
Questo
perché l¹epidemiologia si basa su dati clinici della malattia, sulle abitudini
di vita, sui comportamenti e anni di sopravvivenza delle persone osservate.
Un
ragionamento basilare di Grossarth era che misurare lo stress momentaneo di una
persona, non aveva alcun significato per i suoi studi, perché durante tutta la
vita e fino alla morte quella persona avrà periodi più o meno stressanti.
Quindi bisognava trovare degli indicatori comportamentali che sull¹arco di un
lungo periodo promettevano una grande o una piccola ³tolleranza allo stress².
Quel comportamento che lascia vivere l¹uno pacificamente in mezzo a enormi
casini mentre un altro annega in un bicchiere d¹acqua. Per scoprire con poco
impegno chi reagiva in quale modo egli ha sviluppato tre ³strumenti² che lui
stesso chiama:
- Questionario sull¹autoregolazione.
- Questionario per rilevare il grado del
piacere e del benessere.
- Questionario per la classificazione della
tipologia comportamentale.
Con
questi strumenti (e un po¹ di altri, meno importanti nel nostro contesto)
riuscì a scoprire dei tipici meccanismi individuali che impedivano in
continuazione comportamenti con esiti soddisfacenti e/o provocavano quelli con
esiti frustranti. Discutendo (con criteri simili a quelli di Rogers della
³Gestalt²-psicoterapia) questi meccanismi con il suo cliente e consultandosi su
specifiche alternative comportamentali (sempre proposte dal cliente) dava ³un
colpo di mano² al suo cliente (oggetto della sua ricerca) non solo a rendersi
conto di un suo meccanismo comportamentale, ma anche valutando delle pratiche e
realizzabili possibilità di modificarlo.
L¹interesse
del ricercatore di riuscire nel suo intento era naturalmente grandissimo,
perché doveva crearsi un gruppo di paragone per il suo studio. In più il metodo
doveva essere efficace perché costa fare ³terapia gratuita per curiosità del
ricercatore² ed erano poi coinvolti centinaia di suoi collaboratori nel
progetto (perché erano decine di migliaia i partecipanti ³clienti²). In media
c¹era un impegno di ca. 2.5 ore nella parte che lui chiama:
- allenamento all¹autonomia.
È
evidente che questo lavoro oltre a interessantissimi dati per comprendere
meglio alcune malattie croniche come tanti tipi di tumori, malattie psichiche,
cardiovascolari, allergie, ha fornito anche un ricco bagaglio di conoscenze
su meccanismi comportamentali connessi sia con fatti biologici che con
condizioni e possibilità culturali.
(Ciò
che segue è anche riportato in altra forma come allegato nei ³strumenti
didattici²).
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
5.4.3.1.1 Questionario
sull¹autoregolazione
5.4.3.1.2 Questionario
per rilevare il grado del piacere e del benessere
5.4.3.1.3 Questionario per la classificazione della tipologia comportamentale
5.4.3.1.4 Questionario
differenziato per distinguere i tipi 1, 2 e 4
5.4.3.1.5 Terapia
comportamentale: allenamento all¹autonomia
Dalle
pubblicazioni di Grossarth è stato possibile dedurre il seguente modello
comportamentistico:
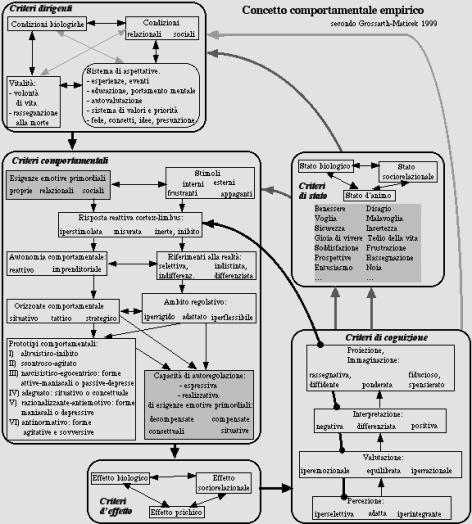
5.4.3.1.1 Questionario
sull¹autoregolazione secondo Grossarth
Si
tratta di 50 domande alle quali rispondere con punteggi da 1 a 6. La somma del
³punteggio divisa per 50 dà un valore medio che permette di valutare la
capacità di autoregolazione che si situa tra molto scarsa e molto buona. Questo
indicatore permette:
- di
valutare grossolanamente il rischio e la ³tolleranza² allo stress;
- di valutare la necessità di
intervento in questa direzione:
- inferiore a 3: intervento
raccomandato,
- tra 34: intervento consigliabile,
- superiore a 4: intervento
superfluo;
- di dedurre (in base alle risposte
specifiche) dove sono i comportamenti critici per l¹autoregolazione e
- di seguito stimolare discorsi
inventivi e creativi sulle possibilità di migliorarli con il minimo sforzo;
- controllare dopo un certo tempo il
risultato.
Un
riassunto del questionario come strumento pratico per un esercizio nel
seminario si trova sotto forma di tabella negli allegati.
1. Parlo con altri dei miei problemi e desideri
psicologici e personali.
Con
quale frequenza lo fa?
1
= molto raramente, 2 = raramente, 3 = mediamente, 4 = piuttosto frequentemente,
5 = frequentemente, 6 = molto frequentemente.
2. Sono attivo/a in un modo per me piacevole (es:
nello sport, sul lavoro, nel rapporto di coppia, ecc.).
Con
quale frequenza realizzo questa condizione?
1
= molto raramente, 2 = raramente, 3 = mediamente, 4 = piuttosto frequentemente,
5 = frequentemente, 6 = molto frequentemente.
3. Con
il mio comportamento verso persone per me affettivamente importanti
posso mantenere la mia indipendenza interiore.
Con
che intensità questo comportamento le è conforme?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
4. Generalmente la manifestazione e la
soddisfazione dei miei desideri e bisogni affettivi si manifestano come segue:
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
5. Quando il mio equilibrio interiore è turbato e
il mio benessere scarso, sviluppo delle attività che mi riportano in equilibrio
e migliorano il mio benessere.
Come
valuta questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = scarso, piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
6. Se ho problemi nei rapporti interpersonali
sviluppo attività fino al punto in
cui li ho sotto controllo.
In
quale misura riconosce in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
7. Modifico il mio comportamento fino al punto in
cui raggiungo risultati per me soddisfacenti.
Con
che forza è presente in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
8. Con il mio comportamento creo delle condizioni
che mi stimolano in modo piacevole (es: rapporti interpersonali e sfera
fisica).
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
9. Di regola evito eccessi .
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = scarsa, piuttosto debole,
4
= scarsa, piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
10. Prego Dio affinché mi aiuti a
superare i miei problemi.
Con
quale frequenza si comporta in questo modo?
1
= molto saltuariamente, 2 = saltuariamente, 3 = scarsamente, piuttosto
saltuariamente, 4 = scarsamente, piuttosto frequentemente,
5
= frequentemente, 6 = molto frequentemente.
11. Prendo le distanze da persone che
non soddisfano pienamente le mie aspettative affettive.
In
che forza è in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
12. Ho stima di me stesso/a.
Qual
è la forza in lei di questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
13. La mia vita ha un senso e mira a un
obiettivo.
Che
forza ha questa convinzione in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
14. Mi nutro con un senso di benessere.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
15. Pratico un¹attività fisica in un
modo da trarne benessere.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
16. Mi distanzio da circostanze e
condizioni che alla lunga non mi fanno bene.
Che
forza ha in lei questo
comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
17. Organizzo la mia vita quotidiana in
modo che possa continuamente rilassarmi.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
18. Quando mi trovo in uno stato
psichico negativo non mi rassegno ma sviluppo attività per superarlo.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
19. Mi comporto in modo da soddisfare
miei bisogni, e con beneficio degli altri.
Che
forza ha in lei questo
comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
20. Armonizzo i modi di comportamento nei vari campi
della mia vita in modo da portare
a uno stato di benessere duraturo (es: alimentazione, lavoro, movimento,
rapporto con il partner).
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
21. Mi osservo in relazione al mio
stato fisico.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
22. Mi osservo in relazione al mio
stato psichico.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
23. Osservo le conseguenze del mio
comportamento in me e negli altri.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
24. Immagino diversi modi di
comportamento che posso adattare se il mio attuale comportamento causa
insuccesso.
Qual¹è
la forza in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
25. Conformo il mio comportamento alle
conseguenze,ossia abbandono modi
di comportamento che portano a conseguenze negative e mantengo modi di
comportamento con conseguenze positive.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
26. Se provo un insuccesso, non mi
lascio sconvolgere,ma lo interpreto quale segnale che in futuro devo fare
altrimenti.
Che
forza ha in lei questo comportamento ?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
27. Giornalmente svolgo diverse
attività che mi fanno bene e si completano tra di loro.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
28. Se non posso stabilire un contatto
con una persona affettivamente importante, allora la lascio.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
29. Vivo contento/a e rilassato/a con
una persona per me affettivamente importante oppure anche senza di lei.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
30. Mi adopero di continuo per trovare
nuovi punti di vista e di comportamento che facilitino la soluzione di problemi
inaspettatamente.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
31. Il mio comportamento è indipendente
da chiunque alla lunga mi porti degli svantaggi.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
32. Con il mio comportamento realizzo
uno stato d¹animo buono emotivamente.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
33. Con il mio comportamento raggiungo
spesso una sensazione fisica piacevole.
Con
che forza vale questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
34. Mi affido di regola al mio intuito.
Che
forza ha questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
35. Con il mio comportamento raggiungo
un appagamento interiore.
Che
forza ha in lei questo comportamento?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
36. Con il mio comportamento raggiungo
sovente uno stato emotivo euforico.
Con
che forza vale questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
37. Se qualcuno mi minaccia o mi
irrita,so manifestare le mie aggressioni in modo conforme.
Che
forza ha questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
38. Se determinate persone mi attaccano
in modo ingiustificato, modifico il mio atteggiamento quanto basta per
difendermi con successo.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
39. Se qualcuno mi critica in modo
giustificato, cerco di modificare positivamente il mio comportamento.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
40. Cerco di regola persone e
circostanze che mi facciano bene.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = molto debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
41. Non rimango incollato a persone e
circostanze per me non benefiche, e prima o poi mi stacco da loro.
Che
forza haquesto comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 =molto forte.
42. Abbandono pensieri e modi di
comportamento che mi inibiscono.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
43. Quando ho problemi personali li
dichiaro a me stesso/a e agli altri.
Con
che forza vale questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
44. Se ho problemi, non esito a
chiedere aiuto agli altri.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
45. l mio comportamento è sempre finalizzato
al piacere e benessere derivanti dalla miglior soluzione possibile di un
problema. Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
46. Non porto rancore e perdono
facilmente.
Che
forza ha questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
47. Osservo
di continuo i processi nel mio corpo per scoprire cosa mi fa bene.
Con
che forza vale questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
48. Osservo di continuo i miei rapporti
con gli altri, nell¹intento di sviluppare forme di comportamento ottimali.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
49. Se sono inibito a esprimere i
desideri e le aspettative, sviluppo le mie attività fino a superare
l¹inibizione.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
50. Se sono agitato/a o arrabbiato/a
interiormente, sviluppo attività per raggiungere uno stato che sciolga tale
tensione.
Che
forza ha questa affermazione per lei?
1
= molto debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole,
4
= piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte.
Valutazione.
I
punti di tutte le domande vengono sommati e poi divisi per 50. Più alto è il
punteggio e più spiccata è l¹autoregolazione.
Valore
medio 5-6 punti autoregolazione
molto buona
Valore
medio 4-5 punti autoregolazione
buona
Valore
medio 3,5-4 punti autoregolazione
media,
piuttosto
buona che non scarsa
Valore
medio 3-3,5 punti autoregolazione
media,
piuttosto
scarsa che buona
Valore
medio 2-3 punti autoregolazione
scarsa
Valore
medio 1-2 punti autoregolazione
molto scarsa.
5.4.3.1.2 Questionario
per rilevare il grado del piacere e del benessere
Si
tratta di 15 domande alle quali rispondere con con punteggi da 1 a 7. La somma
del punteggio diviso per 15 dà un valore medio che permette di valutare la
capacità di piacere e di benessere. Essendo queste le risorse per compensare le
frustrazioni della vita, questo indicatore permette:
- Di valutare grossolanamente le
capacità per vivere del piacere e del benessere;
- Di valutare la necessità di
intervento in questa direzione:
- inferiore a 3:
intervento raccomandato,
- tra 34: intervento
consigliabile,
- superiore a 4:
intervento superfluo;
- di dedurre (in base alle risposte
specifiche) dove sono i maggiori inibitori per vivere piacere e benessere e
- di seguito stimolare discorsi
inventivi e creativi sulle possibilità di migliorare la situazione con il
minimo sforzo;
- controllare dopo un certo tempo il
risultato.
Un
riassunto del questionario come strumento pratico per un esercizio nel
seminario si trova in forma di tabella negli allegati.
Nota
introduttiva
Le
verranno proposte 15 domande per rilevare il grado del suo benessere e la sua
capacità di piacere. Nelle risposte si concentri, sugli ultimi 12 mesi e
risponda mediando le situazioni di benessere e di piacere.
Nel
questionario si distingue tra benessere e piacere, definendo piacere come un
benessere accentuato (per es: benessere estremo,quale evento felice e
entusiasmo). Per benessere si intende il raggiungimento di un equilibrio
interiore che viene vissuto come una cosa piacevole che trasmette sicurezza.
1. Con che forza vive il piacere (contentezza appagante,
benessere sensuale, soddisfazione di un bisogno, attività dilettevole, per es.
sport, sessualità mangiare ecc.)?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole, il mio piacere è completamente bloccato, 2 = debole, 3 =
piuttosto sul debole, 4 = piuttosto sul forte, 5 = forte,
6
= molto forte,7 =estremamente forte, il mio piacere è estremo).
2. Quanto dura il suo piacere quando si manifesta?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= molto breve, pochi secondi, 2 = breve, qualche minuto, 3 = piuttosto breve, 4
= piuttosto a lungo, 5 = a lungo,
(per es: mezza giornata), 6 = molto a lungo (per es: un giorno intero), 7 =
estremamente a lungo (per es: più giorni).
3. Con che frequenza prova piacere (piacere stimolante o
distensivo, rilassamento (per es: sport, sonno, sessualità, soddisfazione
appagante))?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= quasi mai, 2 = pochissime volte (per es: una volta al mese), 3 = talvolta, ma
piuttosto raramente che spesso, 4 = piuttosto spesso raramente, 5 = spesso, 6 =
molto spesso (per es: quasi giornalmente),
7
= spessissimo, almeno giornalmente.
4. Rinuncio a un piacere di breve durata se per questo devo
accettare conseguenze negative di lunga durata, lo faccio nella certezza che
più tardi subentrerà un piacere più grande.
Che
forza ha questo comportamento in lei?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole, 2 = debole, 3 = piuttosto sul debole,
4 =
piuttosto sul forte, 5 = forte, 6 = molto forte, 7 = estremamente
forte).
5. Ha paura prima di provare piacere, soprattutto in ambiti
nei quali è per lei di grande importanza affettiva (per es. nell¹amore)?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= paura assoluta, che impedisce totalmente il piacere, 2 = paura molto forte,
il piacere si afferma molto raramente, 3 = paura forte, il piacere c¹è, ma più
inibito che manifestato, 4 = paura media, in cui il piacere riesce ad imporsi,
5 = paura debole, il piacere si manifesta sempre liberamente e pienamente, 6 =
paura molto debole, il piacere si manifesta sempre pienamente, 7 = paura nulla,
il piacere prospera.
6. Quale grado di certezza ha che in futuro proverà sempre
piacere (appagamento)?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole, 2 =debole, 3 = piuttosto debole, 4 = piuttosto forte, 5
= forte, 6 = molto forte, 7 = assolutamente sicuro).
7. Crede che potrà riprovare in futuro l¹apice del piacere
raggiunto in passato?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole, 4 = mediamente,
piuttosto forte, 5 = forte, 6 = molto forte, 7 = assolutamente sicuro).
8. Con che intensità vive il
benessere?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole (il mio benessere è completamente bloccato), 2 = debole,
3 = scarso, piuttosto debole, 4 = scarso, piuttosto forte,
5
= forte, 6 = molto forte, 7 = estremamente forte).
9. Quanto dura il suo benessere quando si manifesta?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= molto breve, solo pochi secondi, 2 = breve, solo pochi minuti,
3
= scarso, più breve che lungo, 4 = scarso, più lungo che breve,
5
= dura a lungo, per es.un giorno intero, 6 = dura molto a lungo, per più
giorni, 7 = perdura per giorni, quasi ininterrottamente.
10. Con
quale frequenza prova benessere?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= quasi mai, 2 = raramente, solo una volta al mese, 3 = talvolta, piuttosto di
rado che frequentemente , 4 = scarsa, più frequentemente che di rado, 5 =
spesso, 6 = molto spesso, giornalmente, 7 = oltremodo spesso, più volte al
giorno).
11. Rinuncio a un
benessere di breve durata se per questo devo accettare conseguenze negative di
lunga durata. Lo faccio nella certezza che più tardi subentrerà un benessere
più grande.
Qual
è la forza di questo comportamento in lei?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole, 2 = debole, 3 = scarsa, piuttosto sul debole, 4 =
scarsa, piuttosto sul forte, 5 = forte, 6 = molto forte,
7
= estremamente forte).
12. Quando si
manifesta benessere, lei si comporta in modo da distruggerlo?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= quasi sempre, 2 = molto spesso, 3 = spesso, 4 = piuttosto spesso, 5 =
piuttosto raramente, 6 = raramente, 7 = molto di rado, quasi mai).
13. Qual¹è il grado
di certezza che in futuro proverà sempre benessere?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole, 4 = piuttosto forte, 5
= forte,6 = molto forte, 7 = assolutamente sicuro).
14. Crede
di poter ancora raggiungere in futuro il massimo grado di benessere provato in
passato ?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= estremamente debole, 2 = debole, 3 = piuttosto debole, 4 = piuttosto forte, 5
= forte, 6 = molto forte, 7 = assolutamente sicuro).
15. Con quale
frequenza subentrano in lei dopo un¹esperienza di piacere, conseguenze
negative, (per es. sentimenti di colpa, cattiva coscienza, depressioni, sintomi
fisici) ?
1
2 3 4 5 6 7
(1
= quasi sempre, 2 = molto spesso, 3 = di frequente, 4 = scarsa, piuttosto sul
frequente, 5 = scarsa, piuttosto raramente, 6 = raramente, 7 = molto raramente,
quasi mai).
Valutazione
Il punteggio del questionario su benessere e capacità di piacere, risulta
sommando i punti delle domande e dividendo il totale delle stesse per 15.
1-2 punti benessere
e piacere molto debole
2-3 punti benessere
e piacere debole
3-3,5 punti benessere e piacere
più debole che forte
3,5-4 punti benessere e piacere
più accentuato che debole
4-5 punti benessere
e piacere accentuato
5-6 punti benessere
e piacere molto accentuato
6-7 punti benessere
e piacere estremamente accentuato.
5.4.3.1.3 Questionario
per la classificazione della tipologia comportamentale
Si
tratta di ca. 70 domande alle quali rispondere con ³sì² o ³no² secondo il
³Questionario per la classificazione della tipologia comportamentale.
5.4.3.1.3.1 Tipo
1 ³altruistico-inibito²
5.4.3.1.3.2 Tipo
2 ³scontroso-agitato²
5.4.3.1.3.3 Tipo
3 ³narcisistico-autocentrato²
5.4.3.1.3.5 Tipo
5 ³razionalizzante-antiemotivo²
5.4.3.1.3.6 Tipo
6 ³antinormativo²
Il
conteggio dei punti secondo l¹istruzione permette di rivelare dei meccanismi
tipici di comportamento (stereotipi). Nel materiale didattico allegato si
trovano dei moduli per la valutazione. Il Grossarth descrive la valutazione
come segue:
Chiave
di valutazione
Nelle
domande del Tipo 1 fino al Tipo 3 una risposta affermativa è valutata con un
punto.
Nelle
domande del Tipo 4 una risposta affermativa alle prime 10 domande è valutata
con un punto. Una risposta affermativa alle rimanenti 11 domande porta alla
detrazione di un punto.
Nelle
domande del Tipo 5 e 6 l¹affermazione è valutata con un punto.
a) La persona fa parte del Tipo dove
ha totalizzato maggior punteggio.
b) Se la persona ha totalizzato più
punti sul Tipo 1, 2, e 5 che nei Tipi 3, 4, 6, parliamo di espressione
egocentrica inibita, assimilabile a un disstress.
c) Se la persona ha totalizzato più
punti nei Tipi 3, 4, 6 che nei Tipi 1, 2, 5, allora si parla di espressione
egocentrica attiva.
d) Se la persona non ha totalizzato in
nessun Tipo più di un punto, parliamo di espressione egocentrica estremamente
bloccata. Se in nessun Tipo non si hanno più di 2 punti siamo in presenza di
un¹espressione egocentrica inibita.
Nel
materiale didattico allegato come nei capitoli seguenti si trova anche un
riassunto tipologico che tratta i seguenti argomenti:
- Tipo comportamentale:
secondo Grossarth-Maticek
Forme: a) b)
- Esigenze di distanza-vicinanza persone,
gruppi, mete.
- Situazioni provocate dal comportamento
stereotipico (reattivo).
- Inibizione-promozione di attività
autonome (autoattivo).
- Relazioni, socializzazione.
- Reazione d¹emergenza.
- Stati psichici in fasi compensate.
- Stati psichici in fasi decompensate.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
- Tipo 1 ³altruistico-inibito².
- Tipo 2 ³scontroso-agitato².
- Tipo 3 ³narcistico-autocentrato².
- Tipo 4 ³adeguato²
- Tipo 5 ³razionalizzante-antiemotivo².
- Tipo 6 ³antinormativo².
Questionario
per la classificazione della tipologia secondo Grossart
Prima
di rispondere al seguente questionario, la prego di concentrarsi soprattutto
sulle esperienze piacevoli e spiacevoli della sua vita. Provi a ricordare come
si è comportato/a nelle due situazioni.
Molte delle prossime affermazioni si basano su
comportamenti tipici in situazioni di particolare significato emotivo. Se una
osservazione corrisponde al vero oppure si avvicina, allora risponda con ³sì²,
e si assegni un punto. Se non corrisponde o vi si allontana, risponda con ³no²,
e non si assegni nessun punto.
5.4.3.1.3.1 Tipo 1 ³altruistico-inibito²
1. Sono specialmente impedito a rivendicare
diritti.
2. Piuttosto che avanzare pretese, do retta
agli altri.
3. Mi comporto secondo le aspettative delle
persone che mi sono vicine, piuttosto che secondo i miei desideri.
4. Per il mantenimento di uno stato di
fatto, rinuncio ai miei desideri (per es. l¹armonia interpersonale).
5. Per anni non sono stata/o capace di far
capire ad altre persone i miei sentimenti e le esigenze più importanti.
6. Da anni sopporto, senza protestare,
condizioni che mi danneggiano.
7. Sono fortemente inibito/a ad esternare
sentimenti negativi, per es. rabbia, odio e aggressione.
8. Tendo possibilmente a non esternare
scosse emotive.
9. Se le mie attese emotive sono deluse mi
sento interiormente bloccata/o.
10. Dopo degli avvenimenti infelici, quali
morte di una persona cara, separazione, schok non sono capace di esprimere i
miei sentimenti e i miei desideri più importanti.
Esigenze di distanza-vicinanza persone, gruppi,
mete:
nostalgia
di nuove vicinanze indeterminate.
Situazioni
provocate dal comportamento stereotipico (reattivo):
conserva
l¹intimità esistente, impedisce nuovi approcci.
Inibizione-promozione
di attività autonome (attivo):
inibito,
espressione di pretese ma aspettative passive verso l¹ambiente.
Relazioni,
socializzazione:
cerca
armonia anche a discapito di soddisfazioni proprie (altruismo).
Reazione
d¹emergenza:
disperazione,
apatia, depressione, paralisi psichica.
Stati
psichici in fasi compensate:
un
po¹ inibito, calmo adattato, altruistico, cerca l¹armonia, nostalgico di
intimità indeterminate.
Stati
psichici in fasi decompensate:
la
nostalgia dell¹intimità indeterminata cerca risposta nell¹altruismo fino
all¹esaurimento con depressioni durature, disperazione e apatia.
4.3.1.3.2 Tipo 2 ³scontroso-agitato²
1. Da anni protesto contro situazioni che
non mi fanno bene, ma non sono capace di modificarle.
2. Determinate persone sono da sempre la
causa più importante della mia infelicità.
3. Determinate situazioni sono da sempre la
causa più importante delle mie disgrazie.
4. Sono sempre in balia di persone o
condizioni negative (es. non sono capace di cambiare la situazione né di
esserne abbastanza distaccato/a).
5. Vengo a contatto continuamente con le
qualità negative di persone o situazioni.
6. Certe persone mi disturbano e ostacolano
lo sviluppo della mia personalità.
7. Determinate situazioni mi disturbano e
ostacolano di continuo lo sviluppo della mia personalità.
8. Non posso modificare la causa di
agitazioni e tensioni continue, perché insite nel comportamento di altre
persone.
9. Non posso modificare la causa di
agitazioni e tensioni continue, perché proprie di situazioni su cui non posso
influire.
10. Formulo le mie intenzioni e le mie mete,
ma mi sento impedito/a dall¹esterno nella loro realizzazione.
Esigenze
di distanza-vicinanza persone, gruppi, mete:
nostalgia
di distacco indeterminato.
Situazioni
provocate dal comportamento stereotipico (reattivo):
impedisce
distanziamento e rotture concrete.
Inibizione-promozione
di attività autonome (attivo):
eccitato
da pretese e aspettative, quindi inibito ad agire in modo mirato.
Relazioni,
socializzazione:
perfezionismo
e critica con latente aggressività e sensi di importanza.
Reazione
d¹emergenza:
eccitato,
commosso, agitato, squilibrio interno.
Stati
psichici in fasi compensate:
tendenza
a scaldarsi, agitarsi, critica e valutazioni smisurate, risposte con
adattamento e successo p.es. professionale.
Stati
psichici in fasi decompensate:
crollo
dell¹equilibrio interno ³se i fatti sono ancora peggio del pretesto² e reazioni
di panico.
5.4.3.1.3.3 Tipo 3 ³narcisistico-autocentrato²
1. Anzitutto sono concentrato/a su di me, in
modo egocentrico.
2. Dal mio partner fuggo regolarmente da un
rapporto di grandissima lontananza in una vicinanza opprimente, e viceversa.
3. Nel valutare persone o situazioni passo
da un estremo all¹altro a seconda che mi senta sostenuto/a o anche minimamente
disturbato/a
4. Se in una situazione mi sento a disagio o
minacciato cerco con ogni mezzo l¹aiuto di altre persone, inducendole ad es.ad ascoltarmi o
prendersi cura di me.
5. Se una persona per me affettivamente
importante mi ferisce, anche solo lievemente, prendo subito le distanze da lei.
6. Da altri esigo comportamenti morali
rigorosi (per es. fedeltà assoluta) che per me però non hanno alcuna validità.
7. I miei desideri personali li esprimo e li
soddisfo per lo più con un atteggiamento anticonformista (per es. un
atteggiamento scioccante per altre persone o che provoca resistenza).
8. Le aspettative affettive da altre
persone, devono essere subito corrisposte.
9. Posso realizzare situazioni che mi
soddisfano pienamente solo fuori dalle norme e dalle aspettative vigenti.
10. Non appena determinate persone diventano
affettivamente importanti, avanzo delle pretese esagerate (per es. non
lasciarmi mai o vattene subito!).
Forme: a) Maniacali b) Depresse
Esigenze
di distanza-vicinanza persone, gruppi, mete:
ambiguità
di esigenze interminate di vicinanza/distacco.
Situazioni
provocate dal comportamento stereotipato (reattivo):
rotture/amalgamenti
vacillanti.
Inibizione-promozione
di attività autonome (attivo):
ambiguità
tra brevi fasi di inibizioni, di dinamismo e di serenità.
Relazioni,
socializzazione:
egocentrico
e socialmente poco adattato.
Reazione
d¹emergenza:
intensi
e duraturi sensi di paura e di ansia.
Stati
psichici in fasi compensate:
finché
l¹ambiente partecipa al gioco vacillante, riesce a soddisfare sempre nuove
pretese.
Stati
psichici in fasi decompensate:
se
il gioco non funziona più si sviluppano ansie e paure massicce e aggressioni
verso se stesso e gli altri.
5.4.3.1.3.4 Tipo 4 ³adeguato²
1. La mia attività quotidiana, suscita in me
piacere.
2. Se non posso realizzare il contatto con
una persona affettivamente importante, sono capace di abbandonarla moralmente.
3. Verso importanti figure di riferimento
sono in grado di stabilire con il mio comportamento l¹auspicato contatto e il
necessario distacco.
4. Se il mio comportamento non porta al
successo desiderato, so di trovare e sperimentare nuovi comportamenti.
5. Posso vivere contento/a e rilassato/a con
o senza una persona importante affettivamente.
6. Sono in grado di modificare il mio
comportamento attraverso le conseguenze verificatesi, abbattendo cioè quei
comportamenti che portano a conseguenze negative durature, e incrementando quei
comportamenti che portano a lungo termine conseguenze positive e piacevoli.
7. Sono capace di trovare punti di vista e
modi di comportamento nuovi che rendono possibili una soluzione inaspettata e
gradita dei problemi.
8. Nel mio comportamento sono indipendente,
cioé non dipendo da nessuno a mio discapito a lungo termine.
9. Se il mio comportamento porta a un
insuccesso, non è mai per me motivo di rassegnazione, ma stimolo per cambiare.
10. Se determinate situazioni non mi sono
favorevoli, con il mio comportamento riesco di regola a cambiarle
positivamente.
11. Non posso essere contenuto/a e vivere
rilassato/a né con né senza una determinata persona.
12. Non posso essere contento/a e rilassato/a
interiormente né in un determinato stato (per es. ho bisogno del mio posto di
lavoro ma non sono felice), né senza di esso.
13. Vengo spesso dominato/a da pensieri
negativi che mi sconvolgono.
14. Anche se la mia relazione con determinate
persone porta sempre a conseguenze negative non sono in grado di cambiarla.
15. Anche se una determinata situazione (per
es. sul posto di lavoro) porta sempre a conseguenze negative, non riesco a
cambiarla.
16. Sebbene un determinato stato fisico (per
es. sovrappeso) comporta sempre conseguenze negative non sono in condizione di
cambiarla.
17. Riesco raramente a rilassarmi fisicamente
e psichicamente: ciò significa che internamente sono per lo più teso.
18. Con il mio comportamento non so creare
condizioni che mi rendono contento/a.
19. Preferirei morire anziché vivere.
20. Sono in balia di scosse emotive
difficilmente sopportabili (per es. depressioni, angosce ecc.).
21. So entusiasmarmi: per es. solo raramente.
Esigenze
di distanza-vicinanza persone, gruppi, mete:
ambivalenza e mutazioni gestite secondo il caso o il concetto.
Situazioni
provocate dal comportamento stereotipato (reattivo):
espressione/soddisfazione di esigenze variabili.
Inibizione-promozione
di attività autonome (attivo):
spesso sereno, equilibrato e soddisfatto, senza grandi o lunghi sbalzi.
Relazioni,
socializzazione:
socialmente adattato, capace di soddisfare esigenze proprie e altrui.
Reazione
d¹emergenza:
attivissimo, con strategie che mirano a un nuovo equilibrio interno.
Stati
psichici in fasi compensate:
serenità.
Stati
psichici in fasi decompensate:
per
via della sviluppata capacità autoregolativa, non si sviluppano fasi
decompensate durature.
5.4.3.1.3.5 Tipo 5 ³razionalizzante-antiemotivo²
1. Riesco a manifestare i miei sentimenti
solo se c¹è una motivazione razionale.
2. Mi è molto difficile esprimere i miei
sentimenti perché ogni pro ha un contro.
3. Il mio comportamento è esclusivamente
razionale e quasi per niente emozionale.
4. A aspettative emozionali di qualcuno,
rispondo in modo razionale e mai emozionale.
5. Sono del tutto incapace di informare il
mio comportamento ai moti effettivi.
6. Il mio comportamento non è mai stato
guidato da sentimenti al punto di essere considerato irragionevole.
7. Mi sforzo sempre di fare quello che è
ragionevole e logicamente esatto.
8. Cerco di manifestare e soddisfare i miei
bisogni esclusivamente attraverso comportamenti oggettivi e razionali.
9. Cerco di risolvere i miei problemi con
comportamenti oggettivi e razionali.
10. Credo solo a quello che è assolutamente
oggettivo e che si lascia provare razionalmente.
Forme: a) Maniacali b) Depressive
Esigenze
di distanza-vicinanza persone, gruppi, mete:
motivazione mentale di distanza-vicinanza sensata.
Situazioni
provocate dal comportamento stereotipico (reattivo):
che
permette di valutare razionalmente il senso di prendere o lasciare.
Inibizione-promozione
di attività autonome (attivo):
confermato
dall¹ambiente adeguato, se incontra comportamenti insensensati, flippa.
Relazioni,
socializzazione:
adattamento
solo in funzione di autocriteri razionali, non accessibile ad argomenti altrui.
Reazione
d¹emergenza:
stati depressivi o maniacali duraturi se cade il
controllo razionalizzante.
Stati
psichici in fasi compensate:
finché
delle supposizioni razionali ³giustificano² comportamenti scarsi di emozioni,
può essere mantenuto un equilibrio interno.
Stati
psichici in fasi decompensate:
quando
le barriere mentali non limitano più emozioni negative o positive, si
sviluppano spesso stati maniacali o depressivi.
5.4.3.1.3.6 Tipo 6 ³antinormativo²
1. Mi sottraggo a impegni e aspettative, non
ottemperando a regole e norme.
2. Nei confronti di altre persone mi
comporto da compagnone bonario oppure in modo molto aggressivo/a e ostile.
3. Spesso esigo dagli altri con le minacce
l¹osservanza rigorosa di accordi che io stesso inclino a non rispettare.
4. Agisco spontaneamente guidato dai miei
sentimenti negativi o positivi senza pensare alle conseguenze.
5. Spesso mi sento spinto ad attaccare altre
persone aggressivamente e ad annientarle.
6. Alle dimostrazioni d¹amore di un partner
divento particolarmente aggressivo/a.
7. Non ho nessuna inibizione ad attaccare
fisicamente una persona se sento l¹impulso di farlo.
8. Non ho nessuna inibizione ad autoferirmi
fisicamente, se spinto da un impulso interiore.
9. Mi sono svincolato da tutti gli oblighi
morali perché mi bloccavano psicologicamente.
10. Se ciò comporta per me vantaggi, so dire
bugie o stravolgere le cose senza inibizioni morali.
Forme: a) Agitative b) Sovversive
Esigenze
di distanza-vicinanza persone, gruppi, mete:
realizzazione antinormativa di esigenze materiali,
ideali, relazionali.
Situazioni
provocate dal comportamento stereotipato (reattivo):
pretese senza compenso, se non trova risposte: aggressioni e dispetti
Inibizione-promozione
di attività autonome (attivo):
frustrato: estremamente teso
speranza: soddisfatto.
Relazioni,
socializzazione:
antisociale, usa criteri e valutazioni contrastanti per sé stesso e gli
altri.
Reazione
d¹emergenza:
agitato
e carico al punto di minacce massicce, perdita di senso della realtà.
Stati
psichici in fasi compensate:
finché
l¹ambiente (naturale, relazionale, sociale) permette di soddisfare le pretese
antisociali, l¹equilibrio interno può sussistere.
Stati
psichici in fasi decompensate:
dopo
durature frustrazioni o insuccessi, si sviluppano tensioni interne e
aggressioni distruttive fino all¹incapacità di affrontare la realtà.
5.4.3.1.4 Questionario
differenziato per distinguere i tipi 1, 2 e 4
Se
una persona totalizza il maggior punteggio in uno dei tipo 1 o 2 o 4, conviene
differenziare ulteriormente, perché in fasi compensate dei tre tipi non è
evidente la prevalenza, (il ³tipo 4² contiene p.es. elementi di ³tipo 1² come
di ³tipo 2²).
A
questo scopo servono le domande del ³Questionario differenziato per distinguere
i tipi 1, 2 e 4² che mostrano delle alternative a): direzione tipo 1, b):
direzione tipo 2, o c): direzione tipo 4. Nel materiale didattico allegato si
trovano dei moduli per la valutazione. Il Grossarth descrive in modo seguente
la valutazione:
Chiave
di valutazione
1. La persona appartiene al Tipo
ha totalizzato il maggior punteggio.
2. Per la classificazione nella
categoria del Tipo 1 si sommano i punti delle corrispondenti 10 domande del
Tipo 1 alle risposte a) delle 11 domande del questionario per la
differenziazione del Tipo 1, 2 e 4.
3. Per la classificazione nella
categoria del Tipo 2 si sommano i punti delle corrispondenti domande del Tipo 2
a tutte le risposte b) delle 11 domande del questionario per la
differenziazione del Tipo 1, 2 e 4.
4. Tutte le alternative c) delle
11 domande del questionario differenziato del Tipo 1, 2 e 4 si attribuiscono al
Tipo 4 e sommate ai punti del Tipo 4.
5. Il punteggio totale del Tipo
4 deriva come segue:
Le prime 10
domande del questionario vengono sommate con le 11 c) alternative del
questionario per la differenziazione del tipo 1, 2 e 4. Dalla somma totale
vengono detratte le ultime 11 domande.
Il
³Questionario differenziato per distinguere i tipi 1, 2 e 4² è il seguente:
1. Se vengo minacciato, importunato,
respinto o trattato non giustamente,
mi sento interiormente
a) inibito, eccessivamente calmo, senza
parole, paralizzato, come pietrificato;
b) sovreccitato, inquieto, infuriato,
incontrollabile;
c) ancora
abbastanza equilibrato, né molto inibito, né sovreccitato.
2. Io sono piuttosto
a) una persona inibita e molto calma;
b) una persona sovreccitata che tende ad
agitarsi e irritarsi;
c) una persona equilibrata.
3. Vedo il mondo
a) del tutto positivamente;
b) del tutto negativamente;
c) con sentimenti contrastanti, ora
positivamente, ora negativamente, a seconda della luna e delle circostanze.
4. Soffro prevalentemente
a) perché a lungo andare non riesco a
realizzare il contatto con persone per me molto importanti (per es. il loro
affetto, la convivenza dopo una separazione, morte ecc.);
b) perché non riesco a mantenere il distacco
necessario e auspicabile da persone che alla lunga sento come negative (per
es.: da un partner che influisce negativamente su di me, da un superiore non
comprensivo, );
c) non soffro affatto, perché alla lunga riesco nel contempo a
realizzare il contatto auspicato con persone importanti e a distaccarmi da
quelle importune.
5. Io soffro prevalentemente:
a) perché alla lunga non riesco a
raggiungere mete per me importanti (per es. sul lavoro) oppure condizioni (per
es. armonia nella famiglia);
b) perché determinati stati negativi che mi
sono di ostacolo mi irritano di continuo;
c) non soffro affatto perché raggiungo i
miei obiettivi, e riesco a eliminare gli stati negativi.
6. In situazioni nelle quali qualcuno mi
respinge, offende, minaccia in modo estremo oppure mi tratta ingiustamente,
sono per lo più una persona che
a) è estremamente inibita, nell¹esprimere aggressività in atti e
parole;
b) diventa facilmente e molto velocemente aggressiva con atti e
parole;
c) non ho inibizioni nel mostrare aggressività, laddove ciò è
opportuno, senza tuttavia presentare un¹aggressività eccessiva.
7. Ho piuttosto l¹impressione che a lungo
andare
a) non riesco a stabilire un intimo contatto con persone molto
importanti;
b) non riesco a tenere la necessaria distanza da persone
importune;
c) riesco a realizzare un¹empatia con persone importanti e nel
contempo so distaccarmi da quelle importune.
8. Dopo perdite dolorose (per es. morte,
separazione, insuccesso professionale) reagisco
a) con uno stato di persistente stasi
interiore, come in una campana di vetro, con tendenze depressive e
autocritiche;
b) con persistente inquietezza interiore,
irritazione, sovrec-citabilità e irritabilità verso i colpevoli;
c) con uno stato di infelicità adeguato e di
durata breve, seguito da un nuovo equilibrio interiore.
9. Se vivo in condizioni negative a lungo
andare non benefiche
a) mi adatto, rassegnandomi alla situazione
incresciosa, e cerco di trarne il meglio, ristabilendo ad es. l¹armonia;
b) protesto energicamente, mi ritrovo di
nuovo in litigi e conflitti, permanendo però sempre nella stessa situazione
incresciosa;
c) esco da questa situazione con una mia
strategia di comportamento (per es. rimuovendo persone e condizioni negative e
modificando radicalmente la situazione).
10. Le mie attività mentali o fisiche (lavoro
, hobbies ecc.) conducono di regola a
a) esaurimento psicofisico e depressioni,
per cui mi sento sfinito e spossato;
b) sovreccitazione, tensione, irritazione
con l¹impressione di esplodere da un momento all¹altro;
c) benessere, stimolazione positiva e
contentezza interiore.
11. Mi sento interiormente inerme e incapace
di realizzare le condizioni necessari per il mio benessere
a) adeguandomi agli stati negativi senza
protestare (per es. non esponendomi in prima persona);
b) irritandomi incessantemente sulle cause
di questa situazione e protestando contro di esse;
c) perché influisco condizioni e stati
positivamente in modo che subentra il benessere.
5.4.3.1.5 Terapia comportamentale: allenamento
all¹autonomia
È
chiaro che il lavoro psicoterapeutico necessita di istruzione e di allenamento.
Il miglior allenamento e la migliore istruzione è sperimentare il metodo su sé stessi. Di seguito i principi e
le procedure del metodo proposto da Grossarth-Maticek.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
5.4.3.1.5.2 Approcci
all¹esito
5.4.3.1.5.3 Principi
terapeutici
5.4.3.1.5.4 Procedura
terapeutica
5.4.3.1.5.5 Attivazione
dell¹auto-osservazione
5.4.3.1.5.6 Stimolazione
dell¹autoattività per gestire meglio i problemi
5.4.3.1.5.7 Discorso
sui comportamenti alternativi in base a modelli
5.4.3.1.5.1 Traguardo
Per
il terapeuta: Stimolare l¹autoattività del cliente per risolvere i suoi
problemi osservando i seguenti criteri.
Per
il cliente, i criteri che gestiscono un comportamento sensato sono:
Instaurare delle condizioni di vita
quotidiana che promuovono:
- L¹espressione e comunicazione
(esteriorizzazione).
- La realizzazione e il godimento
(soddisfazione, interiorizzazione) di emozioni primordiali piacevoli per il cliente.
Instaurare delle condizioni di vita
quotidiana che evitano e inibiscono delle emozioni primordiali frustranti per
il cliente.
Reggere e gestire la vita quotidiana in
funzione dei due principi sovraccitati, adattando se necessario anche valori,
esigenze e concetti.
Per
il lavoro pratico è importante che il cliente si definisca un (pure piccolo)
obiettivo delimitato e definito.
5.4.3.1.5.2 Approcci
all¹esito
La
premeditazione dialettica e sistemica è lo strumento mentale per il lavoro:
Dialettico in quanto paragona delle alternative, sistemico in quanto si
immagina delle conseguenze probabili di comportamenti e si chiede se sono
conformi agli obiettivi e ai criteri, sopportabili o inaccettabili (il santo
non vale la candela).
Durante
la sperimentazione di un comportamento alternativo (o abituale) si tiene
presente:
- Un insuccesso significa che il
comportamento non era adeguato e che bisogna sperimentare un¹alternativa.
- Un insuccesso che si ripete in
continuazione può essere un segnale per rivedere il sistema delle aspettative e
l¹autovalutazione (accettarsi, rispettarsi, volersi bene, perdonarsi) malgrado
l¹insuccesso.
5.4.3.1.5.3 Principi
terapeutici
La conduzione del discorso (Rogers) da
parte del consulente deve essere:
- Autentica: sincerità, privo di
bigotteria, che crea fiducia.
- Di stima positiva: rispetto e dignità,
non invadente che crea un ambiente privo di paura e ricatto, che stimola il
cliente ad affrontare le proprie emozioni e esperienze.
- Dedica comprensiva: darsi da fare per
vedere il mondo con gli occhi del cliente, chiedere se le sospettate emozioni
erano presenti, verbalizzare emozioni, fornire al cliente un modello di
trattamento ³autoesplorativo².
Non guidare il discorso secondo le
scoperte del terapista, né dare suggestioni.
Scoprire cosa è importante per il
cliente, che obiettivi ha, la sua gerarchia individuale (canone) di valori e di
esigenze e il suo ³piano di vita a monte².
5.4.3.1.5.4 Procedura terapeutica
- Attivazione dell¹auto-osservazione e
nessi tra comportamento e conseguenze.
- Stimolazione di autoattività per gestire
meglio i problemi.
- Discorso di comportamenti alternativi in
base a modelli trattato brevemente di seguito.
5.4.3.1.5.5 Attivazione
dell¹auto-osservazione e nessi tra com- portamento
e conseguenze
- La persona rapporta i loro problemi,
desideri e conseguenze subite.
- Il terapeuta pone delle domande circa i
problemi, i traguardi, il comportamento e le relative conseguenze.
- Servono gli strumenti ³Questionario
sull¹auto-regolazione² e ³Questionario per la classificazione di tipologia
comportamentale² per scoprire i punti critici e per rendere più chiari i nessi.
5.4.3.1.5.6 Stimolazione
dell¹autoattività per gestire meglio i problemi
- Il terapeuta interroga il cliente su
quanto fatto in questo senso, sul comportamento passato e futuro.
- Certe persone sviluppano presto idee in
merito.
- Altre sono deluse che il terapeuta non
faccia delle proposte.
- Quasi tutti sviluppano dopo un certo
tempo delle proposte proprie per intraprendere qualcosa.
5.4.3.1.5.7 Discorso sui comportamenti alternativi in base a dei modelli
- Se non ci sono proposte del cliente, il
terapeuta spiega come un¹altra persona con simili problemi ha tentato di
risolverli e chiede un suo parere in merito.
- Le proposte sono discusse secondo i
seguenti criteri:
- Creano condizioni in direzione del
benessere, voglia, sicurezza, gioia, soddisfazione, prospettive, entusiasmo?
- Evitano o sfuggono condizioni di disagio,
malavoglia, incertezza, tedio nei confronti della vita, frustrazione,
rassegnazione, noia?
- Permettono una mutazione di proprie
interpretazioni, valutazioni e convinzioni?
- Per questi discorsi serve il modello
compo-rtamentistico PTO 1.5.4.2.1 e il ³Questionario per rilevare il grado del
piacere e del benessere² per rispettare le risorse. Modelli ³discorsivi² sono
utili per comprendere come altre persone affrontano un simile problema.
6.0 Strumenti didattici per il seminario
6.1 Test autoregolazione e benessere
6.1.1 Test
autoregolazione
6.1.2 Test risorse del
piacere e del benessere
6.2 Tipologia comportamentale
6.2.1 Questionario
per la classificazione della tipologia comportamentale
6.2.2 Valutazione di
tipi comportamentali
6.3.1 Stereotipi
comportamentali
6.3.2 Concetto
comportamentale empirico
6.3.3 Allenamento
all¹autonomia
6.4 Autotrattamento ³kinesiologico² delle fobie e
dipendenze
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |