|
|
Medicina popolareper autodidatti
agosto 10, 2005 |
|
Gli autori ³monumentali² del tema sono
Uexküll e Weizäcker. Il primo autore del tema era Groddeck.
Bibliografia:
|
PSYCHOSOMATISCHE
MEDIZIN Klussmann
Rudolf Springer 1998 CHF 56,00
|
NATURA
GUARISCE, IL MEDICO CURA. LA
SCOPERTA DELLA PSICOSOMATICA (LA) GRODDECK
GEORG CELUC
LIBRI 1986 ¤19,00 |
|
LINGUAGGIO
DELL'ES. SAGGI DI PSICOSOMATICA E DI
PSICOANALISI DELL'ARTE E DELLA Š GRODDECK
GEORG ADELPHI 1991 ¤14,46 |
PSICOSOMATICA
TROMBINI
GIANCARLO; BALDONI FR
IL MULINO 1999 ¤18,00 |
|
MEDICINA
PSICOSOMATICA HAYNAL
PASINI MASSON ¤27,89 |
PREPARAZIONE
PSICOSOMATICA ALLA
TERZA ETA' NEGRISOLI
ALDO NUOVI AUTORI 1986 ¤10,33 |
|
PSICOSOMATICA
PINKUS
LUCIO CAROCCI 1989 ¤18,60 |
CLINICA
PSICOSOMATICA DEL BAMBINO KREISLER
LüON CORTINA RAFFAELLO 1996 ¤24,30 |
|
STRESS,
EMOZIONI, MALATTIA. INTRODUZIONE ALLA
MEDICINA PSICOSOMATICA PANCHERI
PAOLO MONDADORI 1983 ¤ 21,69 |
TRATTATO
DI MEDICINA PSICOSOMATICA PANCHERI
PAOLO USES 1984 |
|
PSICOSOMATICA
SHORTER
EDWARD FELTRINELLI 1993 ¤ 46,48 |
PSICOSOMATICA
CLINICA CREMERIUS
JOHANNES BORLA 1981 ¤25,82 |
|
LA
SOCIOLOGIA PER L'OPERATORE SOCIALE MIMMA
CINTURA ARMANDO ¤ 12.39 |
|
La
³psicosomatica² si propone di studiare malattie, disordini, disagi e disturbi
partendo dagli stretti legami tra il funzionamento psichico e quello fisico.
Secondo me, bisognerebbe chiamarla anzitutto ³socio-psico-somatica², perché
l¹aspetto sociale ne è altrettanto coinvolto (e normalmente anche sottinteso).
Trattando
il tema mi sono trovato di fronte a parecchie difficoltà:
- Dare a un
disturbo, oltre alla dimensione fisica anche un aspetto psichico e sociale
significa anzitutto avere nozioni psicologiche e sociali che nei programmi
abituali di naturopatia non sono previste.
- Questo
fatto è molto strano proprio in un campo che pretende di essere ³olistico,
integrativo, ². Infatti, cos¹altro può significare se non considerare e
studiare anche le condizioni psichiche e sociali. Forse che queste materie ci
siano innate?
- Ogni
medico e terapista degno di questo nome considera gli aspetti sociali e
psichici del suo paziente. È stato così da tempi immemorabili, molto prima
dell¹invenzione della ³psicosomatica².
- Il padre
della psicosomatica GRODDECK, allievo di FREUD e inventore dell¹ES nel modello
di Freud, ha scritto il primo libro a me noto che tratta il tema in modo
sensato. Anche se antiquato, consiglio caldemente di leggerlo; è molto migliore
della maggioranza dei testi moderni sul tema.
- Nel
frattempo la psicosomatica è, almeno formalmente, entrata nell¹ambito
dell¹insegnamento medico universitario. In tante università esistono delle
cattedre di psicosomatica (p.es. Monaco di Baviera: Ludwig Maximilian
Universität: Lehrstuhl für Psychosomatik).
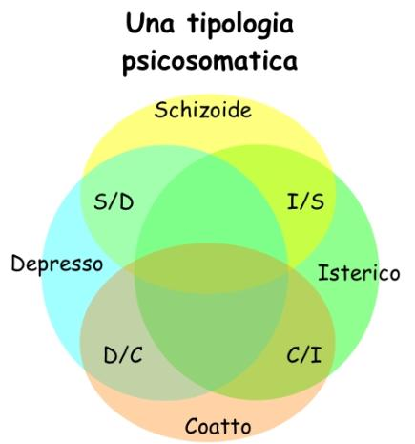
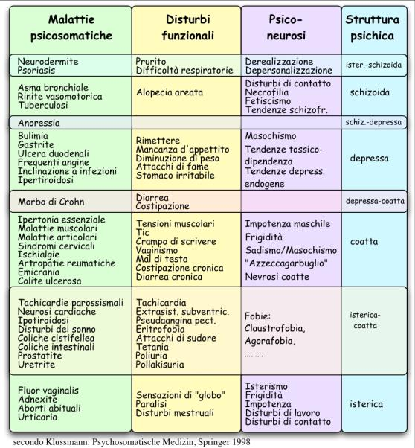
Il tema è vastissimo e non può essere trattato in poche lezioni e richiede conoscenze di psicologia e sociologia. Ho quindi deciso di:
-
discutere, in una prima parte, dei modelli sull¹interazione di dimensioni
sociali, psichiche e somatiche come strumenti di lavoro per il terapista.
- Trattare
il tema in una seconda parte in modo ³esemplare², attingendo a un esempio
ritenuto poco psicosomatico: la gotta.
Inoltre,
sarei disposto a stilare una breve introduzione di: sociologia, psicopatologia,
psicoterapia e psicoterapia ³ortomolecolare² se ci fossero degli interessati
(vedi capitolo 3: ³Nozioni di).
1.0 Modelli
socio-psico-somatici
Psiche
(anima) e soma (corpo) in interrelazione individuale e in relazioni sociali con
altri esseri umani.
1.1 Immagini dell¹essere umano
1.2 Interazioni psico-socio-somatiche
1.3 Individuo tra biologia e sociologia
1.4 Relazioni tra persona e ambiente
1.6 Concetti di psiche e
corpo
1.7 Esempio: fisiologia
dello ³stress²
1.1 Immagini
dell¹essere umano
Un
adolescente di dodici anni chiese a sua mamma:
³Se guardo
nello specchio vedo una persona e non mi sembra di essere io. E quando penso,
non sono io che penso, ma il pensiero nasce da sé. Chi sono poi io?².
Genialità
dell¹adolescente! (Il fatto è veramente successo). Non solo ha notato, ma è
anche capace di formulare la sua condizione umana fondamentale in modo
chiarissimo: io, tra la biologia (riflesso nello specchio) e la sociologia
(capace a dirigere il mio pensiero) chi sono?
Per i miei
ragionamenti professionali come naturopata, massaggiatore e psicoterapista
percepisco l¹essere umano (similmente all¹adolescente) come figura limitata:
- Da una
parte da condizioni biologiche
-
dall¹altra da impedimenti sociali (creati soprattutto dalla propria razza)
- dal
tentativo (vita natural durante) di arrangiarsi (più o meno egregiamente) con
le esigenze (di solito contrastanti) di natura e cultura.
Espresso
con parole sarcastiche: ³Una sedia a sinistra, una sedia a destra e noi sempre
nel mezzo² (Tucholsky).
Partendo da
questo presupposto, le discipline più importanti del mio mestiere sono:
- La
biologia ³medica² (p.es. anatomia, fisiologia, patologia).
- La
sociologia ³medica²: strutture (p.es. ruoli, gruppi, posizione) e funzionamenti
(p.es. politica, economia, giurisprudenza, educazione, formazione, sanità,
³cultura², informazione, ).
- La
psicologia ³medica²: struttura e funzionamento della personalità (p.es.
identità, valori, gestione di conflitti, deprivazione, anomalia) dei miei
clienti.
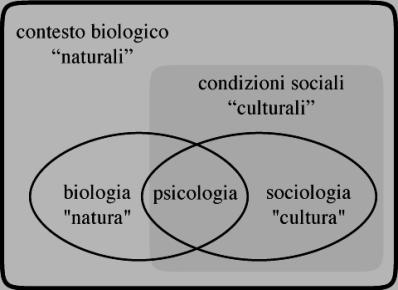
1.2 Interazioni psico-socio-somatiche
Inizialmente
nel mio mestiere artigianale come massaggiatore e naturopata mi concentrai
sull¹aspetto ³biologico². Con il passare degli anni mi resi conto che nelle
cure erano altrettanto importanti dei fatti sociali e psichici e mi sentii, per
un certo periodo, più ³olistico² e ³integrale².
Lavorando
in questo modo, cominciai a sfumare la differenziazione, fino al punto che oggi
mi è difficile distinguere ed etichettare una ³patologia² secondo questi
criteri. Devo rispettare il fatto, che qualsiasi disordine, disagio, malattia
fisica ha anche una dimensione sociale e psichica; e non solo. Secondo me si
tratta di:
- processi
sistemici, nei quali la distinzione di causa ed effetto diventa altrettanto
problematica quanto la questione se ci sia stato prima l¹uovo o la gallina;
- disordini
sistemici che possono essere provocati da innumerevoli fattori, i quali:
- formano
³circoli viziosi², che nel caso patologico si autonutrono fino oltre al limite
dell¹ accettabile.
- Questi
circoli viziosi possono essere ³interrotti² con strumenti sia biologici, sia
sociali o psichici (con effetti collaterali diversi).
In base a
queste riflessioni, è grande la tentazione di ³psicologizzare² tutto (ed è
diventato una moda), cosa che respingo categoricamente, perché di solito si
tratta dell¹inconscio tentativo di nascondere l¹impotenza terapeutica, buttando
sul cliente la colpa. Quanti medici (universitari e naturalistici), dopo il
fallimento delle loro cure, dichiarano ³psichico² o ³terapia resistente² il
loro paziente, come se avessero gli strumenti per fare una diagnosi di questo
genere.
È diventato
anche un paradigma popolare (mediato dai mass-media e giornalisti non
qualificati in materia) che la causa di malattie fisiche malcurabili risieda in
disordini mentali.
Questo
paradigma riempie le sale d¹aspetto degli psichiatri, psicologi e
psicoterapisti. Nella mia prassi noto più spesso disturbi fisici (metabolici,
ormonali, malattie croniche) alla base di disturbi mentali che viceversa.
L¹interdipendenza psichico-fisico non è a senso unico, come il paradigma vuol
farci credere.
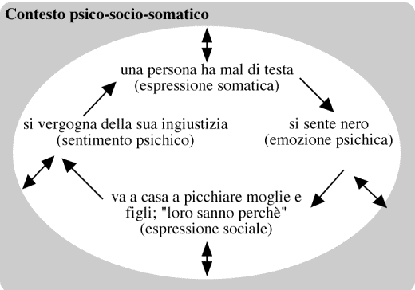
1.3 Individuo
tra biologia e sociologia
Come
modello base della psicosomatica uso l¹ambivalenza umana tra condizioni
biologiche e condizioni sociali. La vita umana è una continua scelta tra:
- Piacevole
o meno spiacevole (biologico).
- Giusto o
meno sbagliato (sociale).
- Utile o
meno futile (individuale).
Malauguratamente
mi capita raramente il caso di una scelta contemporaneamente piacevole, giusta
e utile, ma:
- L¹utile è
spesso ingiusto e spiacevole.
- Il giusto
spesso inutile e spiacevole.
- Il
piacevole spesso sbagliato e futile.
Comunque,
per tenere in equilibrio il mio ³metabolismo psichico², ho bisogno di certe
dosi sia di piacevole, che di giusto e di utile, anche a scapito del resto. Mi
capita anche che un¹alternativa sia sbagliata, spiacevole e futile, e, se me ne
accorgo, non la scelgo.
In breve:
- Se voglio
aver successo devo convivere con colpe e dispiaceri.
- Se voglio
aver ragione devo convivere con insuccesso e futilità.
- Se voglio
divertirmi devo convivere con vergogna e futilità.
Perché è
impossibile avere rapporti e rimanere vergine e trarne profitto nel medesimo
tempo.
Per non
rimanere in continuazione frustrato:
- Ogni
tanto scelgo il giusto (e mi sento mezzo santo).
- Ogni
tanto scelgo il piacevole (e mi diverto un mondo).
- Ogni
tanto scelgo l¹utile (e mi sento un grande imprenditore).
Di fatto
non vorrei mancare nessuno dei tre sentimenti.
L¹altra
problematica delle scelte è, che se di cinque alternative mi decido per una, ho
rinunciato alle altre quattro, il che è frustrante per me. Però la frustrazione
è 4:1. Se non mi so decidere (cosa che succede facilmente, visto che mi lascio
condizionare poco e mi tengo così aperte delle alternative), la rata di
frustrazione però è 5:0. Se mi lascio condizionare, non ho scelta e la rata di
frustrazione è 1:0. Personalmente preferisco un 5:1, ma questo sembra molto
individuale.
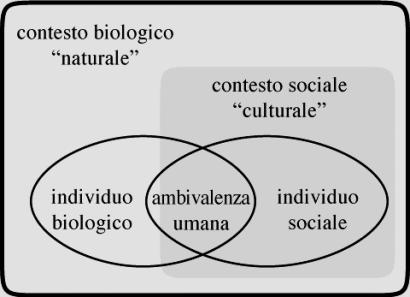
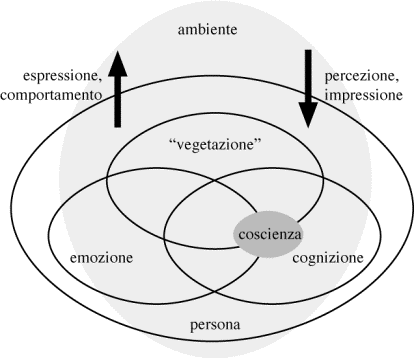
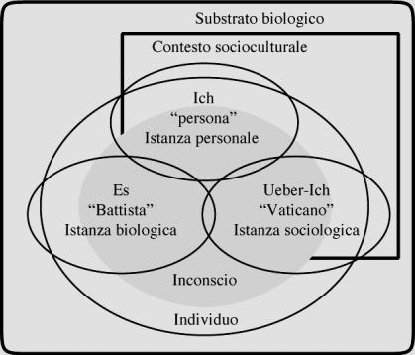
1.4 Relazioni
tra persona e ambiente
L¹ambivalenza
umana (tra sociologia e biologia) nei relativi contesti si manifesta nei
seguenti ambiti:
-
Emozionale, nutrito da percezioni e impressioni evidenziete da comportamenti ed
espressioni.
-
Cognitivo.
-
Vegetativo.
La massima
parte di questa dinamica si svolge in modo ³meccanico², automatico, regolativo,
cibernetico, riflessivo ma all¹infuori del conscio, saputo, riflettuto,
mirato, voluto Infatti tutte le nostre mosse elementari esistenziali
fortunatamente funzionano così (se no, la nostra coscienza non troverebbe mai
il tempo di dedicarsi ai suoi compiti più nobili) L¹organizzazione anatomica e
fisiologica dei sistemi di gestione (regolazione basale, endocrina, nervosa) ce
lo dimostra esaurientemente.
Freud ha
descritto l¹inconscio utilizzando più o meno la seguente parabola:
³Un uomo di
notte con un lumino in mano esplora un campo. Conscio corrisponde a quello che
appare nella luce del suo lumino; inconscio è tutto il resto.²
1.5.1 Definizioni
e usi ³professionali²
1.5.2 Definizioni
e usi comuni
1.5.1 Definizioni
e usi ³professionali²
Secondo la
definizione Freudiana , il ³conscio² è:
-
Strettamente riservato a coscienza momentanea e individuale.
- Soggetto
a interpretazione (cosa significa ciò che appare).
Personalmente
preferisco questo approccio, per motivi pratici e perché mi sembra
sufficientemente delimitato e differenziato.
Altri
autori, senza perdersi in definizioni, usano il termine ³cosciente² in modo non
situazionale (momentaneo) ma individuale, nel senso di una specie di
³cognizione individuale², ³capacità di una determinata persona di rendersi
conto² con tutte le difficili implicazioni di memoria, ricordo, reminiscenze,
associazioni mentali, mistificazioni, riflessioni,
Altri, e
spesso gli stessi autori, (senza differenziarlo bene nel contesto) lo
definiscono ³implicito² come potenziale di cognizione di una cultura o
dell¹essere umano in generale.
È
altrettanto curioso, che sull¹inconscio, ci siano tanti pareri, modelli e
teorie, ma raramente s¹incontrino, nella letteratura, dei concetti sul conscio.
Pare che tutti sappiano cos¹è, solo io stento a capire.
Ogni tanto
si legge di ³subconscio²; dove si capisce che l¹autore si è risparmiato l¹onere
di leggere Freud, che si rigirerebbe nella sua tomba, poveretto, dovendosi
accorgere che qualcuno ³sottomette² l¹inconscio al conscio.
1.5.2 Definizioni
e usi comuni
Nell¹uso
comune si nota:
- Un gran
mito dell¹inconscio.
- Che
l¹inconscio fa paura.
- Perché
apparentemente sfugge al controllo e alla volontà.
-
All¹intenzione e al sapere.
- Che
sembrano tutti valori (sociali) più potenti.
- Del
miracolo della vita (biologica) umana stessa.
Per me,
questo approccio è segno di un grande disprezzo della creatura.
In questo
senso l¹inconscio corrisponde più a strane motivazioni e oscuri impedimenti da
parte di fonti ³bestiali², mentre la coscienza appare come ideale di sovranità
sugli impulsi esistenziali. Questo punto di vista è molto limitativo perchè è
facilmente dimostrabile che:
- Anche
delle funzioni vegetative possono essere rese coscienti e controllate fino a un
certo punto (p.es. respiro, nutrizione, defecazione) e molti violentano in
questo modo sistematicamente i loro automatismi vegetativi fino a farsi una
religione (di nuovo l¹inventore ha sbagliato qualcosa).
- Tipiche
funzioni sociali possono essere o diventare inconscie (p.es. norme, moventi,
impedimenti, costumi, atteggiamenti).
- Tipiche
funzioni psichiche sono a volta coscienti e a volta inconscie.
Nella
valutazione popolare, e tacitamente anche da parte di tanti operatori del
settore psicosociale, esistono le seguenti valutazioni e credenze (spesso
inconsce) fatali:
- Inconscio
è male perché incontrollabile (concetto del diabolico).
- Conscio è
bene perché gestibile (concetto dell¹angelico).
- Per
risolvere i problemi psichici bisogna rendere cosciente l¹inconscio
(trasformare un diavolo in un angelo).
Il concetto
ricorda, nella sua polarità e esclusività di approccio, quello medioevale del
diavolo (impulsi, istinti biologici) verso la spiritualità (fede, preghiera,
contemplazione) e la sublimazione del vano terrestre in un ideale celeste, nega
creazione e creatura come valori a sé. Inoltre, il concetto non funziona nella
pratica, come lo può confermare ognuno di noi, che ogni tanto sa perfettamente
cosa ci sarebbe da fare ma non ci riesce (³sindrome dell¹eunuco²).
1.6 Concetti
di psiche e corpo
Psiche:
anima (dal greco: anche ³farfalla²); Soma: corpo.
1.6.3 Tentativo
di un modello differenziato
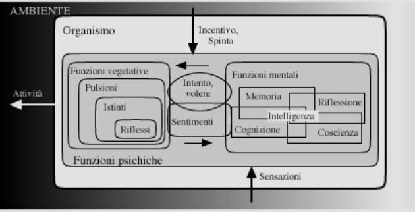
1.6.1 Concetti vigenti
I relativi
modelli europei vigenti sono polari nel senso che raggruppano:
- l¹ambito
cognitivo
- con
quello emotivo,
in qualcosa
di ³psichico² e lo mettono in opposizione a qualcosa di ³biologico².
Inoltre,
dei fenomeni sociali e culturali, in quanto antietici e conflittuali al
³biologico², vengono trattati come fatti ³psichici². In questa tendenza (poco
differenziata) viene trattato come ³psichico²:
- tutto
quello che non è ³evidentemente² biologico e
- tutto
quello che non corrisponde ad una normalità statistica di comportamento, di
impressione, cognizione o emozione secondo le norme vigenti di una società.
Questo
approccio crea confusione perché evita la differenziazione esplicita di:
-
sociologia (relazionale) e
-
psicologia (individuale),
ma ammette
almeno la conflittualità tra biologia e sociologia e i relativi disagi
individuali. Permette di distinguere e discutere fra gli elementi biologici e
quelli non biologici (chiamati ³psichici²).
Un altro
difetto (oltre alla confusione) dei modelli vigenti, consiste nel fatto che non
distinguono ³l¹umano² dal ³bestiale², perché anche le bestie (specialmente
quelle addomesticate) si trovano in conflitti sociali/biologici, ma molto
probabilmente non in quelli di valori sociali (ideologici, religiosi, estetici,
etici, morali, ).
La tendenza
populistica è più semplicistica; essa definisce (tacitamente) tutto quello che
non corrisponde ad una normalità statistica di comportamento, di impressione,
cognizione o emozione, come difetto biologico col tentativo di correggerlo a
livello biologico o sociale (come se l¹inventore avesse sbagliato tutto). Rende
indistinguibili e indiscutibili dei fatti socioculturali evidentemente
abiologici e stipula così la dominanza di un¹ideologia sulla vita umana, con
completo spregio della creatura umana come tale.
In
compenso, le stesse persone rispettano spesso al massimo la creatura animale,
un classico esempio di ambivalenza umana e/o di percezione selettiva.
1.6.3 Tentativo
di un modello differenziato
Non si
tratta tanto di delimitare la terminologia, perché nella persona reale non
esiste questa distinzione.
- È comune
classificare le emozioni come psichiche, mentre diventa moda nella medicina
considerarle esclusivamente come processi biochimici (ormonali e di
neurotrasmettitori).
- La
psicologia definisce anche le percezioni, le sensazioni e impressioni come
psichiche, mentre il laico le classifica piuttosto come ³corporee² (vista,
udito, olfatto, gusto, tatto, equilibrio, dolore, ).
- La psicologia
classifica come psichiche anche delle prestazioni come memoria, cognizione,
intenti, volontà (part accessibile al cosciente) mentre il laico le percepisce
più come ³mentali² o ³spirituali².
- La
psicologia classifica come psichiche anche le parti espressive umane, i
³comportamenti², mentre il laico tende a classificarli ³caratteriali² quando
sono ³aberranti², scomodi e ripetitivi.
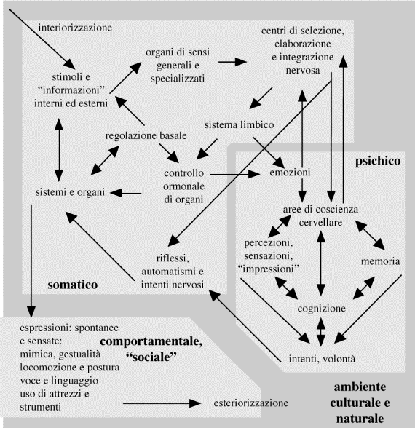
1.7 Esempio:
fisiologia dello ³stress²
Negli
ultimi decenni e anni sono stati approfonditi diversi nessi e interazioni tra
soma e mente. Essi permettono di connettere anche mentalmente dei fatti
comportamentali, emotivi, fisiologici e anatomici. Dopo i lavori di Selye sullo
stress e di Pauling sul metabolismo e sui ³micronutrienti², si suppone che
tantissimi disturbi classificati ³sociali, comportamentali, psichici,
percettivi, emotivi, relazionali, ² abbiano anche una dimensione
fisiologica/anatomica: che scoperta!
Come
conosco la scienza e i mass-media, i prossimi anni saranno dedicati a interminabili
discorsi intesi a capire se la schizofrenia sia causata da una massiccia
mancanza di vitamina B6 o se la schizofrenia crei un esagerato fabbisogno di
vitamina B6, mentre essa ha altre cause ancora sconosciute (probabilmente
genetiche). Questo non aiuterà tanto a curare.
Il seguente
esempio di un modello scientifico (utile) tratta la dimensione
organica/fisiologica di un fatto percepito come ³psichico: lo stress.
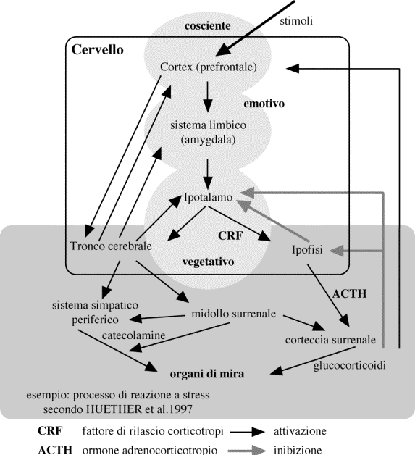
2.0 Esempio
di malattia psicosomatica: la gotta
Ho scelto
la gotta come esempio di malattia psicosomatica per due motivi:
-
Normalmente non viene percepita come malattia ³psicosomatica², ma come
³metabolica².
- Il prof.
Klussmann l¹ha documentata bene nel suo libro:
Klussmann,
Rudolf Prof.Dr.: Gicht-Gier-Grösse-Macht: Herrscher im Spannungsfeld von Lust
und Leid (Gotta-avidità-grandezza-potere: Sovrani nel contrasto assillante di
voglia e dolore).
Lehrstuhl
für Psychosomatik, Ludwig Maximilian Universität, München.
Gotta:
Malattia ³di una società di lussuria²; colpisce il 3% della popolazione, di cui
95% maschi, normalmente in posizioni di comando e guida. L¹80% degli attacchi
acuti colpisce l¹articolazione basale dell¹alluce. Occupa il secondo posto come
malattia ³metabolica² negli stati industrializzati.
2.1 Distinzione di
genesi della gotta
2.2 Approccio
psicoterapeutico
2.4 Relativizzazione
dell¹esempio
2.1 Distinzione
di genesi della gotta
Da parte
medica ci sono due approcci alla genesi (creazione) della gotta:
-
L¹approccio ³biomedico² la spiega come ³aberrazione² fisiologica nel
metabolismo dell¹acido urico (con classici sintomi fisici) da trattare con dei
rimedi che tolgono il disturbo in fase acuta e correggono l¹aberrazione
fisiologica dopo averla scoperta.
-
L¹approccio ³psicosomatico² accetta l¹approccio biomedico, ma sospetta,
all¹origine e come causa, un determinato ³funzionamento psichico patologico² e
propone, oltre alla medicazione biomedica, un adeguato trattamento
psicoterapeutico.
- Come
terapista ho trattato clienti con nessun ³sintomo psichico² di gotta
(biogenesi) e altri invece con marcati relativi sintomi (psicogenesi). Ho
notato che l¹esito della cura biomedica era accettabile per tutti e due, solo
che i clienti del tipo ³psicogenesi² tendenzialmente aumentavano i sintomi ³non
fisici². (Dettagli vedi capitoli ³Esiti ²).
In base a
questa esperienza e come praticante terapista è diventato importante poter
distinguere la genesi della gotta di un determinato cliente:
- Per non
stigmatizzare con pregiudizi ³caratteriali² gli uni.
- Per
essere preparato a effetti collaterali, socialmente pesanti per l¹ambiente,
degli altri.
Forse è
semplicemente sbagliato voler distinguere perchè in realtà non c¹è distinzione,
come lascia dubitare un meccanismo metabolico (asse: trattenimento acido urico
<> treonina <> glicina <> eccitazione maniacale). E così è
anche inutile fissarsi su un determinato approccio finché non si riesce a
valutare l¹importanza delle componenti e mettere il peso su quello prevalente.
In questo senso è inteso il seguente discorso: Come si fa a distinguere una
³genesi² prevalentemente somatica (biomedica) da una prevalentemente
³psicosiociale²?
Per
rilevare questo mi servo dei seguenti criteri:
-
L¹anamnesi rivela inclinazione verso altri disagi ³neurovegetativi² o di
sospetta origine psicosomatica come asma, emicranie, nevralgie, coliche,
disturbi gastrointestinali, depressioni, lombalgite
-
L¹inchiesta personale/sociale rivela tipici ruoli sociali di dirigenza
intellettuale con scarse doti di responsabilità relazionale (a scapito del
ruolo sociale) e altri elementi comportamentali del genere.
-
L¹osservazione e il dialogo fanno sospettare rilevanti sintomi narcisistici e/o
isterici; ma è difficile valutare perché l¹evento acuto può sia amplificare sia
smorzare questo elemento.
- La
distinzione mi è spesso difficile, perché non si tratta di una delimitazione
netta, ma di prevalenze dove facilmente si può incorrere in errore.
-
Personalmente (e in caso di dubbio) preferisco un primo approccio ³biomedico² e
tengo di mira l¹evoluzione ³psicosociale² per poter correggere il tiro, se necessario.
2.2 Approccio
psicoterapeutico
La medicina
psicosomatica tiene in considerazione il punto di vista ³biomedico² ma aggiunge
altri elementi (multifattoriale). Oltre al trattamento acuto biomedico,
l¹approccio della medicina psicosomatica consiste in una psicoterapia. Uno
psicosomatico di stesura prevalentemente psicoterapeutica proporrà forse una
psicoterapia con forti accenti sociali/relazionali, che accompagnano le cure
³biomediche². Egli parte ammettendo a priori un nesso tra gotta e una struttura
psichica ³caratteristica², determinata da elementi come:
- Disposizione
biologica innata e/o
acquisita (metabolismo dell¹urea e acido urico).
- Sviluppo
infantile di personalità
gravemente disturbata, prevalentemente di tipo narcisistico/isterico (problemi
di autostima, rilevanti sensi di inferiorità e dubbi su sé stesso), spesso
frutto di traumi infantili come smisurate punizioni, deprivazione sociale,
paure esistenziali, incertezze e abitudini alla diffidenza dalle quali si
difende spesso con elementi megalomani (autoimmagine grandiosa),
caratteristiche decisamente espansive, disinvoltura relazionale, autocontrollo
³maniacale² e spesso fobie di piccoli animali.
- Compensazione
comportamentale con
atteggiamenti di prepotenza, ambizioni prevalenti, forte volontà di
sopravvivenza e volontà ferrea, testardaggine, smisurato senso del dovere,
lunaticità e irascibilità.
L¹ambiguità
tra personalità disturbata, difesa e compensazione comportamentale è un
equilibrio instabile che tende a crollare nelle fasi di seri conflitti acuti.
Manifestandosi
nelle forme della malattia socialmente accettata (la gotta impedisce fra
l¹altro la fuga) salva l¹equilibrio ambiguo (guadagno della malattia) e
permette di rivolgere l¹attenzione, la concentrazione e le imprese sul disagio
fisico, mantenendo l¹integrità di sensi, valori e atteggiamenti contrastanti.
Klussmann
ha dimostrato con ampi esempi questo meccanismo in personaggi storici
(sovrani), mentre la ricerca attuale rivela che la gotta colpisce
prevalentemente delle persone con compiti dirigenziali intellettuali, attivi,
dinamici, orientati alla resa, sovraccarichi, dominanti con scarso senso di
responsabilità per il prossimo (le paure sembravano scostate): professori,
studenti universitari, manager,
La mia
critica è la critica di tutte queste distinzioni:
- È la
struttura psichica della persona a indurre la gotta?
- È la
gotta (come disposizione metabolica) a indurre la struttura psichica della
persona?
La domanda
in fondo non mi interessa tanto, perchè come terapista sono chiamato a curarla.
Come si
cura una persona da questo disturbo. Otto von Bismarck (18151898),
³cancelliere di ferro² dell¹impero prussiano e noto ³gottoso psicosomatico² ha
definito bene l¹approccio terapeutico dicendo del suo ultimo medico di corpo
Schweninger, che era stato l¹unico ad osare di metterlo in riga e aveva avuto
successo, mentre tutti i medici precedenti avevano fallito, malgrado Bismarck
gli avesse suggerito che cosa fare. Schweninger, più di cento anni fa, aveva
pochi strumenti ³biomedici² per curare la ³patologia² di Bismarck che
consisteva in:
- gotta,
asma, emicranie, nevralgie, coliche, disturbi gastrointestinali, depressioni,
lombalgite del cancelliere.
- Sembra
che Schweninger era un bravissimo medico e che riuscì a capire i meccanismi del
funzionamento psicosomatico di questo suo paziente ³eroico e piagnucoloso² ma
potente e pericoloso sia per la reputazione che per l¹esistenza del medico
stesso.
- Sembra
che egli avesse trovato proprio in questi meccanismi l¹aggancio per rendere i
sintomi (fisici e psichici) meno devastanti per il suo paziente, sé stesso e
l¹ambiente politico europeo.
- Non si sa
come abbia fatto, perché da bravo medico, fedele al giuramento di Ippocrate,
egli non parlò mai né scriss riguardo alla cura dei suoi clienti.
- Per me
era anche un grande medico perché riusciva a trattare il potente Bismarck con
più potere di lui come d¹altro canto trattava, con umiltà, gli umiliati
miserabili di Berlino.
L¹esempio
serve ad illustrare le difficoltà di cura di un tipico cliente ³gottoso
psicosociale², ma il comportamento e la relazione terapeutica di Schweninger e
Bismarck, non sono né un programma né una ricetta, perché noi non siamo
Schweninger e il nostro cliente non è Bismarck. L¹esempio illustra solo una
possibilità e offre una vaga idea delle capacità mediche, umane, relazionali e
sociali richieste dalla cura.
Per la
³biomedicina² la gotta si presenta così:
-
Iperuremia (tasso elevato di acido urico nel sangue).
- Depositi
salini di acidi urici in articolazioni, borse, organi (spec. reni) e derma
(tofi gottosi).
- Attacchi
acuti (normalmente articolazione basale dell¹alluce) molto dolorosi che
impediscono il movimento, i quali, se non trattati possono diventare cronici,
innestarsi negli organi colpiti, e, come complicazioni, aprirsi, creare tumori,
causare invalidità e, in casi molto gravi, anche la morte.
Sarebbe
quindi da irresponsabili non frenare almeno le conseguenze
metaboliche/patologiche, se non quelle psichiche.
2.3.1 Medicina
e naturopatia ³classica²
2.3.2 Medicina
³oligoterapeutica²
2.3.3 Esiti
di trattamento in genesi somatiche
2.3.4 Esiti
di trattamento in genesi psicosociali
2.3.1 Medicina
e naturopatia ³classica²
- Attacchi
acuti: trattati con derivati di colchicina (canonico e naturopatico).
-
Predisposizione alla malattia e disturbo latente.
-
Trattamento con allopurine, in medicina canonica oppure con Hb. avenae rec.,
Fol.
betullae, urticae, in naturopatia.
-
Correzione della dieta (diminuzione o eliminazione di frattaglie, frutti di
mare, pesce, carne rossa, formaggio).
Si notano
spesso relativi eccessi dietetici in pazienti coinvolti.
2.3.2 Medicina
³oligoterapeutica²
Si occupa
specialmente di fattori metabolici e di ³micronutrienti², un aspetto non da
trascurare in un disturbo metabolico come la gotta.
Partendo da
conoscenze metaboliche riguardanti l¹acido urico, un praticante di medicina
ortomolecolare farebbe le seguenti riflessioni:
- nel
metabolismo dell¹acido urico (importantissimo per la rigenerazione di tessuti e
un potente antiossidante ³naturale²) hanno un ruolo centrale:
1. La
treonina, un amminoacido essenziale che viene trasformato nell¹organismo, fra
l¹altro, in glicina.
2. La
vitamina C.
3. Il
molibdeno.
- Il
molibdeno è piuttosto co-responsabile per una ordinata produzione di acido
urico; molto probabilmente non è importante per la gotta, che è caratterizzata
o da troppa produzione o da troppo poca escrezione.
- La
treonina è un amminoacido essenziale che:
- Dopo la
trasformazione in glicina raggiunge il cervello rapidamente.
- Ha
effetti sedativi e attenuanti specie in stati maniacali, d¹irascibilità e di
paure.
- La
glicina è un amminoacido non essenziale (sintetizzabile dalla treonina):
- Che
stimola l¹escrezione di acido urico tramite i reni e abassa così l¹uremia.
- Arriva
lentamente anche nel cervello, dove ha gli effetti descritti della treonina, ma
lenti e minori.
- Alte dosi
di vitamina C stimolano anche l¹escrezione di acido urico e abbassano quindi
l¹uremia.
Come primo
approccio (ipotetico, perché, se l¹oligoterapista è bravo, oltre alla gotta
guarda anche altri elementi della sua anamnesi (p.es. stato di Vit. D se
disturbi renali, ) egli proporrà:
- ca. 2
grammi di vitamina C al giorno, ripartita in piccole dosi sulla giornata (non
la sera)
- 14
grammi di treonina in 3 dosi prima dei pasti e/o
- 110
grammi di glicina in una o due dosi prima dei pasti
secondo i
sintomi che il cliente dimostra: ³maniacali² (treonina) o più ³gottosi²
(glicina).
Darà dei
consigli circa la dieta, come un medico accademico o naturalista, e in più
indicherà alimenti ricchi di treonina (soia, lenticchie, trota, pecora, pollo,
arachidi, gemme di frumento, ricotta, semi di girasole, uova crude).
2.3.3 Esiti
di trattamento in genesi somatiche
A livello
pratico anzitutto è da tener presente che non ogni paziente con sintomi di
gotta è un ritratto del sovraesposto ³dirigente caratteriale psichico²:
- La
debolezza biologica metabolica può essere sufficientemente rilevante per far
scattare un attacco.
- Mentre
gli elementi psicosociali possono rivelarsi di minore o minima importanza.
- In questo
caso sicuramente sarà abbastanza promettente una terapia ³biomedica² (sia
canonica sia naturopatica sia ortomolecolare).
- Secondo
la mia esperienza con un trattamento ³biomedico² spariscono spesso anche lievi
sintomi narcisistici e isterici (il che per me è indice, che la psicosomatica
non è a senso unico o causa-effetto, ma circolo vizioso).
2.3.4
Esiti di trattamento in genesi psicosociale
Sarà forse
più frustrante l¹esperienza terapeutica nel caso in cui prevalgano elementi
psicosociali:
- o le
difese ³somatizzanti² sono così forti che la terapia non ³attacca² o essa non
viene seguita. Voi passate come terapisti incapaci e il cliente se ne cerca un
altro, più bravo;
- o la
terapia attacca e butta il cliente in stati d¹animo piagnucolosi,
autocompassionevoli, fino a una serie di crisi di autostima alternate ad
attacchi di megalomania, irascibilità e prepotenza insopportabili per
l¹ambiente sociale e da ultimo socialmente devastanti per il cliente:
- è
improbabile che il terapista venga responsabilizzato per questo, perché il
nesso non è evidente per una persona non istruita e, data la separazione di
compiti nel settore sanitario, con i nuovi malanni il cliente frequenterà un
altro terapista (o andrà in una clinica psichiatrica).
- Se non vi
sentite di fare un lavoro approfondito, vi accontentate di questa situazione e
aspettate che il cliente torni ogni tanto per farsi curare un attacco acuto di
gotta, diventando così ancora più insopportabile per i suoi dipendenti.
2.4 Relativizzazione
dell¹esempio
L¹esempio
della gotta è preciso, con delle informazioni specifiche su meccanismi e nessi
plausibili.
Il limite
dell¹esempio è che non va generalizzato per altri disturbi di tipo
psicosomatico. Altrimenti si rischia di creare dei bei disastri del tipo
³medicina ottima per malattia sbagliata².
Quindi
asma, emicrania, nevralgie, coliche, depressioni, lombalgite e altri disturbi
di sospettata genesi ³psicosociale² hanno come base:
- Altre
predisposizioni biologiche e debolezze metaboliche, ormonali,
-
Tutt¹altri meccanismi di traumi infantili (o meno).
-
Tutt¹altri disturbi di sviluppo di personalità nel contrasto biologico-sociologico.
- Con altre
forme di espressione dell¹ambivalenza.
- Con
difese tutte diverse per mantenere l¹equilibrio labile dell¹ambivalenza.
- Altri
tipi di compensazione comportamentale.
- E infine
altre manifestazioni corporee e comunicative.
Che sarebbero
tutti da chiarire per il singolo caso e da integrare in un quadro plausibile,
come fa il criminalista con i suoi indizi, deduzioni, testimoni, dimostrazioni,
Per la
maggior parte dei disturbi psicosomatici non abbiamo fonti valide come per
l¹esempio della gotta. Ma neppure Schweninger le aveva eppure è riuscito,
grazie alle sue capacità emotive, cognitive e vegetative, con un misurato,
lungo e faticoso processo di percezione, valutazione e comportamento
terapeutico. In questo contesto è meno importante il ³sapere enciclopedico² per
non dire nozionistico.
3.0 Nozioni
di discipline correlate alla psicosomatica:
Sono
dell¹avviso che dovrebbero fare parte integrante della formazione di naturopati
(e anche di altri medici) un¹introduzione alla sociologia, alla psicologia in
generale nonché ³un¹infarinatura² di psicopatologia e di psicoterapia
³verbale².
Malauguratamente
i programmi di formazione abituali non lo prevedono e perciò neanche questo
corso, che si basa su programmi abituali.
Per quanto
concerne la psicologia in genere esiste un¹ampia offerta di libri, corsi serali
e di educazione pubblica. Invito vivamente ogni partecipante a questo corso ad
istruirsi almeno superficialmente in merito.
Per quanto
concerne gli elementi di:
-
psicopatologia e psicoterapia,
ci si trova
davanti al solito problema della scarsità di testi che si rivolgono a noi
naturopati, mentre una formazione completa richiederebbe troppo tempo e soldi e
non sarebbe nemmeno necessaria.
Vi propongo
di leggere il seguente testo:
Invito alla
psicologia,
di
Alessandro Antonietti,
ISBN 88-430-1973-2
Per quanto
concerne la terapie ortomolecolari:
Il termine
³ortomelocolare² venne introdotto da Linus Pauling (premio Nobel): ³medicina
ortomolecolare è il mantenimento di una buona salute e il trattamento delle
malattie tramite il cambiamento di concentrazione di sostanze che si trovano
per natura nell¹organismo e gli sono necessarie².
Gli studi
di Pauling e dei suoi seguaci e successori - specialmente del dott. Pfeiffer -
hanno rilevato che molti disturbi ³psichici² hanno anche una dimensione
³materiale², metabolica e fisiologica che è accessibile p.es. tramite
³micronutrienti². Questo è un campo altamente interessante per noi naturopati e
medici naturalisti. Malauguratamente i testi sono rari, mal distribuiti e
prevalentemente in inglese.
In merito a
questo tema sono previsti dei Seminari. Chi fosse interessato può rivolgersi al
nostro segretariato.
I testi di
riferimento riguardante questi temi sono i fascicoli:
PTO 2 Elementi di terapia ortomolecolare
PTO 4: Terapia ortomolecolare per frequenti disturbi
psichici
disponibili
pure presso il nostro segretariato.
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |


