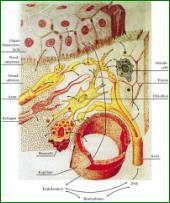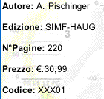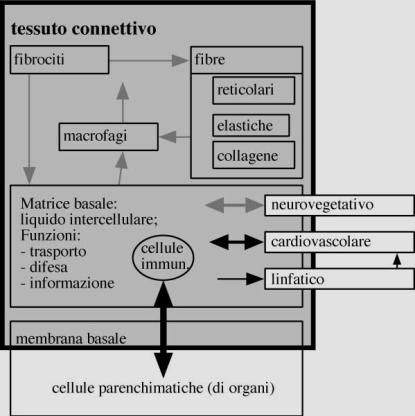|
|
Medicina popolare
per autodidatti
settembre 23, 2005 |
|
Bibliografia:
|
Pischinger, A.: Das System der Grungregulation; 9. Aufl.;
HAUG 1998 Hartmut Heine, Otto Bergsmann, Felix Perger, Gisela
Draczynski Prof. Dr. Pischinger, cattedra per istiologia ed
embriologia dell¹università di Vienna presentò nel1975 la sua opera ³
Sistema della regolazione basale ². Si occupava inizialmente delle proprietà comunicative del
tessuto connettivo. Indipendentemente sono attualmente attive tre grandi
scuole sul campo: - Università di Vienna: regolazione basale: Pischinger,
Altmann, Bergsmann, Fleischhacker, Hopfer, Aiginger, Perger, Flohberger,
Riccabona, Stacher. - Università di Münster: reazione mesenchimatica
universale: Hauss, Junge-Hülsing - Università Witten-Herdecke: Istituto per medicina
antiomotossica e ricerca di regolazione basale. |
|
|
1.0 Struttura
e funzione del tessuto connettivo
Il tessuto
connettivo lasso è composto da fibre e matrice basale prodotte da fibrociti e
decomposte da macrofagi.
1.2 Topografia del tessuto connettivo lasso
1.3 Struttura del tessuto connettivo lasso
1.4 Funzioni del tessuto connettivo lasso
1.1 Riassunto
1.1.3 Matrice
basale come ambiente delle cellule
1.1.4 Modello
originale di Pischinger
-
Connessione meccanica di tessuti parenchimali (specialmente fibre).
- Infrastruttura
³portante, sospensiva² per vasi e nervi (specialmente fibre).
- ³Filtro
reticolare² per microrganismi.
- ³Filtro
molecolare² per macromolecole.
- Substrato
ambientale per processi extracellulari di ogni genere.
- Substrato
ambientale per cellule immunitarie (specialmente matrice).
1.1.2 Compiti funzionali
- Tampone e
magazzino del flusso materiale tra cellule parenchimatiche e vasi sanguigni e
linfatici.
- Tampone
energetico per processi locali.
-
³Discriminatore² per molecole di ³-filia², carica e dimensione diversa.
- Ambiente
per processi biofisici e biochimici extracellulari.
- Ambiente
per reazioni di difesa extracellulare locale e generalizzata.
- Sistema
regolativo per processi biofisici e biochimici extracellulari interdipendenti.
- Sistema
³informatico² extraneurale.
1.1.3 Matrice
basale come ambiente delle cellule
La matrice
basale è l¹ambiente (si potrebbe dire ³il mondo²) delle cellule, che le nutre e
smaltisce i loro detriti e, diffonde i loro prodotti: in essa vivono e muoiono
e si svolgono le loro relazioni.
Evolutivamente,
negli organismi multicellulari a ³respirazione di ossigeno² la matrice basale è
la struttura elementare di approvvigionamento, smaltimento e coordinazione tra
le cellule e lo è rimasta anche negli organismi più differenziati e sviluppati.
In questo senso è il precursore dei sistemi specializzati di:
-
Approvvigionamento/smaltimento (digestione, escrezione, respirazione).
- Logistica
(sistema circolatorio/linfatico e difensivo).
- Coordinazione
(sistemi endocrino e neurale).
In origine
c¹erano probabilmente le singole cellule di un multicellulare a sintetizzare e
decomporre la matrice basale, più in là sembra che fibrociti e macrofagi si
siano specializzati a produrla e decomporla oltre alla loro capacità di formare
anche fibre come strutture portanti e legamenti meccanici tra le cellule
parenchimali.
1.1.4 Modello
originale di PISCHINGER
Come segno
di riconoscenza verso l¹instancabile ricercatore, viene pubblicato qui di
seguito il primo schizzo sulla regolazione basale, pubblicato da Pischinger
nell¹anno 1975.
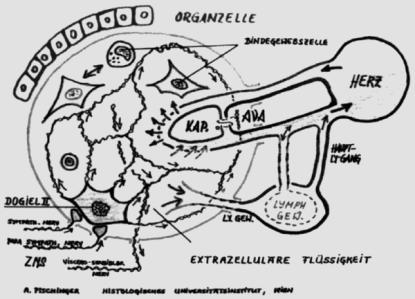
1.2 Topografia
del tessuto connettivo lasso
Il tessuto
connettivo lasso è l¹unica struttura dell¹organismo ³ininterotta². Forma in pratica
le ³pareti² di compartimenti organici e suborganici fino al livello di gruppi
di cellule organiche in un compartimento di approvvigionamento comune. Il
grafico seguente dimostra come esempio a livello macroscopico i grandi
compartimenti muscolari della coscia (I. Rolf: Rolfing; HUGENDUBEL).
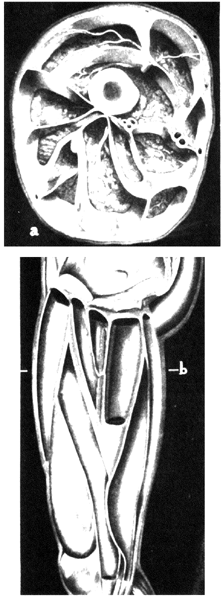
1.3 Strutturadel tessuto
connettivo lasso
L¹immagine
al microscopio della seguente figura (Thibodeau & Patton: Anatomia;
AMBROSIANA) dimostra la rete tridimensionale di fibre collagene ed elastiche
nella matrice basale di tessuto connettivo (nella foto microscopica una sezione
priva di vasi, nervi, cellule del tessuto connettivo (fibrociti).
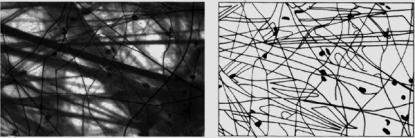
1.4 Funzioni
del tessuto connettivo lasso e della matrice basale
La seguente
figura dà un¹idea dell¹architettura e del flusso materiale e informatico tra le
componenti di cellule/ambiente (Pischinger: Das System der Grundregulation;
HAUG).
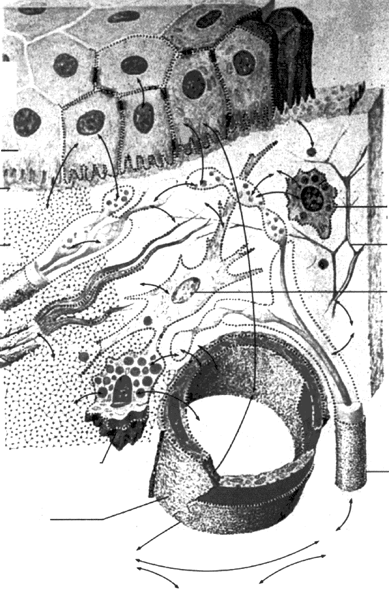
2.0 Struttura
e funzioni della matrice basale
La matrice
basale è una delle sostanze sintetizzate e disposte dai fibroblasti (cellule
del tessuto connettivo). Essenzialmente si tratta di una struttura ramificata
di proteine e zuccheri (glicani).
2.2 Funzioni della matrice basale
2.1.3 Duttilità
e reattività della struttura
2.1.4 Variazione
di produttività dei fibroblasti con l¹età
I
fibroblasti sono fibrociti ³giovani²; distinzione anche in reticulociti piccoli
e grandi.
-
Fibroblasti 1 sintetizzano proteoglicani in forma reticolare.
- Un¹unità
di proteoglicane è ingrandita (2).
- Mostra una struttura ramificata (2a).
- Legato a
una molecola di acido ialuronico (2b).
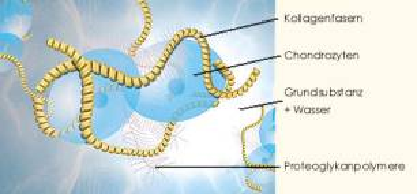
Esempio
tessuto connettivo cartilaginoso (condrociti)
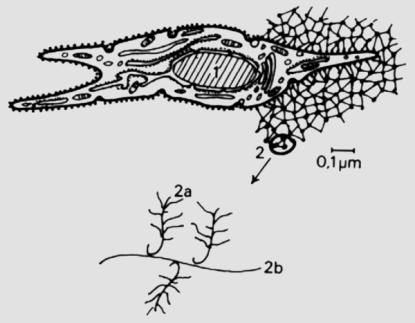
Fibroblasti
producono una struttura di polimeri di proteoglicani
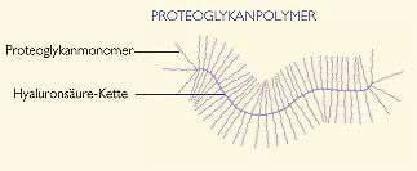
I polimeri proteoglicanici sono monomeri proteoglicanici legati con una proteina a una lunghissima molecola di acido ialuronico (perpendicolari per carica elettrica).
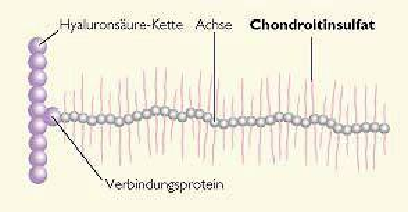
I monomeri proteoglicanici sono
lunghe catene di molecole glicidi-proteici con ciascuna due rami di
condroitinsulfato (perpendicolari per carica elettrica)
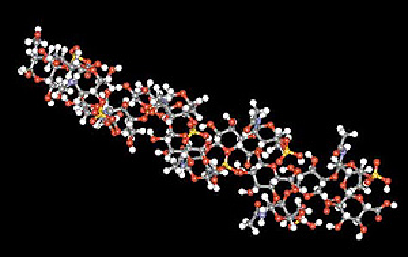
molecola di sulfato di condroitina
(in cartilagine)
Un¹unità
biochimica di matrice basale si chiama ³matrisoma² (³corpo matricale²).
Seguono
nozioni su:
2.1.2.3 Struttura
di molecole proteoglicaniche
La maggior parte delle molecole coinvolte sono biopolimeri di zuccheri (glucobiopolimeri).
Temporaneamente
possono essere integrati nella struttura basale delle proteine transitorie.
Schematicamente
la struttura biochimica di un matrisoma è composta come segue:
-
PG/GAG proteoglicani/
glicosamminoglicani.
-
StGL glicoproteine
di struttura.
-
VGL glicoproteine
interattive.
-
TP proteine
transitorie (p.es. citochine, fattori di crescita, ormoni, enzimi, ).
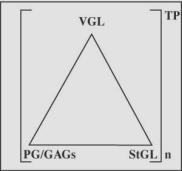
1) proteine
di legatura legano i proteoglicani all¹
2) acido
ialuronico, ³posta in orizzontale² causa di carica negativa come
3) i
polisaccharidi che sono ortogonali alla
4) ³spina
dorsale proteinica².
<-> Interscambio
di ioni.
* Acqua ³cristallizzata² (thixiotropico).
Linee
tratteggiate indicano il ³dominio² di una molecola proteoglicanica.
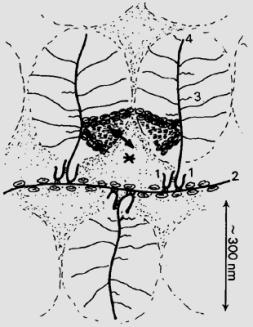
2.1.2.3 Struttura
di molecole proteoglicaniche
Si
orientano secondo una regola delle superfici minime energetiche in iperboloidi
con le seguenti proprietà: l¹interno della ³galleria² è idrofobo/lipidofilo
mentre l¹esterno è idrofilo/lipidofobo. Questo permette un trasporto
contemporaneo di sostanze ³idriche² e ³lipidiche².
Essendo
connesso con il sistema endocrino tramite i capillari vasali e con il sistema
nervoso tramite i terminali liberi di fibre nervose vegetative si forma un
sistema ³comunicativo² (regolatorio passivo) enormemente complesso tra le tre
componenti.
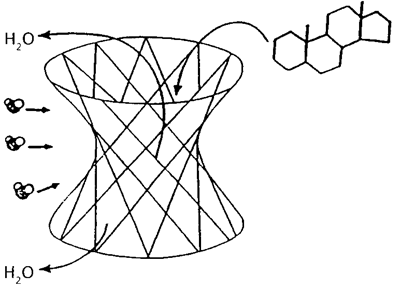
2.1.3 Duttilità
e reattività della struttura
La
struttura basale è altamente duttile verso sostanze acquose o lipidiche grazie
alle capacità discriminatorie delle molecole proteoglicaniche.
La
concentrazione di acqua e l¹orientamento ³cristallino² (thixiotropico) delle
sue molecole in certi areali forma un substrato ideale per processi elementari
come capacità di accumulo calorico, soluzione, diffusione, dissociazione e
legami covalenti, dispersivi ed elettrostatici , tamponamenti acido/base,
processi ossidoriducenti, tensidi di superficie e altri più o meno noti.
La
composizione e struttura della matrice basale cambia facilmente con susseguenti
variazioni di energia potenziale locale e in interdipendenza con l¹energia
cinetica (termica da differenze di temperatura, meccanica con l¹elasticità
delle fibre tessutali) permette una larga gamma di reazioni e trasformazioni
energetiche.
2.1.4 Variazione
di produttività dei fibroblasti con l¹età
Il seguente
grafico mostra la produzione dei fibroblasti in funzione dell¹età. Si nota che
la produzione di proteoglicani raggiunge il culmine durante la prima infanzia,
quella dell¹elastina durante l¹adolescenza e quella dei collageni intorno ai
sessant¹anni.
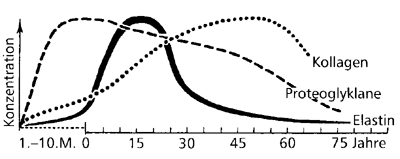
2.2 Funzioni
della matrice basale
Regolazione
fisica, chimica, fisiologica, neurologica, immunitaria.
2.2.1 Trasporto
di sostanze e condizioni energetiche
2.2.3 Altri processi
biofisici
2.2.6 Processi
fisiologici complessi
2.2.7 Reazioni
immunoassistenti
2.2.1 Trasporto
di sostanze e condizioni energetiche
Cellule
parenchimali (di organi specifici) <=> sistema ematico/linfatico.
Ogni organo
così come ogni tessuto e talvolta anche solo loro singole parti, o solo in
determinati periodi, hanno delle esigenze specifiche e molto differenziate per
quanto concerne l¹apporto di materiale o la sua eliminazione, oppure il
rifornimento energetico.
Una bella
parte di questi spostamenti avviene grazie a processi elementari come la
diffusione tra aree con diversa concentrazione (materiale) o conduzione
calorica tra aree con temperature diverse (energetico). Meglio ricordarsi che
nel mezzo si trova una struttura basale con capacità discriminatorie, reattive,
accumulative e regolatore altamente sviluppate.
2.2.1.1 Metabolismo
energetico, muscoli, fegato, cervello
2.2.1.2 Pelle e
tessuti ghiandolari
2.2.1.1 Metabolismo
energetico, muscoli, fegato, cervello
La carica
di trasporto della matrice basale più importante per tutte le cellule sono gli
ingredienti del metabolismo energetico:
- Glucosio
(C6H12O6) e ossigeno (O2) dai capillari alle cellule parenchimali.
- Anidride
carbonica (CO2) e acqua (H2O) dalle cellule parenchimali ai capillari e ai vasi
linfatici.
Questo
prevalentemente nei tessuti intensi di consumo energetico (cervello, fegato,
muscoli). In queste zone, grazie alla grande produzione di energia calorica,
devono essere anche assorbite/asportate notevoli quantità di calore.
2.2.1.2 Pelle
e tessuti ghiandolari
Intorno
alla pelle e ai tessuti ghiandolari invece necessitano notevoli quantità di acqua,
zuccheri e amminoacidi come approvvigionamento, mentre lo smaltimento è
relativamente scarso.
L¹intestino
tenue richiede come approvvigionamento notevoli quantità di acqua e come
smaltimento enormi quantità di glucosio, amminoacidi e lipidi (trigliceridi
soprattutto verso il sistema linfatico).
L¹intestino
crasso richiede pochissimo approvvigionamento, ma uno smaltimento di grandi
quantità di acqua, sali minerali e oligoelementi.
Il tessuto
osseo ha un grande scambio di minerali (Ca, P, Mg, ). Apporto tramite il
periostio, asporto tramite l¹endostio.
Vengono
trattati i seguenti temi:
- Omeostasi
termodinamica
-
Deviazioni reattive patologiche
- Modello
materiale/energetico del sistema basale.
Biopolimeri
di zuccheri, acqua e soluti di sostanze sono gli ingredienti della matrice
basale. I flussi energetici sono dati da flussi di calore e materiale per via
di:
-
adeguamenti di temperatura e
- reazioni
chimiche (legamenti, dissociazioni, ),
- reazioni
fisiche (spostamenti, orientamenti di ioni e molecole),
-
spostamenti di energia potenziale con il flusso materiale.
Lo scambio
materiale e lo scambio energetico sono interdipendenti tramite composizione e
struttura della matrice basale da una parte, entropia (³consumo²) e entalpia
(³produzione²) energetica dall¹altra.
Nel caso
ideale il tessuto basale si trova in un equilibrio fluttuante termodinamico con
la struttura molecolare in movimento spontaneo (ma non casuale). Questa
omeostasi è veramente labile (e facile da variare), ma è la condizione per il
mantenimento di un ordine molecolare in un equilibrio fluttuante biologico.
2.2.2.1 Omeostasi
termodinamica
2.2.2.2 Deviazioni
reattive patologiche
2.2.2.3 Modello
materiale/energetico del sistema basale
2.2.2.1 Omeostasi
termodinamica
In un
sistema tecnico chiuso le collisioni casuali di molecole (movimenti di Brown)
con il tempo instaurano un equilibrio termodinamico stabile (p.es. un pezzo di
ferro ardente in un secchio d¹acqua).
In un
sistema biologico aperto non si tratta prevalentemente di collisioni
(traslatorie) tra molecole, ma di continue variazioni spontanee (non aleatorie)
di stati d¹ordine interdipendenti (p.es. oscillanti) con proprietà
autocatalitiche (catalizzatore: stimola processi senza modificarsi). La
componente spontanea è legata a stati d¹ordine (strutture) in sé labili (non
verso il caos, ma verso altre strutture o stati d¹ordine).
Trattandosi,
nella matrice basale di un sistema termodinamicamente aperto con continue
variazioni di aflussi e deflussi materiali ed energetici, idealmente si imposta
un ³equilibrio labile continuamente variato² per via di innumerevoli processi
autoregolativi ³passivi².
Questo
stato è energeticamente mantenuto fino quando entalpia (³produzione²
energetica) e entropia (³consumo² energetico) si bilanciano.
2.2.2.2 Deviazioni
reattive patologiche
La
reattività di un tale sistema dipende essenzialmente dalle sue capacità
³entalpiche² (produttive) e dalle sue esigenze ³entropiche² (consumistiche).
Un eccesso
di entalpia (³produzione energetica²); quindi un¹ipereattività del sistema
diminuisce smisuratamente l¹ordine (struttura) e trova la sua espressione in
stati strutturalmente riducenti del tipo:
- malattie
acute.
-
infiammazioni
- allergie
-
reumatismi
-
neoplasie.
Un eccesso
di entropia (³consumo energetico²), quindi un¹iporeattività del sistema aumenta
smisuratamente l¹ordine (struttura) e trova la sua espressione in stati
strutturalmente ³fossilizzanti² e forme patologiche come:
- sclerosi
-
gelatinosi
- sarcomi.
2.2.2.3 Modello
materiale/energetico del sistema basale
Lo schema
che segue è un tentativo di illustrare in un modello le interdipendenze
materiali/energetiche nel sistema biologico aperto ³matrice basale² e le
interdependenze con gli altri sistemi biologici aperti direttamente connessi.
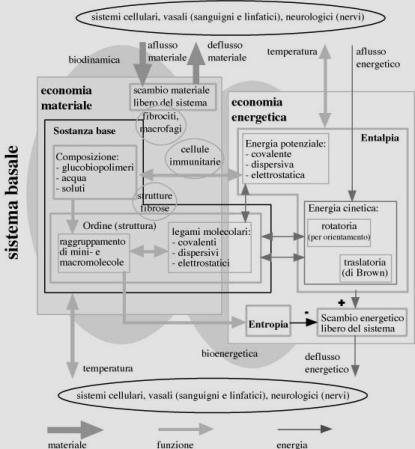
2.2.3 Altri processi biofisici
Oltre ai processi biofisici di spostamento materiale tramite osmosi e differenze di carica e oltre ai processi energetici coinvolti ci sono altri processi biofisici essenziali che si occupano dei meccanismi di regolazione basale:
-
Mantenimento di potenziali di membrana.
- Mantenimento
di valori di acidità.
Vengono
trattati nei seguenti due capitoli. Altri come il mantenimento di potenziali
ossidoriducenti e di tensidi superficiali sono ancora poco studiati.
2.2.3.1 Mantenimento
di potenziali di membrana
2.2.3.2 Mantenimento
dei valori di acidità
2.2.3.1 Mantenimento
di potenziali di membrana
Locale, in
collaborazione con le cellule adiacenti tramite le pompe sodio/ potassio delle
membrane cellulari e il rifornimento delle relative sostanze (Na, K), energia
(per lo spostamento dei ioni) e informazioni (per aprire e chiudere i canali
nelle membrane).
2.2.3.2 Mantenimento
dei valori di acidità
Qualsiasi
stimolo ³irritante² (meccanico, sostanziale, ionizzante, energetico, germinale,
) induce una reazione locale della matrice basale del tipo ³acidosi². I due
tipi di fibroblasti (reticulociti grandi e piccoli) concorrono al mantenimento
dell¹omeostasi acidica locale, l¹una verso ³l¹acidosi², l¹altra
verso²l¹alcalosi².
Quando non
riescono più, l¹acidosi fa scattare meccanismi regolatori ³superiori² e sempre
più distanti (nel senso di una reazione a catena) fino a coinvolgere tutto il
sistema.
A questo punto diventa problematico il termine ³informatico² stesso:
- Se si
intende ³dare una forma² o cambiare da una forma (struttura, ordine) all¹altra
è altamente appropriato per descrivere le interdependenze
strutturali/energetiche esposte nel capitolo precedente.
- Se si
punta più sul termine in senso ³umanizzato² comunicativo è sbagliato, perché
non si scopre bene né mittente né ricevitore né messaggio né interpretazione
dell¹ultimo.
Indipendentemente
dalla valutazione di tutti questi fatti, rimangono, per me, più numerose le
domande delle risposte.
2.2.4.3 Comunicazione
e reazione
2.2.4.4 Accumulo,
impronta e memoria
2.2.4.1 Variazione
e reazioni amplificative
È certo che
una variazione minima locale (come pungere con un ago) può avere come
conseguenza una reazione a catena strutturale/energetica a lunga distanza, in
breve tempo ed eventualmente coinvolgendo altri sistemi (superiori). La
reazione, visto che può mettere in moto tanti processi autoregolativi a livello
sia materiale che energetico, può amplificare di molto l¹intensità dello stimolo.
In questo senso struttura/energia possono comportarsi in modo amplificativo,
una rispetto all¹altra.
D¹altronde
siamo continuamente soggetti a innumerevoli stimoli di questo tipo senza che
essi ci possano scombussolare più di quel tanto. È quindi evidente che il
sistema può comportarsi in modo altrettanto ammortizzante.
2.2.4.3 Comunicazione
e reazione
Comunicativo
e reattivo in questo contesto è l¹elemento di trasmissione e di reazione
strutturale/energetica secondo certe caratteristiche di tempo e di spazio. Le
caratteristiche di trasmissione sono grossolanamente:
- di
³spazio² praticamente da ogni posto dell¹organismo verso ogni altro, visto che
il tessuto basale è ininterrotto tra i tessuti parenchimali;
- in tempi di
trasmissione nell¹ordine di grandezza di frazioni di secondi fino a pochi
secondi;
- in tempi
di regolazione (adattamento) nell¹ordine di grandezza di frazioni di secondo
(processi reattivi locali elementari) fino a ore (processi sistemici
complessi).
2.2.4.4 Accumulo,
impronte e memoria
Visto che
il tessuto basale è capace di ³immagazzinare² le sostanze basilari
(carboidrati, lipidi, proteine, acqua) in strutture ben definite e più o meno
variabili, si potrebbe parlare anche di una capacità mnemonica. Può rimanere
³impresso² un evento o un¹abitudine regolativa come struttura materiale.
A livello
informatico sono noti diversi meccanismi ³patologici²:
- Se la
risposta è tardiva e sistemica a un¹irritazione debole, invece di pronta e
locale anche per un¹irritazione media (come in malattie infiammatorie
croniche).
- Se la
risposta è pronta, sistemica e potente anche per un¹irritazione debole (come
per allergie istantanee) invece di rimanere locale e proporzionata
all¹irritazione.
- Se la
risposta, dopo una fase di ³choc sensato² non ricupera con una controreazione
altrettanto sensata (come nello choc anafilattico).
- Se la
risposta è ³perversa² reagendo all¹irritazione in modo di rinforzarla invece di
compensarla (come nelle malattie allergiche rallentate o autoimmunitarie).
Tamponamento di radicali liberi, deposito di sostanze ambientali e nutritive.
2.2.5.1 Tamponamento
di radicali liberi extracellulari
2.2.5.2 Deposito di
sostanze ³ambientali²
2.2.5.3 Deposito di sostanze nutritive
2.2.5.1 Tamponamento
di radicali liberi extracellulari
Il
metabolismo di organismi a ³respirazione d¹ossigeno² crea grandi quantità di
radicali liberi, nella maggior parte provenienti dalla decomposizione di
glucosio e dalla formazione di ATP.
Gli
organismi hanno sviluppato potenti sistemi di ³antiossidanti² per ³tamponarli².
-
All¹interno della cellula: perossidismutasi, catalasi, glutationperossidasi.
-
Extracellulare: acido ascorbico (Vit.C), Vit.A, Vit.E e.a.
-
Metabolismo sistemico: urea/acido urico.
La matrice
basale ³raffredda² le reazioni antiossidanti e usa l¹energia così guadagnata
per i propri bisogni energetici. Uno squilibrio tra radicali liberi prodotti e
antiossidanti disturba evidentemente l¹omeostasi umorale, cioè processi
biochimici nella matrice basale.
2.2.5.2 Deposito
di sostanze ³ambientali²
Nei generi
alimentari si trovano ca. 1¹000 molecole artificiali; l¹acqua potabile, le
vernici, la plastica e i prodotti voluttuari ne contengono altre. Alcune di
queste fino a certe dosi il corpo riesce a decomporle e ad eliminarle, altre si
accumulano nella matrice e disturbano la regolazione basale quando superano
certe concentrazioni (spesso dopo i 50 anni).
2.2.5.3 Deposito
di sostanze nutritive
I
proteoglicani sono capaci ad accumulare ³scorie metaboliche² di tutte e quattro
le sostanze nutritive:
-
Idrocarburi come glucosio o lattosio.
- Proteine
come gruppi -NH-.
- Grassi in
forma di acidi lipidici.
- Acqua in
forma ³cristallina² (thixiotropio) nei ³domini² dei proteoglicani.
Smisurati
depositi di queste sostanze sono caratteristici per certe malattie:
- Aumentato
tasso di depositi glicidici nella membrana basale: diabetes mellitus.
- Legami
glicidici a proteine (p.es. emoglobina A1c), collagene, elastina,
proteoglicani, albumina, miolina, frammenti di membrane cellulari: processi
degenerativi di senescenza, arteriosclerosi, diabete.
- Proteine
di deposito (collagene & polisaccaridi) possono legare molte altre molecole
come immunoglobuline, lipoproteine, fibrinogene-complemento, albumina,
amminoacidi, glicoproteine, urea, colesterolo, emoglobina e altri.
Superando
una certa concentrazione nella matrice basale impediscono il passaggio di
metaboliti tra vasi e cellule: micro- e macroangiopatie, endarterite
obliterans, claudicatio intermittens, coronarite
Comunque
questi depositi smisurati impediscono una regolazione basale funzionante.
Le capacità
individuali per la rigenerazione sono molto variabili per decomposizione
enzimatica proteolitica e idrolitica effettuata da lisosomi di granulociti
neutrofili o macrofagi.
2.2.6 Processi
fisiologici complessi
Decomposizione
(lisi) di vescicole e cellule, matrice tumorale.
2.2.6.1 Lisi di
vescicole matricali
2.2.6.3 Regolazione
di matrice tumorale
2.2.6.1 Lisi
di vescicole matricali
Le cellule
del tessuto connettivo e del sistema immunitario sono capaci di secernere
elementi vescicolari nella matrice basale, dove si decompongono liberando
molteplici sostanze biologicamente attive:
- Enzimi
proteolitici e idrolitici.
- Diversi
tipi di citochini.
-
Prostaglandine e leucotrieni dalla decomposizione della membrana vescicolare.
Localmente,
gli enzimi sono capaci di decomporre selettivamente proteine e molecole idrolizzate
che sono estranee in questo posto. Le altre sostanze attivano e/o controllano
meccanismi di difesa come infiammazioni locali. Come effetto collaterale questo
meccanismo influisce sull¹acidità (pH) e sul potenziale ossidoriducente locale
e così indirettamente sulla regolazione basale anche a distanza. Influisce
anche sulle funzioni neurali e cellulari.
Citolisi
(la decomposizione di cellule) è il meccanismo opposto alla proliferazione
(mitosi) di cellule. Questi due processi, opposti nel tessuto parenchimale di
una persona dopo l¹adolescenza, è meglio che siano in equilibrio.
È noto che
certe cellule vengono decomposte più di altre (p.es. muta di eritrociti nella
milza probabilmente per esigenze funzionali).
Una
particolare importanza pare avere la leucocitolisi e la lisi di linfociti,
fibrociti e macrofagi per meccanismi di difesa e forse per meccanismi di
adattamento ambientale (materiale, acidità, potenziale di membrana, ).
Nella
leucocitolisi (processo ematico) si hanno enormi quantità di leucociti che si
decompongono, si stima tra 1.2 2 milioni al secondo. Sono aperte tante
domande in questo contesto:
- La
regolazione pare che dipenda da caratteristiche come acidità, potenziale
ossidoriduttivo,
- Pare che
siano attivate da granulociti ed eseguite tramite per ossidazione che libera
sicuramente tante sostanze, fra l¹altro anche notevoli quantità di acidi
nucleici (urea, acido urico,).
- Per
stimolare il processo occorrono sostanze di proliferazione di monociti di
ignota provenienza.
2.2.6.3 Regolazione
di matrice tumorale
In tessuti
normali sono i fibroblasti a generare la matrice basale ³normale². In tessuti
tumorali, le cellule tumorali producono in eccesso acido ialuronico ed enzimi
proteolitici e idrolitici che ledono la ³normale² matrice basale. Questa
situazione facilita la mitosi tumorale e inibisce la differenziazione delle
relative cellule. È quindi importante nella cura di pazienti affetti da tumore
sostenere le riserve e i potenziali di regolazione basale con cosidetti ³metodi
naturali².
2.2.7 Reazioni
immunoassistenti
Diversi
studi confermano che esiste una coordinazione stretta tra il sistema di
regolazione basale e il sistema immunitario. Questo rapporto può essere così
spiegato:
-
Un¹iporeattività della regolazione basale (rigidità regolativa) che per natura
è aspecifica.
- Induce
un¹iperreattività del sistema immunitario (tipo autoimmunitario, allergico) che
è molto più specifico.
In questi
casi vale la pena di controllare lo stato di regolazione basale e se necessario
migliorarlo.
3.0 Fenomeni
biocibernetici di regolazione basale
3.1 Collaborazione dei sistemi gestionali
3.2 Caratteristiche cibernetiche della regolazione
basale
3.3 Fenomenologia della puntura
3.4 Meccanismi di regolazione immunitaria
extranevrale
3.1 Collaborazione
dei sistemi gestionali
La
regolazione basale si trova alla base di tutti i sistemi gestionali
dell¹organismo essendo evolutivamente il più remoto. Si basa prevalentemente
sui processi biofisici e biochimici. In organismi evoluti è inseparabilmente
correlata con i sistemi:
- ormonale
-
immunitario
- neurale
al punto
che in un contesto pratico medico sono spesso indecifrabili le prestazioni dei
singoli sistemi all¹effetto finale.
-
L¹organismo tenta con tutti i mezzi momentaneamente disponibili di salvare la
sua omeostasi.
-
L¹ipofunzione (o l¹impegno altrove) di un sistema gestionale.
- Può
mettere in iperfunzione un altro nel tentativo di sostituirlo.
- P.es.
blocco della regolazione basale e stimolo basale può creare un¹iperrezione
immunitaria come un attacco di asma allergica.
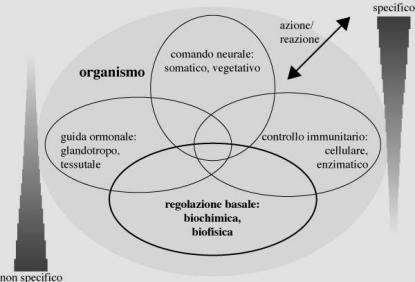
3.2 Caratteristiche
cibernetiche della regolazione basale
- Il
sistema di regolazione basale reagisce in modo integrale ma non uniforme: la
reattività a destra e a sinistra del corpo è parecchio diversa, asimmetrica.
Più un disordine diventa cronico, più simmetrici diventano i parametri a dx. e
sin.
-
Differenze di simmetria reattiva dipendono dalla localizzazione del carico
regolativo (disintegrazione tessutale batterica e non batterica).
- Il
sistema di regolazione basale dispone di una certa autonomia periferica che per
cariche croniche va persa progressivamente.
- Il
sistema basale reagisce in modo non specifico e si sommano stimoli anche molto
diversi (infiammazioni croniche, tossine, deficienze materiali, aberrazioni di
flora intestinale). La somma può causare aberrazioni regolative:
- delle
provocazioni anche minime ma continue (come ³focolai²) sembrano aver un effetto
accumulativo nel senso che si propagano e possono coinvolgere sistemi
superiori.
- Secondo
SELYE il sistema regolativo basale reagisce nel senso di una reazione d¹allarme
e i suoi disordini sono deducibili da questo comportamento.
- Oltre
all¹iperreazione e all¹iporeazione del sistema basale, sono da osservare anche
reazioni ³paradossali² dove un certo parametro reagisce in modo opposto a come
ci si aspetta.
- Una
provocazione del sistema basale crea dapprima una reazione locale che, a
dipendenza dell¹intensità e durata dello stimolo, si propaga e coinvolge ev.
anche sistemi superiori.
- La soglia
dove uno stimolo provoca una reazione integrale coinvolgendo anche sistemi
superiori varia molto tra organismi sani e ammalati come lo dimostra la
seguente tabella indicativa:
intensità
tempo
di intensità
della
dello
stimolo attesa
reazione reazione
integrale
iperreativo (p.es.anafilassi) 100%
<0.5
>200%
diverse reazioni iperallergiche
100%
0.5>1
200%>100%
sano 100%
1
100%
diverse reazioni ipoallergiche 10%<100%
1<2
55%<100%
distonie vegetative 10%
2
55%
diatesi essudative 5%
3
30%
diatesi proliferative 2%
4
17%
cronico-progrediente e tumori
maligni -
5
10%
ante exitum -
-
5%
Significa che più una malattia diventa cronica e meno viene
impiegata la difesa integrale, uno stato fortemente diseconomico con altissimo
consumo energetico che con il tempo porta all¹esaurimento dei sistemi
regolativi come si nota dai ritardi di reazione e dell¹intensità di reazione
ancora possibile.
- Una dissociazione della normale integrazione di sistema
basale e sistema immunitario, associata all¹esaurimento ormonale
(ipofisi-corteccia surrenale) non è più rimediabile con gli strumenti medici
attualmente disponibili.
3.3 Fenomenologia
della puntura
Serve ad
illustrare come un¹irritazione dell¹organismo provoca una reazione sistemica
misurabile nella variazione di diverse caratteristiche.
Pischinger ha
scoperto che irritazioni ³trascurabili² come la puntura con un ago (agopuntura,
neuralterapia, prelievo di sangue) mettono in moto processi di regolazione
basale notevoli e misurabili.
La punzione
causa tre effetti primari:
- Una
microlesione tessutale che distrugge cellule. Secondo POPP le emissioni di
fotoni provenienti da cellule morenti raggiungono le cellule vicine entro 7-10
sec. e si propagano almeno alla velocità del suono (330 m/s) su tutto il
tessuto.
- Gradiente
di temperatura ago/tessuto di ca. 15 C.
- Gradiente
di potenziale elettrico misurabile ago/tessuto.
A livello
di misurazione degli effetti di una punzione si scoprì fra l¹altro:
1)
Differenziazione delle caratteristiche ematiche.
-
Concentrazione di minerali locale e nel sangue venoso.
-
Ripartizione ematociti.
2)
Variazione di leucociti.
- Leucolisi
attivata con fra l¹altro.
-
Ripartizione di immunoglobuline.
3)
Variazione di oligoelementi e minerali.
-
Variazione di consumo di iodio (J).
-
Variazioni di altri oligoelementi come Fe, Zn, Cu, Mn.
-
Variazioni di elettroliti minerali spec. Ca, Mg. K.
4) Uso di
ossigeno periferico.
-
Ossigenazione del sangue venoso (consumo di ossigeno).
5)
Parametri elettrici del derma.
-
Cambiamenti nei valori di polarizzazione del derma.
-
Cambiamento di temperatura dermica.
6)
Regolazione di capillari.
- Flusso
ematico periferico (reologia).
La reazione
del sistema basale di ³persone sane² a una microlesione è diversa dalla
reazione di persone con determinate patologie. Come esempio illustrativo diamo di
seguito i dati di consumo di iodio (determinato in 5 ml di sangue venoso)
all¹inizio dopo un¹ora e dopo tre ore (il prelievo serve contemporaneamente
come primo stimolo e da il valore di referenza):
valori
di consumo di iodio
dopo un¹ora dopo
tre ore
persona sana abbass.
ca 10% torna
alla normalità
allergie immediate aumento
lento
abbass.
allergie rallentate: p.es. reumatismi
infiamm.,
sclerosi multipla, colitis ulcerosa, forte
abbassamento lento
rialzo
malattie consumanti: p.es. tumori maligni,
leucemia, stadi terminali di infiamm. come
tuberculosi, cronici-progredienti mancanza
di reazione o reazione debole
La domanda
critica è perchè la seconda punzione non fa scattare di nuovo un meccanismo di
regolazione: SELYES e LICKINT hanno dimostrato che nel percorso di una reazione
d¹allarme il sistema non reagisce a nuovi stimoli vegetativi. A livello di
consumo di iodio si nota quindi una specie di ³tempo refrattario² di 34 ore.
Di altri
processi coinvolti nella regolazione vegetativa/basale/umorale si sa che i loro
tempi di reazione/refrazione sono anche più lunghi (fino a 5 giorni).
3.4 Meccanismi
di regolazione immunitaria extraneurale
Serve per
illustrare come un¹irritazione dell¹organismo stimoli dapprima il sistema
basale che a sua volta mette in moto i sistemi immunitari, ormonale e
neurovegetativo:
Sono note
quattro fasi cellulari di difesa immunitaria:
Si forma
una ³diga² di istiociti intorno al luogo d¹invasione della sostanza nociva
indotta da:
- Processi
biofisici: acidosi locali (valore pH).
- Processi
biochimici: ormoni tessutali come prostaglandine, leucotrieni, interferoni.
- Immediata
liberazione di reticulociti come istiociti mononucleari.
Questi
processi sono prevalentemente di regolazione ³umorale².
Si
presentano microfagi, ancora reazione locale ma con ³avvertimento
dell¹organismo².
- Aumento
della permeabilità di vasi capillari e invasione di microfagi.
-
Fagocitosi con liberazione di enzimi proteolitici e ossidativi.
-
Formazione di microedema, diluzione della sostanza nociva, presentazione di
immunoglobuline.
-
Correzione pH: mobilizza fonti energetiche (ATP) se la relazione Ca/Mg (Ca
alto, Mg basso) lo permette e se l¹acidosi tessutale cronica non lo inibisce.
Questi
processi sono prevalentemente di regolazione ³umorale².
Appaiono
macrofagi: reazione che coinvolge già attivamente tutto l¹organismo.
- Indotta
da nodi linfatici, regolazione ormonale e regolazione del sistema nervoso
centrale.
- Se la
concentrazione del ³fattore monocitario² (un acido lipidico) è sufficiente.
-
Quest¹ultimo è terapeuticamente disponibile come ELPIMED e applicata s.c. o
i.m. per effetti sistemici, i.c. per effetti locali quando la regolazione
basale è ³rigida²o impedita per via di prevalenti ³choc² organici:
- infezioni
banali ³cronicizzate², traumi cerebrali, chemioterapie;
-
controindicato durante infezioni acute;
- con
precauzioni in casi di infiammazioni croniche (attivazione di fasi acute),
-
postcurativo dopo eliminazione di focolai e tossine e dopo sostituzione di
stati di carenza.
Sono
state fatte ricerche interessanti sul meccanismo di produzione e sulla funzione
dei linfociti.
- Dal
liquido presente nei linfonodi è stato isolato il cosiddetto ³fattore
linfocitario², in grado di influire sulla regolazione ormonale e sul sistema
nervoso centrale, oltre che sulla produzione dei linfociti B e T.
- In base
sperimentale si sono ottenuti risultati promettenti nel trattamento di diverse
forme virali, tumorali e autoimmunitarie.
-
Malauguratamente, le ricerche sono ferme per mancanza di fondi e non è
disponibile un preparato.
4.0 Diagnostica di regolazione basale
I seguenti
metodi ³di laboratorio² sono applicati clinicamente per determinare delle
aberrazioni regolative oppure in che stato di reattività si trova il sistema.
Questo è indicato prevalentemente in caso di gravi malattie croniche ed è
riservato a cliniche specializzate nel settore e medici del ramo. Richiedono
oltre agli alti investimenti in attrezzature corrispondenti, anche personale di
laboratorio altamente specializzato, delle infrastrutture che permettono
numerosi test (perché necessitano parecchi valori nel tempo per determinare
curve regolative) e naturalmente dei medici clinici che sanno interpretare i
risultati e dedurre da questi delle ³aberrazioni di funzionamento² e di trarne
conclusioni per delle cure adatte. È altrettanto difficile come affascinante.
Di seguito
gli strumenti del clinico per:
1)
Differenziazione delle caratteristiche ematiche.
-
Concentrazione di minerali locale e nel sangue venoso.
-
Ripartizione ematociti.
2)
Variazione di leucociti.
- Leucolisi
attivata con fra l¹altro
-
ripartizione di immunoglobuline.
3)
Variazione di oligoelementi e minerali.
-
Variazione di consumo di iodio J.
-
Variazioni di altri oligoelementi come Fe, Zn, Cu, Mn.
-
Variazioni di elettroliti minerali spec. Ca, Mg. K.
4) Uso di
ossigeno periferico.
-
Ossigenazione del sangue venoso (consumo di ossigeno).
5)
Parametri elettrici del derma.
-
Cambiamenti nei valori di polarizzazione del derma.
-
Cambiamento di temperatura dermica.
6)
Regolazione di capillari.
- Flusso
ematico periferico (reologia).
Tutti i
metodi accennati in questo capitolo danno informazioni su stati
riflessivi/regolatori.
Non sono
³patomorfologiche² e quindi costituiscono solo un accessorio a normali esami
diagnostici clinici e parametri biochimici di laboratorio:
4.2.2 Termodiagnostica,
diagnostica a infrarosso
Non si
tratta della usuale palpazione medica, ma di esami di reazioni riflessive di
cute, subcute e muscoli (con minima pressione, basta raggiungere lo strato
relativo) per determinare aree riflettenti. La conoscenza di dermatomi, catene
funzionali cinetiche e altri indici riflessologici facilitano la scoperta di
organi coinvolti.
Dettagli
vedi:
-
Bergsmann, O. & Bergsmann R.: Projektionssymptome; Universitätsverlag
Facultas; Wien 1988
4.2.2 Termodiagnostica,
diagnostica a infrarosso
La
termodiagnostica è un antico metodo medico. Ogni terapista che usa metodi
corporei la usa in modo qualitativo scoprendo con le mani zone ³fredde² e
³calde².
L¹uso
di moderni ³termometri istantanei² permette di rilevare temperature locali che
sono anche una misura di attività del tessuto sottostante e la loro relativa
matrice basale.
- Ditta:
ROST.
Rilevare
termogrammi infrarossi è molto impegnativo per il grosso investimento in
apparecchiature ma permette una vasta diagnostica circa lo stato della
regolazione basale.
- Ditta:
BLOHMKE und HEIM.
Vengono
usati diversi principi:
-
Conduttività (inverso della resistenza elettrica).
-
Differenza di potenziale tra elettrodi.
- La
caricabilità (capacità elettrica) del tessuto.
Inoltre
esistono diversi metodi per rilevare oscillazioni elettromagnetiche proprie
dell¹organismo.
4.2.3.3 Differenza
di potenziale
4.2.3.4 Caricabilità
(capacità)
4.2.3.5 Segnali
elettromagnetici dell¹organismo
Irritazione
della cute con corrente galvanica. In zone di riflesso di disfunzione basale si
sviluppa un rossore che persiste più a lungo che in aree ³sane².
È chiamata
anche ³palpazione elettrica². Sensazioni spiacevoli, soprattutto in zone
sensibili.
Oggi si
misurano specialmente su agopunti (punti terminali delle dita, delle mani e dei
piedi), ma anche altri. Deviazioni dal normale:
- Verso
l¹alto: ipergia (sovrastimolazione, infiammazione, allergia).
- Verso
basso: ipoergia (degenerazione, esaurimento, blocco regolativo).
Le regole
dell¹agopuntura determinano l¹identificazione dell¹organo coinvolto.
Secondo
varie osservazioni il metodo sottovaluta l¹apparato motorio e le sue multiple
capacità di disturbo.
4.2.3.3 Differenza
di potenziale
Metodo
parecchio trascurato nella diagnostica benché spesso dei disordini funzionali
si manifestino dapprima come differenze di potenziale e solo dopo anche nella
conduttività. Ci sono solo due sistemi diagnostici:
-
IMPULS-DERMO-TEST (misurazione di punti).
-
BF-DECODER (diagnostica sinottica bioelettrica).
4.2.3.4 Caricabilità
(capacità)
Si carica
per un determinato tempo un¹area cutanea con una determinata tensione elettrica
e si misura poi la corrente in corto circuito. L¹interpretazione dei risultati
è difficile.
4.2.3.5 Segnali
elettromagnetici dell¹organismo
Sono sul mercato i più svariati marchingeni per determinare tramite processi di risonanza i segnali elettromagnetici dell¹organismo nei disturbi funzionali.
La loro
applicazione richiede tanta esperienza da parte dell¹utente se vuole ottenere
risultati riproducibili anche da colleghi.
L¹obiettivo
delle terapie regolative è di ricondurre dei processi regolativi disturbati
nella loro ³normalità²; ripristinare omeostasi ed economia dell¹organismo.
Questo si combina perfettamente con forme terapeutiche cliniche benché queste
ogni tanto creino disturbi regolatori anche seri come p.es. nel caso di alte
dosi a lungo tempo di corticoidi e psicofarmaci Chi si occupa di questi metodi,
usa di solito un programma terapeutico del seguente tipo:
1)
Eliminazione o delimitazione di fattori che disturbano la regolazione basale
come:
- Cariche
croniche anche minime come p.es. focolai,
-
Esposizione a metalli pesanti come p.es. amalgame,
- ³Veleni²
di lusso (o di miseria) come alcool. tabacco,
-
Sovraconsumo di alimenti come p.es. zuccheri, grassi,
I più
³arrabbiati² terapisti del genere predicano una vita frugale, ascetica,
naturale e vietano quasi tutto quello che potrebbe disturbare la regolazione
basale. Vanno a sospetto: fino alla dimostrazione del contrario è proibito
tutto. I più moderati si impegnano a dimostrare per il caso specifico quale
degli elementi a rischio disturba veramente.
2) Compensazione
di deficit che portano a disfunzioni regolatorie come:
- Vitamine.
- Minerali.
-
Oligoelementi.
- Enzimi.
- Altri
³micronutrienti² come amminoacidi e lipidi essenziali.
I
qualunquisti del genere, per sicurezza ingoiano tutto quello che eventualmente
potrebbe mancare, e poiché costa parecchio, dopo poco tempo lasciano via quello
che forse sarebbe davvero servito.
È un grande
mercato per i produttori di tali sostanze. Il professionista si serve di
anamnesi, sintomi, test biochimici, esperienza e sapere, per determinare e
sostituire seriamente delle deficienze. Costa qualcosa, ma a lungo sicuramente
meno che una somministrazione a sospetto.
3) Ridurre
dei ³circoli viziosi² patogeni regolativi con metodi come:
-
Agopuntura e simili.
-
Neuralterapia e simili.
- Terapie
stimolanti, irritative e deviative.
I tifosi
del genere applicano la loro specialità ³per sicurezza² anche dove la patologia
non lascia sospettare in primo luogo disfunzioni regolative, quelli un po¹ più
sensati, rispettano i limiti dei loro strumenti.
4)
³Ripristinare² disfunzioni regolative con metodi risonativi sembra possibile.
Le
indicazioni e possibilità però pare che siano inversamente proporzionali alla
quantità di dilettanti che si divertono sul campo (ci sono anche seri professionisti,
ma ci vuole tanta esperienza medica).
Vengono
trattati di seguito i seguenti temi:
5.1.3 Escrezione
di metalli pesanti
I diversi
metodi della balneoterapia servono nel senso della prevenzione e della
riabilitazione a curare particolarmente il sistema basale.
Le diverse
tecniche respiratorie tramite cambiamenti di abitudini respiratorie competono
nel senso di prevenzione e riabilitazione a un ordinario funzionamento del
sistema basale.
Una
accurata somministrazione di micronutrienti:
- In senso
generale prepara il terreno (le condizioni) per un buon funzionamento della
regolazione basale.
- Compensa
fasi di aumentato fabbisogno, deficienze e assorbimento difettoso.
- In senso
specifico e a dosi massicce, può servire contro certe patologie come rimedio.
Dettagli
vedi p.es.
-
ZIMMERMANN, M.: Mikronährstoffe in der Medizin, HAUG.
-
BURGERSTEIN, L.: Burgersteins Handbuch der Nährstoffe, HAUG.
Nelle aberrazioni di flora intestinale si distingue tra disbiosi primarie e secondarie con i loro effetti sullo stato di difesa. Le primarie sono frequenti, le secondarie meno frequenti. Esse sono causate da difese extraaddominali deboli e quindi più difficili da trattare.
In presenza
di malattie croniche si trova solo in tre pazienti su 100 una flora intestinale
intatta, gli altri 97 sono disbiotici (più o meno gravemente).
Il piano
terapeutico prevede la seguente terapia:
-
Trattamento dei germi patogeni, miceti, protozoi con farmaci specifici e subito
dopo
- guida
simbiotica intestinale:
- Limitazione di nuove infezioni con nutrienti cotti.
- Acido lattico destrogiro.
- Simbionti intestinali liofilizzati.
- Assicurazione ed ev. somministrazione di acido cloridrico
gastrico (divieto di antiacidi).
- Assicurazione ed ev. somministrazione di fermenti/enzimi
in caso di disfunzioni epatiche e pancreatiche.
Nel giro di
qualche settimana fino a mesi si riesce a risanare così le condizioni
gastrointestinali in disbiosi primarie: in disbiosi secondarie solo se è
possibile nel medesimo tempo stimolare le funzioni immunitarie in modo da
interrompere il circolo vizioso.
Il
³risanamento intestinale² è un campo di battaglia molto proficuo per una gamma
di apostoli e altri individui di buona volontà spesso più dotati di conoscenze
ideologiche che fisiologiche. Questo può andare anche bene per le indigestioni
di un pubblico ricco e annoiato fissato sui ³problemi² di nutrizione e
digestione, diventa criminale nel trattamento di serie malattie croniche.
Per questo
motivo aggiungo le seguenti nozioni:
5.1.2.2 Diagnosi
di aberrazioni
5.1.2.4 Parassiti
e germi patologici
5.1.2.5 Effetti
di disbiosi intestinali
Le aberrazioni primarie hanno diverse cause:
-
Deficienza di acido cloridrico gastrico.
- Massiccia
infezione continua per grandi quantità di alimentari non disinfettati (non
cotti).
- Effetti
tardivi di infezioni gastrointestinali come dissenteria, tifo, intossicazioni
alimentari.
- Terapie
antibatteriche (come antibiotici, sulfonamidi, imidazoli), che danno il via
alla lesione di simbionti intestinali e preparazione del terreno per miceti.
Le
aberrazioni secondarie si trovano in pazienti con seri disturbi di difesa
immunitaria come:
-
Malignomi.
- Terapie
immunosoppressive.
- Stadi
terminali di malattie infiammatorie come sclerosi multipla, tubercolosi,
-
Immunoinsufficienze innate e acquisite.
5.1.2.2 Diagnosi di aberrazioni
Le
aberrazioni della flora intestinale sono misurabili affidabilmente solo dopo Il
1982. L¹impegno è notevole e praticamente fattibile solo dalle feci fresche
(ancora tiepide). Anche se molti laboratori offrono analisi del tipo, c¹è da
lavorare con tanto scetticismo, perchè ci vogliono delle culture
microbiologiche fatte a regola d¹arte.
Un¹analisi
decente richiede i seguenti esami:
- Esami di
qualità e quantità di simbionti.
- Esami di
quantità e di qualità di ³parassiti² e germi patologici.
Un¹analisi
professionale richiede informazioni circa i seguenti inquilini dell¹intestino.
I seguenti
dati furono rilevati in una clinica tedesca tra il 1982 e il 1987 su ca. 1¹700
pazienti con rilevanti malattie croniche.
-
Escherichia coli: nel 45% manca completamente, in molti si riscontrano
deficienze patologiche. Produce fra l¹altro il ³fattore monocitario²,
responsabile dell¹attivazione delle plaques di Peyere i nodi linfatici
intestinali e il fattore linfocitario.
- B.
bifidum; Lactobacillus acidofilus: nel 42% manca completamente, in molti si
riscontrano deficienze patologiche.
Responsabile
per il riassorbimento di minerali e oligoelementi (spec. Fe, Zn) e il
funzionamento regolare dei simbionti stessi.
5.1.2.4 Parassiti
e germi patologici
1) Germi
patogeni:
- Stirpi
patogeni di E.coli.
-
Pseudomonas aeruginosa.
-
Streptococchi alfa e beta- emolitici.
-
Staffilococchi emolitici e non emolitici.
In 20% dei
casi di malattie croniche.
2) Germi
disbiotici:
- Germi
aerobici disbiotici in 80%.
- Germi
anaerobici disbiotici in 77%.
Di malattie
croniche, dimostrano che delle disbiosi ³mescolate² sono frequenti.
3) Miceti
- Candida
albicans (anche spec. e parapsilosis).
-
Trichosporum spec.
-
Geotrichum spec.
-
Rhodotorula spec.
-
Torulopsos spec.
Si trovano
nel 60% delle malattie croniche. Quantità fino a 100 mic./gr sono irrilevanti,
a partire da 1¹000 si osservono i primi sintomi, 10¹000 fino a 100'000 creano
disturbi di intossicazione (putrefazione di alimenti, fermentazione di
zuccheri, prodotti metabolici dei miceti). A partire di 1¹000¹000 mic./gr si
incontrano infiammazioni (coliti).
4) Protozoi
- Cisti di
lambli tra 1330% (epidemia).
- Entamoeba
c. (apatogena), isospora b.; sarcocystis s. raramente.
Lambli sono
forti parassiti di minerali e oligoelementi.
5) Vermi e
le loro uova sono diventati rari. Oxiuri (bambini) e ascaridi si trovarono solo
nel 4% dei casi.
5.1.2.5 Effetti
di disbiosi intestinali
1) Disturbi
di riassorbimento di minerali e oligoelementi ledono notevolmente la regolazione
basale e i susseguenti sistemi.
2) Tossine:
prodotti metabolici dei germi, sostanze di putrefazione e di fermentazione
caricano il sistema immunitario e i susseguenti sistemi.
3)
Impedimento dell¹apparato linfatico addominale con tossine e germi vivi.
Il tratto
intestinale può diventare in questo modo un¹area di disturbo rilevante per
tutti i sistemi regolativi dell¹organismo.
5.1.3 Escrezione
di metalli pesanti
L¹escrezione di metalli pesanti viene spesso stimolata:
- con diuretici:
che eliminano dei minerali utili e lasciano i metalli pesanti dove sono.
- Formatori
di chelati: che legano i metalli pesanti, ma fanno espellere anche tante
sostanze fisiologicament indispensabili. Se inevitabile, l¹esperto li combina
con una somministrazione sensata di queste ultime.
Il modo più
indicato è la somministrazione di 3 x 15mg di gluconato di zinco combinato con
2 x 500mg di vitamina C al giorno per mesi: lo zinco occupa il posto dei
metalli pesanti nell¹organismo e quest¹ultimi vengono espulsi lentamente. Da
consigliare per tutti i risanamenti dentari che liberano notevoli quantità di
mercurio.
Terapie
stimolanti come:
- Sostanze
stimolanti aspecifiche.
- Terapia
febbrile.
-
Ozonoterapie.
-
Omeopatia.
- Desensibilizzazione.
-
Antiomotossicologia.
Possono
servire (nella mano dell¹esperto) specialmente nella fase di riabilitazione
della regolazione basale.
BERGSMANN
ha chiamato l¹agopunto ³finestra sul sistema basale². Descrive sulla base della
regolazione basale molteplici possibilità diagnostiche e terapeutiche usando
l¹agopunto come accesso al sistema di regolazione basale. Questo approccio
certo non è più di tipo ³medicina tradizionale cinese² ma usa delle cognizioni
millenarie di tutta un¹altra cultura per scopi moderni. Chi è del settore e non
limitato a dogmi e terminologie trova un vasto e proficuo campo d¹azione
rispettando anche le condizioni della regolazione basale.
La
neuralterapia può essere un valido strumento per influenzare ³aree di disturbo
a distanza², ³focolai², come:
-
Gola-naso-orecchie.
-
Denti-mandibola-mascella.
- Tonsille.
-
Appendiciti, colecistiti croniche.
- Cicatrici
malguarite con inclusioni.
PERGER la
descrive come valido strumento per ripristinare il potenziale di membrana nelle
aree colpite e così restaurare i meccanismi immunitari che sono in grado di
eliminare il disturbo. Chi è del settore e non limitato a dogmi e terminologie
trova un vasto e proficuo campo d¹azione rispettando anche le condizioni della
regolazione basale.
Certe ³aree
di disturbo² specialmente del tipo ³infezione incapsulata² sono accessibili
solo ai bisturi del chirurgo o del dentista specializzato. PERGER fa notare che
questi interventi sono critici nel caso di regolazione basale decadente e da
non eseguire prima di aver risanato quest¹ultima almeno fino al punto che
riesca a gestire l¹intervento.
Le scoperte
circa il funzionamento e l¹integrazione della regolazione basale nei sistemi di
difesa arrichiscono lo strumentario del medico in quanto permettono di
rispettare, ripristinare e riabilitare le diverse funzioni. In questo senso la
³medicina regolativa² non è rivoluzionaria ma evolutiva.
La medicina
regolativa viene proposta dopo la cura dei sintomi specifici di una malattia
come:
- Fase
acuta di infezioni.
- Attacchi
di malattie sistemiche infiammatorie.
-
Sradicamento di masse tumorali.
Con
l¹obiettivo di ripristinare velocemente delle funzioni normali difensive/regolative.
Così il
paziente viene riabilitato in modo da evitare:
- Recidive.
- Nuovi
attacchi.
-
Metastasi.
In malattie
sconosciute, la medicina regolativa tramite la riabilitazione dei sistemi
regolativi è forse l¹unica possibilità di arrivare a una guarigione o almeno
alla mitigazione della malattia.
La
riabilitazione dei sistemi regolativi (basale, immunitario, ormonale,
neurovegetativo) richiede certe ³correzioni di tiro² in terapia per rispettare
anche le esigenze di ognuno di questi sistemi.
I seguenti
capitoli trattano i temi:
5.2.1 Valutazione
di sostanze terapeutiche
5.2.2 Infiammazioni
sistemiche recidivanti
5.2.3 Riabilitazione
di prestazioni immunitarie
5.2.4 Terapia
conservatrice per scaricare i circuiti difensori
5.2.5 Eliminazione
di campi di disturbo
5.2.7 Indicazioni,
resa e insuccessi di terapie regolative
5.2.1 Valutazione
di sostanze terapeutiche
Per la
scelta di terapeutici specifici si mira a un minimo carico della funzione
basale, nel senso che il buon medico sceglie il rimedio con meno effetti
collaterali.
Molti
medicamenti causano una grave reazione di choc umorale (iperreazione o reazione
paradossale basale) la quale favorisce susseguenti processi allergici. Questo
può succedere anche se lo stimolo esogeno del medicamento è accettabile, quando
persiste una stimolazione cronica basale: le due reazioni si sommano perché i
fibroblasti non sono capaci di distinguere tra bene e male o di reagire in modo
differenziato!
Il test di
nuovi medicamenti effettuati sugli animali non permettono di scoprire effetti
collaterali aspecifici come lo sono i disturbi regolativi di difesa. Molti
farmaci famosi per la fase acuta della malattia, la trasformano semplicemente
dal percorso di ³attacchi² riabilitabile in un percorso cronico-progrediente
difficilmente influenzabile. Farmaci che agiscono in direzione
³immunosopressione² hanno tutti questo rischio e richiedono delle indicazioni
severissime limitate a casi di ultima ratio in senso palliativo.
In seguito
dò alcune nozioni sui medicamenti spesso usati per le patologie croniche/
infiammatorie:
5.2.1.2 Fenilbutazioni
come antireumatici
5.2.1.3 Analgesici
e antireumatici
5.2.1.5 Immunosoppressione
con acotiaprima, ciclosporina e aureoterapia
PISCHINGER
ha sviluppato un medicamento che ammorbidisce a certe condizioni l¹iperreazione
basale; il ³fattore monocitario². Come farmaco è in commercio sotto il nome di
³ELPIMED².
È spesso
combinato con altre cariche regolative in casi che soffrono già di disfunzioni
regolative e si è obbligati a somministrare medicamenti .
5.2.1.2 Fenilbutazoni
come antireumatici
Effetti
voluti antiflogistici e antireumatici; collaterali allergici ed ematologici.
Mescolati con ELPIMED si riduce notevolmente il dolore e si evitano gli effetti
collaterali.
5.2.1.3 Analgesici
e antireumatici
I
salicilati caricano minimamente il sistema basale; ibobrufene e indometacina in
maniera accettabile. Malauguratamente non sempre bastano.
Creano uno
stimolo intenso per il sistema basale ma non sono sempre evitabili.
Raccomandabile
di somministrare la dose giornaliera la mattina tra le 6 e le 8, perché a
quest¹ora il livello di cortisoli è di natura alta e viene sopportato meglio.
5.2.1.5 Immunosoppressione con acotiaprima, ciclosporina e
aureoterapia
Paralizzano
il sistema basale con poche speranze di riabilitazione di quest¹ultimo.
Terapia
rassegnativa accettabile solo come ultima ratio in senso palliativo.
Capita
spesso che dei prodotti efficienti in vitro sono inefficienti nel vivo o creano
reazioni allergiche, causa di choc basale o di arresto di regolazione basale.
L¹aggiunta di ELPIMED garantisce normalmente il pieno effetto antibiotico,
evitando maggiormente delle reazioni allergiche.
Il secondo
grande problema (evitabile) legato all¹uso di antibiotici è il disturbo di
simbionti intestinali: anche gli antibiotici non sono capaci di distinguere tra
bene e male e ledono anche degli elementi utili.
- Rendendo
sensibile l¹ambiente ai miceti e batteri.
- Queste
aberrazione ambientali intestinali (disbiosi) causano assorbimento
difettoso
di:
-
micronutrienti (come vitamine, minerali, oligoelementi) il che:
causa
disturbi rilevanti nei processi di regolazione difensiva con deficienza di minerali:
direttamente nelle funzioni di trasmissione della matrice basale.
-
Deficienza di oligoelementi: inibisce enzimi dei neurotrasmettitori, anticorpi
specifici e immunoglobuline.
È
facilmente evitabile ma spesso trascurato:
-
Somministrazione di acido lattico destrogirante.
-
Somministrazione di simbionti intestinali come E.coli, B.acidofilio, B.bifidum
in forma liofilizzata ca. 2 ore primo dei pasti, altrimenti vanno defecati.
- Uso di
lievito medicinale.
- Uso di
lactulosi.
5.2.2 Infiammazioni
sistemiche recidivanti
Queste malattie sono sensibilissime a reazioni allergiche e infezioni banali aggiunte.
Meglio
prevedere le necessarie misure:
5.2.2.2 Infezioni
banali e attacchi
In genere
la somministrazione di enzimi proteolitici (p.es. WOBENZYM) in dosi da 720 gr
al giorno (resistenti ai succhi gastrici), migliora fortemente la reazione
basale infiammatoria.
Infiammazioni
sistemiche recidivanti, come artrite reumatoide, sclerosi multipla,
colitis
ulcerosa, causano facilmente reazioni allergiformi (autonome o contro
medicamenti).
Una terapia
antiallergica con Ca e antiistaminici è indicata nelle fasi attive della
malattia per:
-
accelerare la remissione,
- diminuire
effetti collaterali di terapie specifiche necessarie,
- diminuire
edemi infiammatori,
- diminuire
la lesione di tessuti.
5.2.2.2 Infezioni
banali e attacchi
Un altro
fattore da rispettare in queste malattie è che anche un¹infezione banale
aggiunta può far crollare il sistema di difesa e causare così un attacco.
Questo rischio può essere minimizzato usando una terapia gamma-globulina umana.
5.2.3 Riabilitazione
di prestazioni immunitarie
La
riabilitazione di funzioni regolative difensive dopo il trattamento specifico è
la ³conditio sine qua non² per evitare delle recidive. Degli esempi dimostrano
che anche dopo 30 anni senza recidive con regolazione difensiva intatta è
possibile una ricaduta se il sistema regolativo per via di gravi traumi (fisici
o psichici) cede. Per questi motivi è meglio conoscere i fattori predispositivi
per stipulare programmi di riabilitazione:
5.2.3.1 Predispositori
a deficienze
5.2.3.2 Programmi
di riabilitazione
5.2.3.1 Predispositori
a deficienze
Oggi si
ritiene che le seguenti situazioni tendano a indebolire le capacità regolative
di difesa:
-
Infiammazioni croniche ³occulte² (in tempi remoti chiamate ³focolai²) viste in
diretto nesso alla malattia acuta.
- Tutte le
forme disbiotiche intestinali.
- Tossicosi
subsintomatiche.
- Stati di
deficienza di ³micronutrienti².
- Campi
irritanti non batterici (in tempo remoti anche chiamati ³focolai²), le
cicatrici con guarigione disturbata, spesso con inclusioni di particelle
estranee.
5.2.3.2 Programmi
di riabilitazione
Per
riattivare delle funzioni regolatorie disturbate bisogna creare delle
condizioni che rispettino i limiti regolativi attuali, quindi si procede a
riattivare tutto il possibile con terapie conservative prima di eseguire delle
cure invasive come tonsillectomie o risanamenti dentari estesi!
5.2.4 Terapie
conservative per scaricare i circuiti difensori
Le più
importanti sono:
5.2.4.1 Somministrazione
di micronutrienti mancanti
5.2.4.2 Guida di
simbionti intestinali
5.2.4.3 Disintossicazione
metalli pesanti
5.2.4.1 Somministrazione
di micronutrienti mancanti
In questo
contesto per i ³micronutrienti² come vitamine, minerali, oligoelementi, in casi
indicati consigliamo di far fare dei ³profili² in un laboratorio serio che usa
secondo il caso sangue intero, siero, urina o anche capelli per determinare gli
stati. Costa parecchio, ma è meno caro che somministrare a tentativo dozzine di
sostanze. I più mancanti nelle nostre regioni, e negli alimenti offerti e
consumati sono:
- Zinco
(anticorpi, immunoglobuline, beta-globuline, disintossicazione,
neurotrasmettitori, insulinasi, ) (p.es. Zinkglukonat BURGERSTEIN 13 p.d. 15
mg).
- Vitamina
C aiuta assieme allo zinco fra l¹altro alla depurazione tossica lenta ma continua (p.es. come polvere di acido
ascorbinico 12 gr p.d. soluto in acqua da bere durante la giornata).
- Calcio e
Magnesio: diretto influsso sulla regoalzione basale (p.es. Dolomit BURGERSTEIN
5 pastiglie p.d.).
- In certe
regioni anche lo Iodio (p.es. sale iodato JURA), e per certe persone Fe e Cu.
- Per
controllare lo stato vitaminico si dà spesso un¹iniezione di vitamine A,
complesso B e C (p.es. PANCEBRI LILLY) Se il paziente si sente marcatamente
attivato, ci sarà una mancanza. In caso di scorretto assorbimento intestinale
inizialmente è meglio l¹iniezione, con il risanamento intestinale si passa man
mano all¹applicazione per via orale.
5.2.4.2 Guida
di simbionti intestinali
Stati di
deficienza di micronutrienti accadono soprattutto per motivi di disturbi
dell¹apparato digerente e relativi assorbimenti difettosi:
- acidità
stomachica insufficiente: impedisce la disinfezione di nutrienti non cotti!
Non è
possibile risanare la flora intestinale senza sufficiente presenza di acido
cloridrico (HCl, se somministrat dall¹esperto, perché deve essere diluito e
dosato con criterio). Per casi meno ³clinici² si usano le ricette ³dispeptiche²
della fitoterapia che stimolano non solo da produzione di succhi gastrici ma
anche del fegato, del pancreas e delle ghiandole intestinali. Chi soffre di
dispepsia gastrica o se la crea con antiacidi, farà meglio a curarla. Inoltre
un¹acidità gastrica sensata permette l¹assorbimento di molti oligoelementi,
specialmente del ferro.
- Disbiosi
e disfunzioni dell¹apparato digerente: come primo approccio vedi i consigli
dati sopra, concernenti le cure con antibiotici. Per un risanamento della flora
intestinale in caso di croniche disbiosi e disfunzioni ci vuole l¹esperto che
dispone anche dei dovuti strumenti per controllare l¹effetto.
- Micosi e
protozoosi intestinali si trattano inizialmente con farmaci specifici.
Da non
dimenticare che nessuno di loro è ³discriminatorio² e così tutti indeboliscono
anche i simbionti intestinali. Quindi subito dopo la cura specifica, si deve
effettuare una cura per normalizzare da flora intestinale.
5.2.4.3 Disintossicazione da metalli pesanti
Stati
d¹intossicazione di metalli pesanti subsintomatici richiedono un¹escrezione
forzata. Spesso a questo scopo vengono usati dei formanti di chelati che hanno
diversi effetti collaterali, p.es. provocano anche l¹escrezione di
oligoelementi essenziali. Per questo motivo preferiamo la somministrazione di
zinco unito alla vitamina C (come descritto sopra), perché lo zinco sostituisce
nei depositi i metalli pesanti indesiderati e ha nel medesimo tempo importanti
funzioni enzimatiche e immunitarie.
5.2.5 Eliminazione
di campi di disturbo
Aree cicatrizzate disturbanti, focolai.
5.2.5.1 Eliminazione
di aree cicatrizzate disturbanti
5.2.5.2 Scarica di
focolai infiammatori cronici occulti
5.2.5.1 Eliminazione
di aree cicatrizzate disturbanti
Disturbano cicatrici con ³guarigione difettosa², specie se sono intasate di particelle.
- Talco da
operazioni.
- Trucioli,
resti di stoffe in incidenti lavorativi e di guerra.
- Granuli
di sabbia, asfalto, vetro da incidenti stradali.
-
Vengono
malamente e lentamente smaltite, portano il tessuto adiacente in acidosi e
modificano così la regolazione basale. Si trasformano in infiammazioni
abatteriche occulte croniche e possono sviluppare effetti a distanza.
L¹acidosi
locale dev¹essere compensata dai due tipi di fibroblasti (i piccoli e grandi
reticulociti con carica elettrica opposta), il che costa per l¹alto consumo di
fibroblasti e spesso non riesce a lungo. Il potenziale tessutale locale e le
cellule adiacenti si depolarizzano e funzionano a malapena.
L¹infiltrazione
di cicatrici con punture di procaina o lidocaina ripolarizza le membrane
cellulari e scioglie il blocco di regolazione basale, così il disturbo può
essere eliminato o almeno regolato. La ripolarizzazione della membrana
cellulare è un fatto biofisico importante per una serie di processi biochimici
a monte.
5.2.5.2 Scarica
di focolai infiammatori cronici occulti
Focolai
sono delle aree infette che la difesa dell¹organismo non è stata capace di
eliminare ma è riuscita almeno a incapsulare. Si trovano spesso vicino a denti
e tonsille ma anche in altre parti dell¹organismo e di solito sono eliminabili
solo tramite intervento chirurgico.
Interventi
di questo tipo (p.es. estesi risanamenti dentari) sono da prevedere solo dopo
una cauta preparazione del terreno e un certo livello di funzionamento della
regolazione basale con le sopracitate misure:
-
Sostituzione di ³micronutrienti² mancanti.
-
Risanamento intestinale.
-
Escrezione di metalli pesanti.
Perché ogni
intervento chirurgico richiede notevoli prestazioni da parte del sistema
basale.
Per questo
motivo sono necessari:
- Una
pianificazione degli interventi a distanza di almeno 3 settimane uno dall¹altro,
perché la regolazione basale e il sistema immunitario richiedono almeno questo
tempo per riprendersi dal trauma.
-
Prevenzione antiallergica (che non impedisce i processi di guarigione) con
calcio e antistaminici.
-
Eventualmente diminuzione di rischi d¹infezioni secondarie o banali,
rinforzando il sistema immunitario.
-
Eventualmente sostegno della guarigione naturale dell¹intervento.
Sono da
evitare l¹applicazione di:
-
Antibiotici che in questo contesto sono obsoleti, perché sopprimono
l¹immunostimolazione ed eccitano reazioni allergiche.
-
Corticoidi che in questo contesto sono obsoleti perché inibendo i processi di guarigione naturale
favoriscono la formazione di focolai rimanenti.
Le misure
indicate fino adesso liberano l¹organismo dalla sua carica, ma la completa
riabilitazione naturale richiede da due a tre anni. In questo periodo è elevato
il rischio di nuove cariche di ogni genere. Per evitare che la regolazione
basale crolli di nuovo è consigliabile una delle cure seguenti, che
parzialmente, oltre che sulla regolazione basale, hanno anche effetto sugli
altri sistemi gestionali:
- sistema
immunitario,
- sistema
ormonale e
- sistema
neurovegetativo.
Senza
essere complete, le seguenti tecniche terapeutiche rinforzano la regolazione
basale:
-
Balneoterapie.
-
Agopuntura.
- Omeopatia
professionale.
-
Neuralterapia.
- Terapie
stimolanti come:
- Sostanze
stimolanti aspecifiche.
- Terapia
febbrile.
-
Ozonoterapie.
-
Desensibilizzazione semispecifica con vaccini propri o estranei.
Obiettivo è
che nell¹arco di 23 anni la soglia di risposta sistemica si alzi a ca. 500'000
germi di un vaccino con una reazione generale breve. Solo l¹organismo di un
cliente sano risponde così, malattie croniche reagiscono già a un decimo o un
centesimo di germi.
La scelta
della cura riabilitativa si orienta secondo le capacità, l¹orientamento e
l¹esperienza del terapista o medico ³eletto². I discorsi sul metodo sono vani,
perché ciascuno funziona nella mano del professionista e meno nella mano del
dilettante.
5.2.7 Indicazioni,
resa e insuccessi di terapie regolative
Dopo più di
quarant¹anni di ricerche sulla regolazione basale al momento si può concludere:
- È
possibile una guarigione di malattie croniche ripristinando normali e armoniose
funzioni immunitarie.
- Senza la
normalizzazione della regolazione basale (come aviatore di processi
immunologici) questo secondo le esperienze non è raggiungibile.
- Le
funzioni immunitarie sia umorali sia cellulari normalmente non sono disturbate
in maniera tale che dopo il ripristino della regolazione basale non possono
riprendere un normale funzionamento.
- Anche a
livello ormonale e specialmente l¹asse ipofisi-surreni di solito riprende le
sue funzioni.
- Il
sistema neurovegetativo (soprattutto i nervi vasali) si ristaura, se si riesce
a trattare in modo sensato l¹aspetto cibernetico e a riabilitare così la
regolazione basale.
Solo dove
la regolazione basale è irreparabilmente ³paralizzata² come capita in
particolare nelle forme croniche-progredienti al momento non vedo delle
possibilità di riabilitarla.
La reazione
primaria locale a un¹invasione tossica non è esclusivamente biochimica
(umorale) ma anche biofisica:
-
l¹ambiente locale diventa più acido (acidosi, spostamento del pH verso valori
inferiori).
Tutti gli
stimoli esterni come:
-
Microrganismi (batteri, protozoi, virus).
- Tossine.
- Traumi.
-
Irradiazioni ionizzanti.
Provocano
questo effetto iniziale che è quindi estremamente aspecifico. Fa scattare lo
³choc umorale². La somma di tutti questi stimoli nel tempo, se supera un certo
ammontare, può ³esaurire la regolazione basale² in modo che a ulteriori stimoli
viene risposto in modo patologico. In questo senso la ³causa² di una malattia
sembra spesso ³la goccia che fa traboccare il vaso².
Dopo questi
cenni generali elenco di seguito delle nozioni più specifiche concernenti:
5.2.7.1 Malattie
croniche in generale
5.2.7.2 Malattie
infiammatorie sistemiche a scatto
5.2.7.3 Malattie
infiammatorie sistemiche croniche-progredienti
5.2.7.4 Malattie
infiammatorie sistemiche idiopatiche
5.2.7.5 Malattie
allergiche del tipo istantaneo
5.2.7.1 Malattie
croniche in generale
È una
vecchia cognizione che una guarigione da malattie croniche è pensabile solo
dopo aver normalizzato le funzioni immunitarie. Anche la vecchia regola che
un¹infiammazione cronica può guarire solo tramite uno stadio di acutizzazione è
rimasta attuale (³vicarizzazione regressiva² della medicina antiomotossica).
Per come si
può risolvere questo compito :
- in
malattie altamente difficili come
- in
infiammazioni sistemiche
- e in
malignomi.
PISCHINGER
ha scoperto le basi e sta ai suoi discepoli e seguaci di risolvere man mano i
numerosi problemi aperti in merito e di spostare i limiti di curabilità dei
disturbi di difesa, fino al massimo possibile.
I sistemi
regolativi biocibernetici concatenati della difesa funzionano solo in modo non
patologico, se l¹avviamento di queste funzioni (nella matrice basale) avviene:
- in modo
ordinato,
- con
intensità (energetica) sufficiente e
- in tempo
utile.
La diagnostica
e terapia ³umorale² di regolazione basale non sostituisce minimamente quella
specifica, ma amplifica le possibilità diagnostiche e terapeutiche in maniera
equivalente.
5.2.7.2 Malattie
infiammatorie sistemiche a scatto
Come
artrite reumatoide, sclerosi multipla, colitis ulcerosa,
- oligo- e
poliartrite sieronegative: 204/1136 pazienti con recidive entro 830 anni
(18%); soprattutto per lo sviluppo di nuovi focolai oppure altre gravi malattie
acute, ma solo 19/204 (10%) di questi non rispondevano più a ulteriori terapie
regolative.
- Sclerosi
multipla: 22/121 pazienti con recidive (18%).
5.2.7.3 Malattie
infiammatorie sistemiche croniche-progredienti
Le prognosi
non sono buone. Per molti pazienti con questa patologia:
- o sarebbe
indicato un risanamento drastico chirurgico che d¹altronde è troppo rischioso,
perchè la regolazione basale non riesce più a gestirlo,
- oppure la
regolazione è al limite delle sue capacità anche per tipi meno drammatici di
risanamento.
Una
riabilitazione è stata possibile in un caso su cinque, gli altri quattro non
riuscirono. Anche nei casi riusciti si tratta di una guarigione ³a difetto²
perché erano irreversibili certe lesioni tessutali.
5.2.7.4 Malattie
infiammatorie sistemiche ideopatiche
Idiopatiche
=> cause o ³tossine² sconosciute o solo sospettate come p.es. infezione da
virus, autoimmunitarie,
Una terapia
specifica è impossibile per questo motivo. Il tentativo di reinstaurare una
regolazione basale ordinata è il tentativo di ripristinare (come avviatore)
delle funzioni immunitarie efficaci, sperando che così l¹organismo riesca a
superare il suo disordine.
Non è
sempre possibile: se la regolazione basale è definitivamente bloccata, la
prognosi è pessima e si può ancora solo ricorrere alla preghiera sperando in un
miracolo.
5.2.7.5 Malattie
allergiche del tipo istantaneo
Il primo
tentativo consiste recentemente in una desensibilizzazione con l¹allergene
specifico (o anche aspecifico con il proprio sangue). Pazienti che non
rispondono a questo tentativo sono particolarmente indicati per le terapie
regolative.
In molti di
loro si nota la presenza di fattori predispositivi come:
-
Infiammazioni croniche occulte.
- Stati di
deficienza in micronutrienti.
- Cariche
di metalli pesanti (specialmente mercurio, anche senza essere allergico al
mercurio).
In una
statistica di PERGER 1978 oltre l¹80% di questi pazienti rimanevano senza
ulteriori attacchi dopo un trattamento riabilitativo regolativo.
In diversi
pazienti con tumori maligni si riuscì a superare la paralisi della regolazione
basale e il fallimento della reazione immunitaria cellulare evitando così
metastasi e recidive. Ma l¹insuccesso recentemente è ancora grande e la
quantità dei casi troppo limitata per poter trarre delle conclusioni.
6.0 Nozioni
su sistemi di regolazione
Ho ritenuto
opportuno introdurre qui un breve saggio su sistemi, processi e meccanismi
regolativi senza i quali anche le più primitive forme di vita sono
inimmaginabili.
Nel nostro
mestiere tutti ritengono importante ³l¹autogestione dell¹organismo² (e quindi
processi omeostatici, regolativi, ) ma sono rari i professionisti che
dispongono di una formazione anche basilare in merito a sistemi,
organizzazione, regolazione ecc., perché nella formazione professionale come
³materie tecniche² sono ritenute di ³non importanza² e praticamente non vengono
insegnate.
6.2 Dinamica organizzativa di processi
6.3 Regolazione e autoregolazione
I sistemi,
oltre alla loro struttura, sono definiti per delle loro proprietà processuali e
descritti secondo il loro comportamento verso condizioni variabili. Questo
testo si dedica prevalentemente a processi regolativi intercellulari che sono
naturalmente in interdependenza con processi di ³comando² e processi di
³guida².
Sistemi:
- Tecnici
(fisico-chimici).
- Biologici
(ecologici).
- Sociali
(economici, politici, culturali).
Sono
definiti, oltre che dalla loro struttura, anche da proprietà processuali e
valutati secondo il loro comportamento ed eventuali capacità comunicative:
6.1.3 Comportamento
di processi
6.1.4 Approccio
cognitivo ai sistemi
La struttura di sistemi è determinata da:
-
composizione (partecipanti, coinvolti, elementi, ingredienti, )
-
disposizione (³architettura², gerarchia, dipendenza, )
-
eventualmente (in sistemi complessi) comunicazione: mezzi, istanze, percorso,
accessibilità,
I sistemi
sono definiti per le loro proprietà processuali:
-
Regolazione come processo che tende a raggiungere un equilibrio tra diverse
caratteristiche.
- Comando
come processo ³tattico²: secondo piani d¹azione per diverse condizioni base.
- Guida
come processo ³strategico² di adattamento a condizioni variabili complesse
secondo ³obiettivi², scale di valori e priorità.
6.1.3 Comportamento
di processi
I sistemi
vengono descritti (giudicati, valutati) secondo il loro comportamento:
- Iper- o
iposensibili (reagiscono al minimo stimolo o solo a uno massiccio, percezione).
- Inerti o
esagerati (si riferisce all¹effetto della reazione, conclusione).
- Lenti e
veloci (di reazione o allo stimolo o fino alla conclusione).
-
Tolleranti o indulgenti (a diverse condizioni come casuali, rari, sbagli, ).
- Selettivi
o qualunquisti (solo a certi o a una lunga gamma di stimoli).
- Più o
meno prevedibili o aleatori secondo la complessità e
- tante
altre caratteristiche.
6.1.4 Approccio
cognitivo ai sistemi
La
riflessione sui sistemi richiede delle abitudini cognitive spesso insolite:
- Al posto
di ³causa ed effetto² diventa più importante il ragionamento in ³percezione e
risposta² di un sottosistema nel contesto del sistema interessato.
- Visto che
³le risposte² di un sistema complesso modificano spesso le condizioni e poi la
percezione, si formano dei circoli (³viziosi² o ³graziosi²) che determinano il
comportamento del sistema.
- Per
questo motivo interessano meno i dettagli di costruzione e funzionamento che il
comportamento del sistema in diverse condizioni e il tempo (durata) che ogni
processo richiede.
- Per
modificare il comportamento di un sistema bastano spesso interventi
apparentemente insignificanti al posto e nel momento ³giusto² e meno
³l¹adattamento² architettonico² o ³funzionale² del sistema.
- L¹arte di
trattare con i sistemi è quella di sfruttare le caratteristiche dinamiche del
sistema stesso limitandosi ad un minimo di intervento centrato: un atto
altamente ³furbo², ³sovversivo² ed economico.
- Nel
nostro mestiere, questo vuol dire sfruttare le capacità di autoguarigione
dell¹organismo umano che significa istruirsi sulle sue abitudini di reazione.
Da notare che questo è solo un particolare del nostro mestiere che si riferisce
al trattamento dell¹essere umano come sistema (quando sappiamo che in realtà è
molto di più).
6.2 Dinamica
organizzativa di processi
Per
descrivere il funzionamento di sistemi complessi uso un modello che si serve di
terminologie tecniche, biologiche e sociali. Secondo le usanze della teoria
dell¹organizzazione distinguo tre compiti principali con relative
responsabilità e competenze:
-
Gestionale.
-
Dispositivo.
- Esecutivo
(o operativo).
Che sono le
funzioni principali di ogni partecipante di un¹organizzazione.
In un
organismo ci sono:
- Cellule.
- Tessuti.
- Organi.
-
Sottosistemi funzionali.
Nel
contesto biologico la cellula è un completo sistema (gestionale, dispositivo e
operativo) capace di svolgere la propria funzione nei limiti dell¹ambiente nel
quale deve funzionare. Il suo ambiente è la matrice basale e il tessuto
connettivo e per una minor parte di cellule anche un ambiente ³esterno².
L¹ambiente
³intercellulare² (matrice basale dei diversi tessuti, liquidi interstiziali)
che forma struttura e infrastruttura di un organismo dispone di capacità
autonome di adattamento a condizioni variabili (soprattutto del tipo passivo) e
di ricchissime capacità di interlocutore tra sistemi funzionali, organi,
tessuti e cellule. I suoi punti forti sono prevalentemente le capacità
esecutive e dispositive nel settore logistico di materiale, energia e
informazione.
Nei
seguenti capitoli sono trattati:
6.2.1 Funzioni
organizzative di sottosistemi di un organismo
6.2.2 Regolazione
basale nel sistema di un organismo
6.2.3 Modello
organizzativo di organismi complessi
6.2.1 Funzioni
organizzative di sottosistemi di un organismo
Si tratta
di distinzioni di prevalenza e non assolute, perché ogni funzione processuale
necessita di tutte e tre, ma in diverse misure. Tra di loro formano sistemi di
adattamento come:
- Sistema
di guida tra gestione e disposizione (neurale; organismi complessi).
- Sistema
di comando tra disposizione e esecuzione (ormonale; organismi differenziati).
- Sistema
di regolazione tra esecuzione e situazione (basale; organismi primitivi,
cellule).
Non è mia
intenzione entrare in questo contesto nei particolari di gestione e
disposizione.
Occorre
però rendersi conto nei discorsi regolativi, che a monte si trovano meccanismi
e istanze che integrano il ³semplice² lavoro regolativo in programmi
dispositivi e in concetti gestionali e ³correggono ogni tanto il tiro²
nell¹interesse maggiore.
6.2.2 Regolazione
basale nel sistema di un organismo
Anche a
livello esecutivo i processi coinvolti nella regolazione basale fanno solo una
piccola parte dell¹operato. In un sistema biologico assistono ³solo² all¹opera
di trasformazione materiale ed energetica (metabolismo). Il loro contributo è
di tipo:
-
³Informatico² in quanto ³comunicano² attivamente o passivamente lasciando
segnali, tracce, interpretabili o decifrabili da altri coinvolti nel
processo.
-
³Energetico² perché i processi di informazione e trasporto richiedono energia.
-
³Materiale² nel senso di trasporto biofisico e di trasformazione biochimica
elementare.
6.2.3 Modello
organizzativo di organismi complessi
Ho tentato
di riassumere e di stilare un modello secondo le ³scienze organizzative² per il
funzionamento sistemico di organismi complessi, differenziati e socializzati.
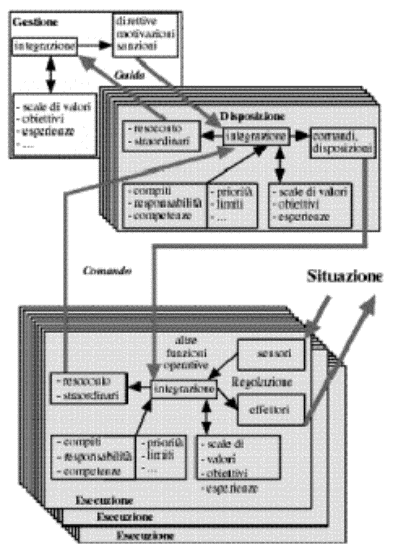
6.3 Regolazione
e autoregolazione
Innumerevoli
sono i processi tecnici, biologici e sociali di ³regolazione ³ e di
³autoregolazione².
La maggior
parte di loro sembra così ³scontata², che non la notiamo nemmeno. Solo negli
ultimi decenni ci si rese conto della loro primordiale importanza per il
funzionamento dei sistemi (cibernetica, regolatori tecnici, sistemica sociale
).
- Quelli di
³autoregolazione² sono processi omeostatici grazie alle proprietà dei sistemi e
delle componenti coinvolte. Il termine autoregolazione si usa prevalentemente
per processi di regolazione ³passiva² (per proprietà innate del sistema) mentre
-
³Regolazione² si applica piuttosto per processi regolativi ³attivi²:
regolazione tramite appositi elementi come sensori, integratori, effettori
Di seguito
vengono trattati i temi:
6.3.1 Processi
di autoregolazione (passiva)
6.3.1.1
Esempio di autoregolazione tecnica ³passiva²
6.3.2 Processi
di regolazione (attiva)
6.3.2.1 Esempio
di regolazione biologica ³attiva²
6.3.3 Degenerazione
di processi regolativi
6.3.1 Processi
di autoregolazione (passiva)
Tantissimi
processi fisici, chimici e tecnici si basano su meccanismi regolativi
³passivi²; sono processi ³autoregolativi. Per il nostro tema interessano di più
processi biofisici e biochimici come p.es.
- La
diffusione e l¹osmosi per processi di trasporto materiale.
- La carica
di ioni per processi di trasporto materiale.
-
L¹affinità chimica (valenza) di atomi e molecole per legami tra loro.
- La
presenza di catalizzatori per processi chimici e biochimici.
- La
presenza di enzimi per processi metabolici.
Le
condizioni di temperatura, pressione, concentrazione di ingredienti, valore pH,
potenziale elettromagnetico, affinità chimica e altri criteri determinano la
possibilità e il percorso di processi. I singoli processi si sviluppano entro
certi limiti ben definiti di questi criteri.
6.3.1.1 Esempio
di autoregolazione tecnica ³passiva²
Come esempio tecno/fisico può servire il serbatoio di un accendino:
- Il
contenuto (metano) si trova allo stato liquido o vaporoso in funzione di
temperatura e pressione locale.
- La
temperatura di ebollizione (passaggio liquido=>vapore) aumenta quando la
pressione aumenta.
- Il
contenitore è costruito in maniera che resiste alle pressioni e alle
temperature ³normali² e che è impermeabile per gas e liquidi coinvolti.
In base a
questi rapporti in un serbatoio chiuso si instaura uno stato di equilibrio
tramite un processo di autoregolazione fisica:
- A
pressione e temperatura ambientale ³umana² evapora del liquido ³metanico².
-
Trovandosi in un serbatoio chiuso, questo aumenta la pressione all¹interno
dell¹accendino fino al punto dove la temperatura di ebollizione (funzione di
temperatura e pressione locale) corrisponde alla temperatura ambientale.
Il processo
degenera funzionalmente quando raggiunge due limiti:
- Quando la
temperatura aumenta al punto che il sebatoio (che perde di resistenza con
l¹aumento di temperatura) non resiste più alla pressione interna (che aumenta
con la temperatura), l¹accendino esplode.
- Quando la
temperatura diminuisce al punto che il liquido gela, cambiano i rapporti tra
pressione e temperatura fino al non più funzionamento dell¹accendino perché
evapora troppo poco gas (in caso di utilizzo) per sostenere la fiamma.
Le due
condizioni corrispondono ³all¹addormentarsi² risp. all¹autodistruzione del
sistema in presenza di condizioni limite.
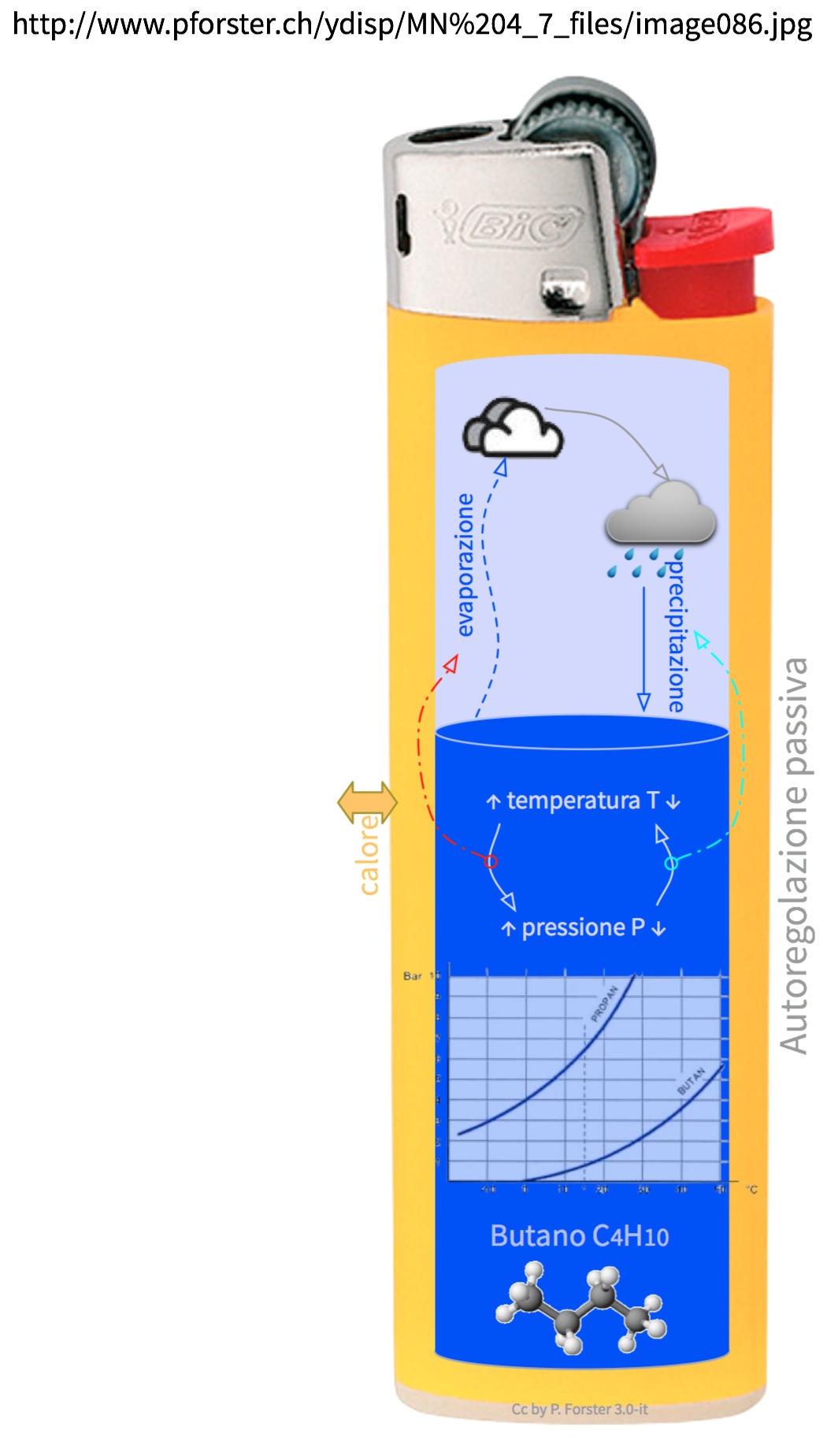
6.3.2 Processi
di regolazione (attiva)
Processi di regolazione attiva dispongono di:
- Istanze
di controllo (sensori, controllori, , comunicazione all¹istanza gestionale).
- Istanze
di integrazione o gestione.
-
Valutazione dei valori di controllo (ev. paragonati con altri criteri) in base
a obiettivi da raggiungere, scale di valori, priorità, emergenze, ...
- Scelta di
modo, strumenti e misura di adattamento.
-
Comunicazione all¹istanza ³effettore².
- Se
opportuno, memorizzazione dell¹evento e correzione di parametri di valutazione
e scelta.
- Istanze
operative (effettori, motori, ...).
È evidente
che una regolazione attiva di questo tipo è più complessa di un¹autoregolazione
ma nel medesimo tempo anche più soggetta a ³errori² di un sistema primitivo
passivo; sono da considerare oltre ai limiti dello stimolo ³regolabile² anche i
limiti delle istanze di controllo, gestionali ed esecutive oltre che i limiti
di comunicazione tra loro.
6.3.2.1 Esempio
di regolazione biologica ³attiva²
Il seguente
esempio mostra un processo biologico di regolazione attiva: la regolazione
della temperatura corporea:
-
L¹esercizio fisico (andare in bicicletta) tramite il lavoro dei muscoli libera
grandi quantità di energia termica nell¹organismo il che porta a un aumento
della temperatura del sangue.
- Sensori
di temperatura nella pelle rilevano questo aumento e lo comunicano tramite
fibre sensitive del sistema neurovegetativo al cervello
- Il cervello paragona i valori rilevati con un valore ³accettabile² impostato, determina la differenza, decide che ci sono da prendere delle misure per abbassarlo e lo comunica al responsabile della regolazione della temperatura corporea, l¹ipotalamo.
- Questo
tramite delle fibre motorie del sistema neurovegetativo aziona la muscolatura
dei vasi sanguigni in modo che si dilatano (effetti di raffreddamento e di
permeabilità) e attiva le ghiandole sudoripare a secernere sudore sulla
superficie della pelle.
- Il
sudore, evaporando sulla superficie della pelle consuma una grande quantità di
energia calorica, abbassando così la temperatura di pelle e sangue.
- Essendo
continuo il processo la regolazione procede fino ad aver trovato un equilibrio
(omeostasi) tra calore prodotto dai muscoli e disperso dall¹evaporazione del
sudore.
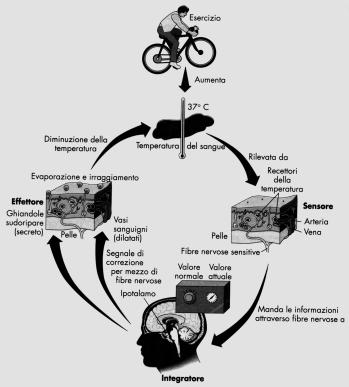
6.3.3 Degenerazione
di processi regolativi
Al di là delle condizioni e dei limiti di ogni genere un processo ³degenera² diventando:
- O sempre
più lento fino all¹esaurirsi (si autoinibisce, addormenta, muore). Anche la
mancanza di stimoli in certe regolazioni attive può portare a questa fine.
- O
autodistruttivo verso il sistema al quale appartiene (si autostimola,
impazzisce, ).
Anche la
sovrastimolazione in certe regolazioni attive può portare a questa fine.
La moderna
³teoria matematica delle catastrofi² mette a disposizione dei modelli per
descrivere le condizioni di regolare funzionamento di sistemi e limiti e
condizioni della loro degenerazione.
Entro i
limiti dei criteri condizionanti il processo richiede tempo. Il valore dei
criteri coinvolti può o accelerare (promuovere) o frenare (inibire) la velocità
del processo. In condizioni stabili il processo ³risponde allo stimolo
promotore dall¹esterno del sistema² aumentando i fattori inibitori fino al
punto in cui promotori e inibitori si bilanciano (equilibrio, omeostasi).
Nel senso
tecnico si definiscono spesso come qualità di regolazione le caratteristiche di
comportamento di un regolatore (attivo) nel tempo come illustrato nel seguente
schizzo:
- Tutto a
sinistra il comportamento di un regolatore fortemente ³ammortizzante²: la
risposta è lenta e non raggiunge più o dopo lunghissimo tempo il valore di mira
(iniziale).
- Tutto a
destra il comportamento di un regolatore ³amplificante²: la risposta crea un
disturbo più grande di quello originale e invece di adattare le condizioni a
quelle di mira comincia a oscillare sempre di più intorno a questo valore fino
alla ³catastrofe².
- Tra i due
estremi il campo di regolazione ³ottimale²: si può (tecnicamente) concepire e
impostare un regolatore in maniera più lenta e stabile (non trabocca dall¹altra
parte) o in maniera più pronta alla risposta e meno stabile (accettando che
trabocchi un po¹ dall¹altra parte).
- In rari
casi possono essere ³ottimali² anche:
- Dei
regolatori ³smorzanti² che reagiscono molto lentamente a variazioni (p.es.
processi di apprendimento di organi di senso specializzati).
- Oppure
dei regolatori che traboccano e creano un piccolo guasto per evitare danni
maggiori (p.es. svenimento per salvare la circolazione).
Il testo stampato è reperibile
presso: LASER, Mario Santoro
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |