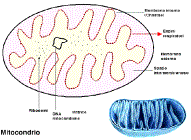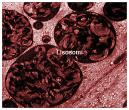Medicina popolare
per autodidatti
ottobre 20, 2005 |
|
|||
Indice della pagina
1 Metabolismo energetico umano 2.2 Flusso delle sostanze nelle cellule 2.3 Produzione energetica a riposo e sotto
sforzo 2.4 La regolazione del flusso del glucosio 2.5 Dinamica della regolazione della glicemia 3 Patologie
del metabolismo del glucosio
Pagine correlate: Metabolismo MmP 12 Download: "Metabolismo
del glucosio" |
MmP 12.3a Metabolismo dei glucidi (metabolismo energetico) © Peter Forster Bianca Buser |
|||
|
Cercare su questa pagina: Explorer:Composizione:Cerca
... oppure |
Cercare sul sito |
|
||
|
1 Il metabolismo energetico umano Il metabolismo energetico umano si basa sia sul * catabolismo (scomposizione) di
acido grasso C 16:0 che sul * catabolismo del glucosio C6H12O6
i quali vengono ossidati (con O2)
in acqua( H2O) e anidride carbonica ( CO2). In condizioni di ridotto sforzo fisico prevale la scomposizione di glucosio nei mitocondri, in condizioni di elevato sforzo fisico la scomposizione di acido grasso nei lisosomi delle cellule dell'organismo. |
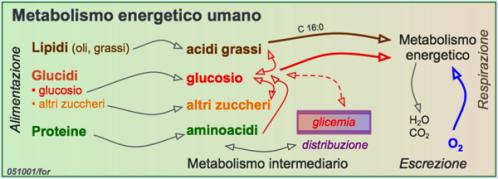
|
Sia l'acido grasso che il
glucosio sono sintetizzati nel metabolismo intermediario delle cellule. Essi
non provengono direttamente dalla digestione di determinati alimenti.
Glucosio e acidi grassi, come anche glucosio e altri zuccheri, possono essere
trasformati a vicenda da specifici enzimi. Gli aminoacidi, invece, possono
essere trasformati in glucosio ma non viceversa. Questo va fatto in continuazione
e ovunque nell'organismo (nei mitocondri cellulari), a dipendenza delle
necessità dei metabolismi strutturali, funzionali ed energetici. La distribuzione di tutte le
sostanze viene fatta per mezzo
della circolazione sanguigna. La concentrazione momentanea di
glucosio nel sangue si chiama glicemia
e si misura (secondo la nazione) in mmol/l (millimol per litro) oppure in mg/dl
(milligrammi per decilitro). E'
di particolare interesse, perché concentrazioni troppo alte (iperglicemia) o
troppo basse (ipoglicemia) sono patologiche: Diabetes mellitus, Ipoglicemia
regolatoria. Tutte le sostanze basilari per
il metabolismo (strutturale, funzionale, energetico) provengono dalla
nutrizione, mentre l'ossigeno è
fornito dalla respirazione. Delle ca. 50 sostanze indispensabili, quelle che
interessano questo contesto di metabolismo energetico, riguardano i lipidi e
i glucidi. Le proteine sono usate anche per
scopi energetici, ma solo quando non servono più ad altro o quando c'è seria
mancanza di glucosio e acidi grassi. Nel metabolismo dei glucidi, più
che i processi biochimici dettagliati, ci interessano: * Il flusso delle sostanze con
le stazioni di trasformazione * Le implicazioni energetiche * I circuiti regolativi 2.2 Flusso delle sostanze nelle cellule 2.3 Produzione energetica a riposo e sotto
sforzo |
|
|
Dal punto di vista alimentare
queste sostanze riguardano i carboidrati digeribili, resi tali in quanto
nell'intestino si trovano degli enzimi atti a scomporli in zuccheri
assimilabili: essenzialmente glucosio, fruttosio, ribosio e galattosio. Negli alimenti, i carboidrati
digeribili sono legati maggiormente sotto forma di: * Amidi: lunghe catene di
molecole di glucosio * Zucchero da cucina: doppie
molecole formate ciascuna da una molecola di fruttosio ed una di glucosio * Malto: doppi legami di
glucosio * Destrosio: altro nome per
glucosio * Fruttosio: reperibile in tutti
negozi e parzialmente in frutta * Lattosio: in latte e in
globuli omeopatici Gli amidi, in cucina vengono
scomposti in catene corte. Più tardi nell'intestino, in fruttosio e glucosio.
Solo in questo modo essi sono assimilabili. Per la concentrazione di
glucosio nel sangue (glicemia) è fondamentale sia la composizione dei
carboidrati negli alimenti, sia i tempi di scomposizione in glucosio e
fruttosio assimilabile. Questo si descrive con l'indice glicemico, una misura che valuta la velocità di assorbimento e la
trasformazione in glucosio. Dopo l'assorbimento del glucosio e di altri zuccheri assimilabili, questi passano nel flusso ematico. Da notare, che solo il glucosio determina la glicemia e non gli altri zuccheri. |
|
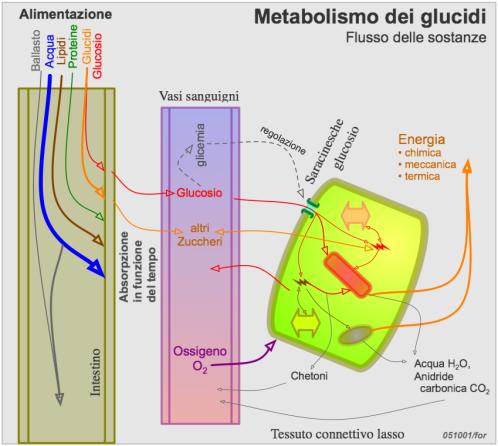
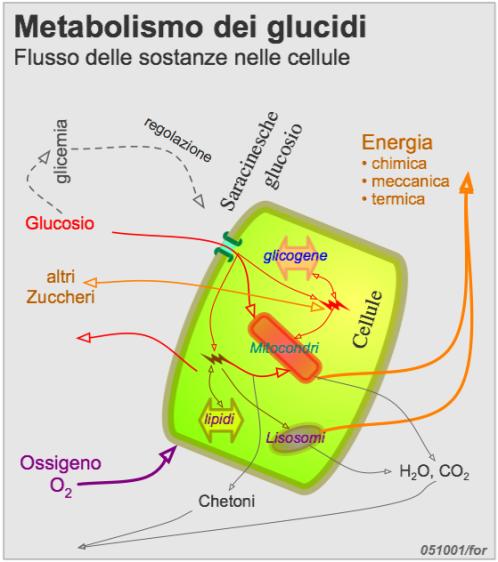
|
|
La produzione energetica
basale avviene
prevalentemente nei mitocondri tramite la trasformazione del glucosio.
Questo è determinato da due fattori: * se il polso è inferiore a (220
età) * 0.5 * se c'è per caso un alto
livello di ormone di crescita in circolazione Ambedue stimolano i processi
biochimici per la produzione
del glucosio necessario (e non
di acidi grassi). Visto che la quantità consumata è piccola (corrispondente a
ca. 20 kCal/kg), se non ci sono impedimenti patologici, questo avviene
facilmente. Esempio: Ho 60 anni. Sotto che polso lavora prevalentemente "a glucosio" la mia centrale energetica? 220 60 = 160 * 0.5 = 80.
Fino a polso 80! |
|
|
Se aumenta la spesa energetica,
man mano cambia il modo di produzione energetica: il lisosomi cominciano a scomporre acidi grassi
ad alta resa meccanica e calorica. I processi biochimici cambiano per mettere
a disposizione acidi grassi e l'esportazione di glucosio viene fermata. Anche
un ormone, la adiponectina promuove questo
meccanismo. Esempio: Ho 60 anni. Sopra che polso lavora prevalentemente a ²acidi grassi" la mia centrale energetica? 220 60 = 160 * 0.6 = 96. A
partire a polso 100 all'incirca! |
|
Ogni tanto, guardando la mia
pancia di riserva, mi controllo. Camminando conto il polso (dita alla
carotide) per 10 secondi e accelero il passo finché ho al minimo 10 battiti
in 6 secondi (polso 100). Non vado mai oltre, perché non
ho nessun allenamento, soffro di ipertensione per cui sono stato consigliato
da un cardiologo ad agire così. La seguente tabella e il grafico
( per persone sane) mostra senza dover fare calcoli i vari rapporti: |
|
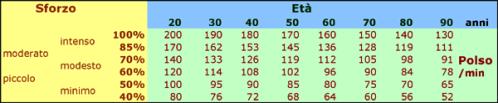
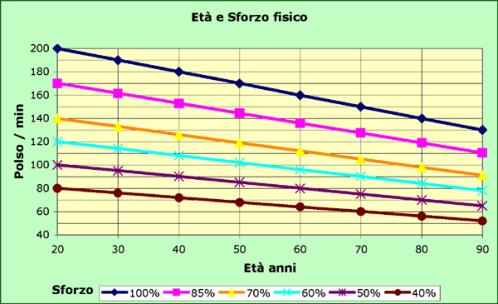
|
Nota: Persone non allenate e / o con patologia
cardiovascolare non dovrebbero mai superare un polso corrispondente a 70%
senza consenso del cardiologo. Altrimenti rischiano lesioni fisiche. Il seguente grafico mostra
approssimativamente quale sia il consumo di glucosio e di acidi grassi come
"combustibili" in diversi sforzi fisici (percentuale elencata
sopra). Ad uno sforzo del 60% si nota che la spesa relativa di glucosio
è pari alla spesa di acidi
grassi. |
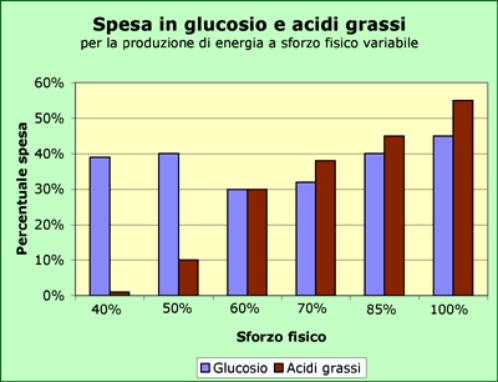
Il seguente schizzo illustra il
metabolismo cellulare durante sforzi minimi e moderati: 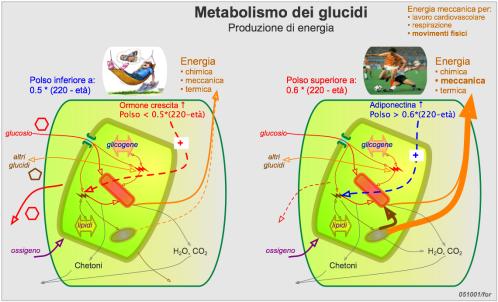
|
2.4 La regolazione del flusso del glucosio La regolazione (informatica) del flusso di glucosio e
di altri zuccheri e acidi grassi, nella discontinuità tra approvvigionamento
alimentare e spesa energetica, è molto complessa. Il flusso del glucosio è di
particolare interesse per il
seguente motivo: * cellule nervose e * eritrociti (globuli rossi del
sangue) non sono in grado di usare acidi
grassi come "combustibile": funzionano solo ³a glucosio². Questo ha enormi conseguenze. I
magazzini di glicogene sono limitati e presto esauriti. Quindi ci deve essere
continuamente una certa concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia), per
garantire un funzionamento ininterrotto della gestione nervosa e della
respirazione (gli eritrociti trasportano l'ossigeno). Se questi due non sono
garantiti (ipoglicemia), dopo
poco tempo vengono a meno le funzioni principali della vita. D'altra parte, elevate
concentrazioni di glucosio nel sangue (iperglicemia) sono tossiche e creano
simili sintomi come per
l'ipoglicemia. Stati duraturi di lieve iperglicemia non creano sintomi
immediati (non ci si accorge) ma a lungo ledono i capillari e gli organi che
dipendono molto dalla microcircolazione. Quindi ci vuole una regolazione
veloce che però non faccia troppi sbalzi in su e in giù. L'inventore ha fatto un apparato
regolatore abbastanza sofisticato basato su delle "saracinesche"
regolabili situate nella membrana di ogni cellula. Grossomodo
funziona così: * L'apertura delle saracinesche
viene regolata da un ormone chiamato insulina * La chiusura delle saracinesche
viene regolata da un ormone chiamato glucagone * Velocità e sbalzi tra apertura
e chiusura sono regolati da un ormone chiamato somatostatina Tutti i tre gli ormoni sono
prodotti nelle isole del pancreas e distribuiti tramite il sangue. A dipendenza del tasso glicemico
il pancreas produce i tre ormoni menzionati sopra e li manda in circolazione.
Raggiunte le saracinesche queste vengono aperte (insulina) o chiuse
(glucagone), di più o di meno secondo il livello della somatostatina. L'entrata di glucosio nella
cellula ne abbassa la concentrazione nel sangue. Viene misurata una glicemia
minore di prima e il pancreas adatta la produzione, e così via. |
|
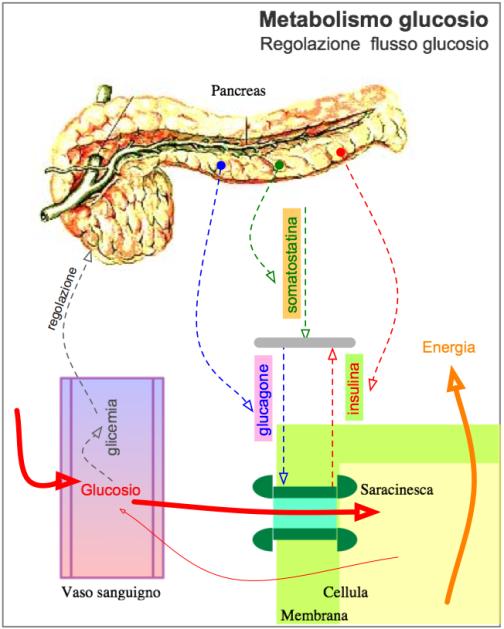
|
In realtà la storia è un po¹ più
complessa in quanto ci sono tanti altri fattori che influiscono, a monte, la
produzione dei tre ormoni. Lo schizzo seguente da un' idea di quali altri
fattori sono coinvolti in questi meccanismi. |
|
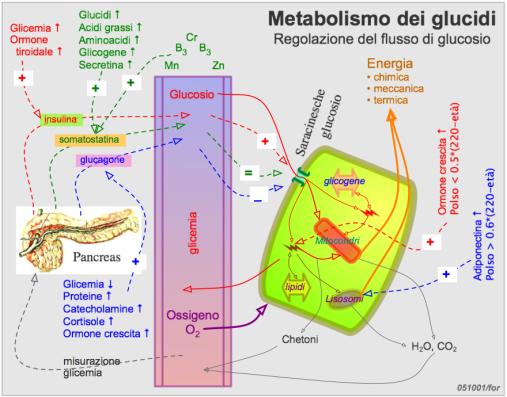
|
Ormone
tiroidale |
prodotto dalla
tiroide per la regolazione generale del metabolismo energetico. |
|
Secretina |
Ormone prodotto
dallo stomaco per avviare la digestione (vagotonia). |
|
Catecolamine |
Ormoni prodotti
maggiormente dai surreni (adrenalina, noradrenalina) per preparare
l'organismo allo stato di allerta (simpatotonia). |
|
Cortisole |
Ormone prodotto
dai surreni; antiinfiammatorio, ormone per preparare l'organismo allo stato
di allerta (simpatotonia). |
|
prodotto
dall'ipofisi in stato di riposo, sonno (vagotonia). |
|
|
Adiponectina |
Ormone prodotto
da cellule lipidiche che stimola l'uso di acidi grassi come combustibile. |
|
2.5 Dinamica della regolazione
della glicemia Il seguente grafico illustra un
percorso di glicemia nel tempo. Esempio * Da un valore a digiuno di 5.8,
dopo un pasto, la glicemia sale rapidamente a ca. 6.6 fino a raggiungere l
¹apice di ca. 7.4. Questo perché il glucosio contenuto nel pasto viene
assorbito ed entra nel sangue. * Con l¹aumento glicemico
riscontrato, il pancreas libera i suoi ormoni, (in maggior misura insulina)
che va in circolazione e raggiunge i ricettori, i quali reagiscono aprendo le
saracinesche. * Il glucosio entra nelle
cellule (esce dal sangue) e la glicemia diminuisce al di sotto del valore a digiuno. * Il pancreas si rende conto e
interrompe la produzione di insulina, stimolando quella di glucagone. Le
saracinesche si chiudono. * Poiché circola ancora glucosio
rallentato dal cibo, la glicemia si alza e dopo qualche adattamento si
normalizza. * La somatostatina durante
questo periodo evita che le
saracinesche si aprano e si chiudano troppo. |
|
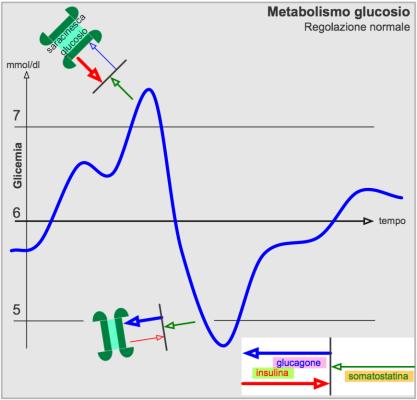
|
3 Patologie del metabolismo del glucosio Le due patologie più frequenti
del metabolismo del glucosio sono: * Il diabete * L'ipoglicemia regolatoria. Si distinguono grossomodo due
tipi diversi che riguardano la patogenesi e la cura del diabete * il diabete I o diabete
giovanile * il diabete II o diabete di
senescenza 3.1 Diabete I o diabete giovanile
Il diabete giovanile si
caratterizza per il fatto che le cellule del pancreas responsabili della
produzione di insulina smettono di produrre quest¹ultima. I motivi riguardano
determinati meccanismi
autoimmunitari che distruggono queste cellule, o malattie virali combattute
in modo anomalo dalle cellule immunitarie (confondono il virus con le cellule
pancreatiche). Fino a pochi decenni fa, in
assenza di insulina iniettabile, (l'unica sostanza fino oggi nota a poter
aprire le saracinesche per il glucosio nelle cellule), il diabete era
letale. Malauguratamente
l'insulina non la si può ingerire perché è una proteina e nel tratto
digestivo verrebbe scomposta in aminoacidi. L¹impegno del diabetico è di
adattare il più esattamente possibile il dosaggio di insulina alla dieta, per non creare sbalzi
glicemici pericolosi. * Per potersi regolare è
importante che il malato conosca
le basi del metabolismo del glucosio. * Sono indispensabili meticolose
istruzioni sulle abitudini nutrizionali e sulle modalità d'uso di insulina
"veloce" e "ritardata". - Per
evitare delle acidosi chetoniche, occorrono come minimo dai 100 ai 150gr al
giorno tra zuccheri e amidi
(corrispondenti a 400 ... 600 kCal di carboidrati). - È
possibile diminuire l¹insulina se il restante fabbisogno calorico è coperto
da oli, grassi e proteine. * Frequenti piccoli pasti
diminuiscono gli sbalzi glicemici. Si può raggiungere questo risultato anche
scegliendo pasti maggiormente composti da alimenti con basso indice
glicemico, p.es. fruttosio al posto di zucchero da cucina, più pasta che pane
e così via (vedi tabelle). * Sostanze come cromo, vitamina
B3, zinco e manganese, tramite la stimolazione della produzione di
somatostatina, aumentano la ³tolleranza al glucosio². Queste sostanze si
trovano in abbondanza nel lievito medicinale. * Particolare attenzione è da
dedicare alla prevenzione dei classici effetti collaterali del diabete che
sono essenzialmente problemi
microcircolatori alle estremità, problemi nervosi, ai reni e agli
occhi. * Non fare esperimenti con
ciarlatanerie a base di tè di cornetti, cannella, peperoncino fino a spaziare
nella vodka; tutte ³stronzate² atte (si fa per dire) a "migliorare il
diabete". Esperimenti di questo tipo possono essere letali. 3.2 Diabete II di senescenza Diversamente dal diabete I, nel
diabete II, la produzione insulinica è normale, se non addirittura esagerata.
Ma le saracinesche non reagiscono più bene ai segnali. Spesso in età avanzata
diminuisce anche la quantità di ricettori (saracinesche). E' evidente
che in questi casi l'insulina
non serve (addirittura danneggia). * La cura inizia con un regime
alimentare più o meno come descritto sopra. * Servono particolarmente
specifici integratori alimentari (Cr, Vit.B3, Zn, Mn p.es. contenuti
in lievito medicinale) e
naturalmente * la prevenzioni ai danni
collaterali e l¹astensione a qualsiasi strano esperimento. Molte volte tutto questo è
sufficiente per tenere la
glicemia entro limiti accettabili. Se ciò non dovesse bastare, sono
utili farmaci come: * Inibitori di assorbimento di
carboidrati * "Biguanidi"
che oltre ad inibire l¹assorbimento, frenano la produzione epatica di
glicogene e aumentano la resa del glucosio nelle cellule * Sulfonylurea che stimola la
produzione insulinica. Questo è indicato solo in rari casi, perché di solito
porta ad un rapido esaurimento delle cellule insulinaproducenti. Di seguito è
indicato l'uso di insulina come nel diabete I. Secondo i medici è una forma
rara, secondo noi è abbastanza divulgata e non diagnosticamente riconosciuta.
Ma è bene che i diabetici (specialmente di tipo I), conoscano l¹argomento,
per essere al corrente del pericolo delle ipoglicemie causate da errate dosi
o da errate applicazioni di insulina "rapida" e
"rallentata". E poi illustra molto bene una dinamica (evolutiva nel
tempo) ipersensibile del metabolismo dei glucidi. Il meccanismo è lo stesso come spiegato
sopra con due differenze * La reazione arriva tardi,
oltre il livello 8 * In compenso, è molto violenta
e le saracinesche si aprono al massimo Questo non causa solo sbalzi
smisurati ma anche un¹ altalena di susseguenti ammortamenti tra iper- e ipoglicemie.
L¹ ingerire spuntini con alti indici glicemici tiene in moto l'oscillazione fatale. Si ipotizza che vi sia una debole produzione di
somatostatina che non riesce ad ammortizzare bene il gioco tra insulina e
glucagone. |
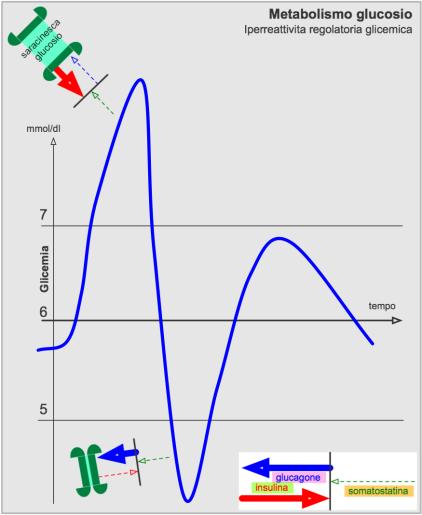
Daniela Rüegg curavit
Carmen Vaucher de la Croix
curavit
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster &
B. Buser via Tesserete, CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul Fair Use : non per scopi di lucro; citazione della fonte. |