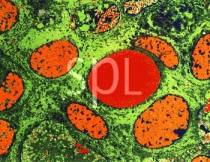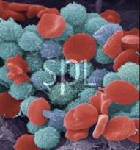|
|
Medicina popolareper autodidatti
luglio 27, 2005 |
|
Indice della pagina 2.1. Concetto naturopatico di tumori 2.2 Concetto clinico di tumori 3.2 Diagnostica tumorale complementare 4.2 Terapie naturopatiche e complementari 5.0 Modelli terapeutici complementari 6.0 Terapie naturopatiche di tumori 6.1 Sinottica di terapie complementari 6.4 Peptidi di milza e fegato, organosieri |
PT 1.2 Elementi di
oncologia clinica e complementare
© Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: MmP 6.4
|
Testi usati e
raccomandabili:
Pianezza, M.: Cancro
oltre la chemioterapia,
Edizioni
Raphael, 1998
Richiede un po¹ di conoscenze
fisiologiche, biochimiche e immunitarie. Contiene una esauriente bibliografia.
Kuno M. D.: Krebs
in der Naturheikunde,
Pflaum
2002
Richiede conoscenze
naturopatiche. Discute i concetti e le applicazioni terapeutiche.
Hobohm: Wegweiser
zur Krebsheilung,
Edizioni
Irisiana, 2000
Presentazione e valutazione di
terapie complementari anche per non professionisti.
Grossarth-Maticek R.: Systemische
Epidemiologie ,
de
Gruyter, 1999
Descrive prevalentemente
fattori rischio comportamentali e relative prevenzioni ³razionali².
Basi
e concetti, diagnosi tumorale, terapie di tumori, modelli terapeutici
complementari e terapie naturopatiche.
|
|
|
|
Cellule tumore al seno |
Cellula carcinoma al seno |
|
|
|
|
Cellule leucemiche nel sangue |
Cellule immunitarie
"killer" attaccano
cellula cancerosa |
Naturopatici
e clinici.
2.1. Concetto
naturopatico di tumori
2.2 Concetto
clinico di tumori
2.1 Concetto
naturopatico di tumori
I
naturopati partono prevalentemente da un modello multifattoriale con diversi
disturbi funzionali e deficienze nell¹organismo del paziente come:
- deficienze del sistema immunitario
- disturbi ormonali
- disturbi elettrolitici e di oligoelementi
- deficienze di vitamine
- disturbi nell¹economia calorica
- disturbi d¹equilibrio acido-base
- disturbi di ³disintossicazione² e
defecazione
- disturbi digestivi intestinali
- disturbi di respirazione cellulare
- disturbi ³psico-mentali-spirituali².
2.2 Concetto
clinico di tumori
Classificazione,
cellula patogena e patogenesi.
2.2.1 Classificazione
di tumori
2.2.2 Caratteristiche
della cellula cancerogena (rispetto ad una ³sana²)
2.2.1 Classificazione
di tumori
Secondo
l¹effetto patologico in benigni, maligni e semimaligni.
I
tumori benigni crescono lentamente e sono ben delimitati dal tessuto vicino.
Possono scostare il tessuto adiacente, ma non lo invadono. Non creano
metastasi.
Se
si escludono i problemi dovuti all¹effetto di massa del tumore stesso, ma ad
eccezione dei tumori benigni del cervello, che a secondo della loro massa e
localizzazione possono compromettere funzioni vitali, normalmente questi tumori
non sono letali.
I
tumori benigni sono:
- adenoma: ghiandole
- polipi: mucose
- fibromi: tessuto connettivo
- lipomi: tessuto lipidico
- miomi: tessuto muscolare
- osteomi: tessuto osseo
- condroma: tessuto cartilagineo
- angioma: tessuto di vasi sanguigni.
2.2.1.2 Tumori
maligni
I
tumori maligni si sviluppano velocemente, non sono ben delimitati verso il
tessuto circostante e lo invadono, possono diffondersi attraverso i vasi
sanguigni e linfatici e formare metastasi (tumori secondari in organi lontani).
L¹integrità del paziente viene seriamente lesa fino alla cachessia (deperimento
con estrema magrezza e perdita delle forze) e la morte.
Tumori
maligni sono:
- carcinoma: epitelio
- sarcoma: mesenchima.
Sono
invasivi localmente, ma non formano metastasi come p.es. il basalioma.
2.2.2 Caratteristiche
della cellula cancerogena (rispetto a una ³sana²)
- Grandezza e forma dei nuclei variabili
- membrana non sferica
- plasma e organuli più variati
- aumentato metabolismo energetico
- rate di proliferazione aumentata
- rate apoptosi (suicidio cellulare)
diminuita.
Dopo
un¹ipotesi di Pott 1775 sui cancerogeni e una di Ramazzini 1700 sui fattori di
rischio, nel 1949 si univano i due pareri in un modello che spiega le modalità
e le cause possibili dello sviluppo di un tumore.
All¹origine
si pensa che ci sia un¹interazione tra i fattori cancerogeni e il materiale
genetico delle cellule, in modo che la procreazione della cellula consiste in
una mutazione della cellula stessa (funziona diversamente). L¹iniziazione può
essere un singolo evento, che non basta però per permettere alla mutazione di
procrearsi rapidamente e di invadere. Per questo si pensa sia necessario un
³promotore² continuamente presente che favorisca lo smisurato ripetersi delle
mutazioni.
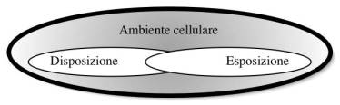
Il
modello lascia aperte diverse domande come, ad esempio, le condizioni genetiche
per la sopravvivenza di mutanti o il ruolo del sistema immunitario di
neutralizzare quest¹ultimi.
Si
pensa che i tumori abbiano una durata di latenza che varia da 10 ai 20 anni.
Questo concetto è in contrasto con l¹esistenza dei tumori infantili.
2.2.3.1 Cancerogeni
e nascita dei tumori
2.2.3.2 Promotori
e fattori a rischio
2.2.3.1 Cancerogeni
e nascita dei tumori
Sono
molti i fattori cancerogeni conosciuti:
- agenti chimici come gli idrocarburi
policiclici prodotti da processi di combustione incompleti
- amine aromatici, nitrosamine, amianto con
fumo, arsenico
- tossine di diversi miceti come
aflatossine (muffa di noci)
- cancerogeni fisici come raggi ionizzanti,
ultravioletti, implantati
- cancerogeni virali.
2.2.3.2 Promotori
e fattori a rischio
Si
sa poco e si specula molto; ³di moda² sono gli episomi (sostanza genetica di
virus in forma di un libero anello di DNA nel nucleo della cellula) che
dovrebbe permettere al tumore di diventare invasivo.
Come
fattori ³a rischio² si cita spesso il fumo (moltiplicatore 1520) per neoplasmi
di polmoni, laringe, esofago, stomaco, la ³nutrizione² (ma non è chiaro quale e
in che misura promuove e che tipi di neoplasmi) nonché lo stress
(moltiplicatore 1020) per le diverse forme di pressoché tutti i neoplasmi.
Sono
note più di diverse sostanze specifiche cancerogene e condizioni ³mutagini² che
aumentano i rischi.
Nonostante
l¹importanza preventiva e di sanità pubblica della conoscenza dei fattori
rischio (e di diagnostica) ho la forte impressione, che le centinaia di
miliardi di dollari investiti negli ultimi 50 anni nella ricerca del cancro
hanno reso risultati terapeutici deludenti. Ogni tanto penso che la moda medica
di trattare rischi distrae solo dal brutto fatto di incapacità curativa.
La
diagnosi di tumori è diventata un elemento importante di economia clinica e
medica. È in tanti casi discutibile la relazione tra impegno ed effetto.
3.2 Diagnostica
tumorale complementare
Ricerca
del tumore tramite:
- ultrasuoni
- radiografie
- risonanza magnetica
- endoscopia
- isotopi radioattivi (medicina nucleare)
- tomografia assiale computerizzata (TAC).
Quando
c¹è un sospetto, in certi casi si procede ad una biopsia (con ago o operazione)
e si cerca la verifica con analisi di laboratorio, tramite:
- marcatori diretti o indiretti di tumori
e/o
- disturbi funzionali organici (chimica clinica,
ematologia).
Vi
sono anche ³markers² = (indizi, marcatori) tumorali, in genere proteine
prodotte dal tumore, che si possono rilevare nel sangue. Sono esami per la
maggior parte aspecifici, che vanno usati in un contesto clinico. Raramente
indirizzano verso una diagnosi (eccezione per fetoproteina nel caso di
carcinoma epatico), ma sono di utilità nel follow-up (monitoraggio) del
paziente durante e dopo la chemioterapia.
3.2 Diagnostica
tumorale complementare
- Microscopia citoplasmatica a campo scuro.
- Procedure di
essicazione/cristallizzazione del sangue.
- Procedure bioelettriche/biorisonanza.
- Radioestesia, diagnostica dell¹occhio.
- Procedure biochimiche.
- Stati immunologici.
Lo
stato immunologico determina la composizione della popolazione di cellule
immunoattive. L¹esperto in materia riesce:
- a dedurre l¹attuale attività e
coinvolgimento dei diversi ³riparti² del sistema immunitario
- a intervenire applicando determinate
sostanze per stimolare la produzione di certe subpopolazioni
- a controllare l¹esito di interventi.
Anche
queste analisi sono impegnative visto che durante una terapia sarebbero
necessarie abbastanza frequentemente, ma permettono una buona gestione della
terapia.
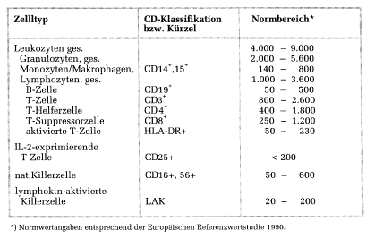
Nelle cure tumorali complementari a richiesta ci
rivolgiamo spesso al sistema immunitario ³riparto tumorcontrollo² e ci serviamo
quindi di questa diagnostica per programmare le misure e controllarne l¹esito.
Questo, se gli oncologi o il medico di condotta collaborano, perché la prescrizione
a carico delle casse malati è monopolizzata, mentre a farli privatamente é
abbastanza caro (ca. 300.- Fr. per analisi di ogni prelievo).
Clinicamente
si trattano i tumori:
- chirurgicamente
- con farmaci (chemioterapia)
- con raggi ionizzanti (radioterapia).
Spesso
si trattano i tumori anche con una combinazione di queste terapie, sempre nel
tentativo di ³sradicare² il tessuto mutato. Poco si fa invece per rendere
difficile la procreazione del tessuto e per fortificare i meccanismi di
autodifesa dell¹organismo.
4.2 Terapie
naturopatiche e complementari
- Distruzione di cellule aberrate con
sostanze chimiche (chemioterapia), con raggi ionizzanti (radioterapia) e
interventi chirurgici
- come prevenzione diverse misure
farmacologiche (es. terapie ormonali)
- come coadiuvanti psicoterapie
specializzate (oncopsicoterapia, psiconcologia).
4.1.1 La
chirurgia
Essa
tenta di asportare in modo più completo possibile il tessuto infetto, cosa non
facile:
- vista la difficoltà di trovarlo nel
corpo e poi
- di distinguere quello malato da
quello sano.
Se
c¹è un dubbio di propagazione si devono anche asportare i nodi linfatici, che
drenano la zona. In più si deve garantire il funzionamento degli organi ridotti
(p.es. intestino) e prevedere un risultato esteticamente accettabile (p.es.
mammella).
Asportando
i tumori localizzati, la maggior parte di massa tumorale, la
³sopravvivenza 5 anni² aumenta del
1020% verso ³non trattamento² secondo il tipo del tumore, la grandezza ed
eventualmente metastasi.
Essa
tenta di avvelenare le cellule tumorali senza ledere troppo quelle sane. Si
tiene in considerazione il fatto che le cellule tumorali sono un po¹ più
sensibili a certi agenti tossici delle cellule ³normali². Cosa altrettanto
difficile è il dosaggio che deve essere ³sicuramente² letale per le cellule
tumorali ma non per il paziente.
La
³sopravvivenza 5 anni² aumenta 15%, molto di più se combinate con terapie
complementari, perché spesso la clinica licenzia questi pazienti in stati
pietosi cachessici e serie deficienze immunitarie. Così noi naturopati abbiamo
il nobile compito di combattere effetti collaterali, curare diete e integratori
alimentari di riconvalescenza, ripristinare flore mucotiche e riattare funzioni
immunitarie.
Anch¹essa
tiene in considerazione il fatto che le cellule tumorali sono più sensibili ai
raggi ionizzanti (e al calore da essi sviluppato) delle cellule ³normali².
Difficile
è stabilire la dose di raggi, e con quale intermittenza somministrarli, e su
quale area di tessuto, per evitare gravi ustioni.
La
³sopravvivenza 5 anni² aumenta 510%. Del resto per le terapie complementari
vale (in misura meno drammatica) quello che è detto sotto ³chemioterapia² in
più spesso delle ustioni ed effetti tardivi di ustioni (bruciore, prurito, )
Queste
si occupano:
- della cura dei pazienti spesso
gravemente lesi sistematicamente e organicamente
- delle cure palliative dagli effetti
collaterali
- della prevenzione (specialmente per
quanto riguarda i tumori ormone-dipendenti)
- della diagnostica e del controllo
accurato.
Visto
che le cliniche sono poco dotate di esperti e strumenti per cure complementari,
i medici di condotta spesso ³tagliati fuori² dagli specialisti oncologi e le
casse non disposte a spendere soldi in merito, questo settore è diventato
vergognoso (salvo rare eccezioni).
4.2 Terapie
naturopatiche e complementari
Esse
non possono e non vogliono concorrere con quelle cliniche. Vedono il loro
contributo piuttosto in modo complementare, cercando di:
- preparare ed accompagnare il cliente per
e durante le terapie cliniche
- effettuare una terapia complementare
³postclinica²
- prevenire alle recidive.
L¹idea
sarebbe quella di fornire all¹organismo gli strumenti per auto difendersi e di
preparare un terreno sfavorevole al tumore, piuttosto che voler ³sradicare le
cellule tumorali².
4.2.1 Naturopatiche
coadiuvanti
4.2.1 Naturopatiche
coadiuvanti
- Basate sul rinforzo del sistema
immunitario con diverse sostanze da Se, Zn, estratto della ghiandola del timo,
echinacea, phytolacca.
- Basate su antiradicali come la
Vitamina C, compl. Vit. B, Vit. E e tante altre
- diverse proposte dietetiche,
ambientali e comportamentali (es. antistress)
- ³oncopsicoterapie² come il libro
dei Simonton e programmi antistress
- diverse tecniche di terapie
corporee (riflessologia, Feldenkrais, Alexander, osteopatia craniosacrale e
altri)
- palliative per rendere più
sopportabili gli effetti collaterali di terapie cliniche (es.fitoterapia,
aromaterapia, ).
- Proposte di diverse medicine di
altre culture (tibetana, indiana, cinese )
- cliniche e medici alternativi di
diverso tipo con metodi come p.es. ipertermia
- scoperte e credenze di singoli
naturopati difficilmente valutabili e riproducibili.
Farmacologia
originale in base al vischio, oncopsicoterapia e terapie espressionistiche
secondo R. Steiner applicate da medici antroposofici specializzati ev. in
clinica specializzata (Ita Wegmann-Klinik, Arlesheim).
5.0 Modelli
terapeutici complementari
5.1 Modelli naturopatici
Diversi
modelli e ³approcci² si intercettano. Ogni ³scuola² mette il peso sulla sua
parte prediletta. Non è né distinto né ben chiarito in diversi meccanismi, se è
l¹alterazione fisiologica a causare il tessuto tumorale o viceversa.
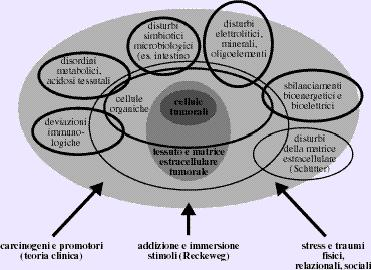
Liquidi
e strutture extracellulari coinvolti nei processi tessutali. Substrato
principale della difesa immunitaria.
Sistema
della matrice extracellulare (regolazione umorale).
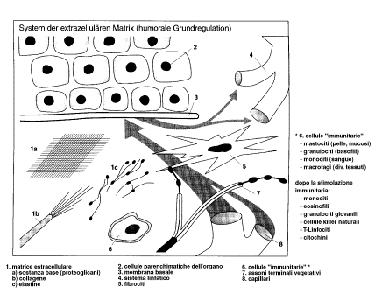
Meccanismi
di difesa contro cellule tumorali. Difesa immunocellulare:
funzioni
della risposta immunitaria.
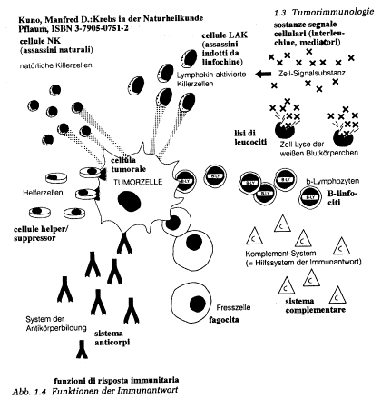
Il
modello biochimico focalizza i processi chimici/fisici che promuovono mutazioni
cancerogene di cloni cellulari.
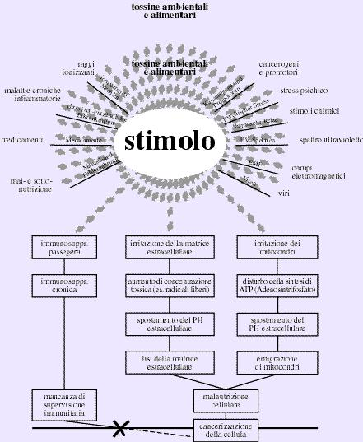
6.0 Terapie
naturopatiche di tumori
6.1 Sinottica
di terapie complementari
6.4 Peptidi
di milza e fegato, organosieri
6.6 Terapia
sistemica enzimatica
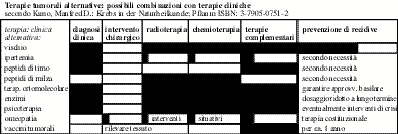
6.1 Sinottica di terapie complementari
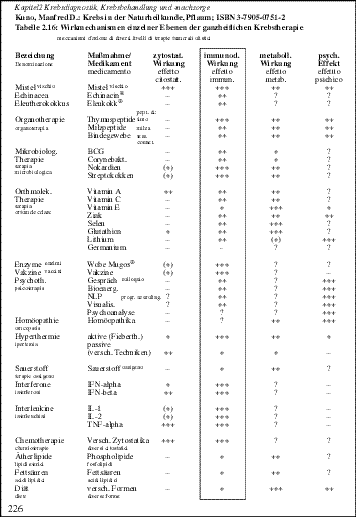
R.
Steiner ha proposto, nel 1920, preparati di vischio per la cura di tumori. La
sua collega, medico Ita Wegmann, ha realizzato il progetto nella sua clinica di
Arlesheim (Basilea Campagna).
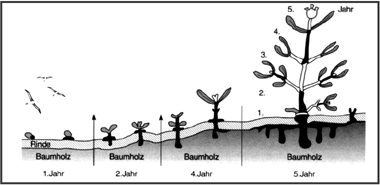
Baumholz:
legno dell¹albero oste
Rinde:
corteccia
Jahr:
anno (1060)
Il più noto della WELEDA, ISCADOR per applicazione s.c.
Diversi tipi secondo l¹albero ³oste².
M:
Mela; A: Abete; P: Pino
In
parte in diluzione omeopatica fino D7 (1:10 milioni, potenziato 7 volte)
L¹applicazione
richiede l¹accompagnamento di un medico o di un naturopata istruito.
La
seguente tabella mostra alcune sostanze contenute in estratti di vischio e il
loro effetto su cellule tumorali e immunitarie:
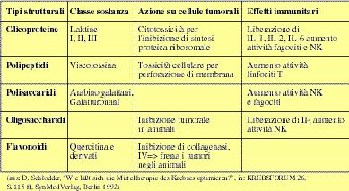
6.3 Peptidi di timo
I
peptidi di timo a partire dal 1922 (Merck, Hoffmann-La Roche) sono usati per
aumentare la resistenza contro le infezioni. Il loro uso è quasi sparito dopo
la seconda guerra mondiale a causa dell¹introduzione di antibiotici.
In
naturopatia sono ancora usati per gli ³squilibri² del sistema immunitario
(allergie, reumatologia, autoimmunitarie e terapie complementari tumorali)
La
seguente tabella presenta alcune sostanze contenute in preparati di timo (p.es.
THYM-UVOCAL) e il loro effetto sul sistema immunitario.
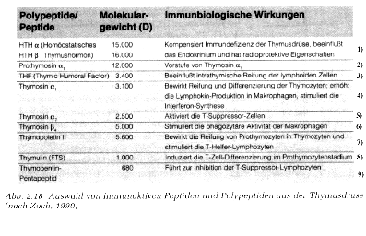
1)
Compensa una deficienza della ghiandola TIMO, effetti endocrini,
radioprotettivo
2)
prestadio di timosina alfa
3)
effetto su maturazione intratimica di cellule linfoidi
4)
effetto su: maturazione e differenz.
timociti, produz. linfochini, interferoni
5)
attivazione cellule T-soppressori
6)
stimola fagocitosi di macrofagi
7)
stimola maturazione timociti, produzione cellule T-helper
8)
induce differenziazione di T-linfociti
9)
inibizione di cellule T-sopressori
Esistono
preparati ³freschi² per iniezioni i-m., s.c. e i.v. e delle pastiglie.
6.4 Peptidi
di milza e fegato, organosieri
I
peptidi di milza/fegato (p.es. FACTOR AF2) sono usati da naturopati
prevalentemente durante le radio-/chemioterapie, perché aumentano la
sopportabilità di queste terapie e diminuiscono il rischio di recidive.
Le
proprietà generali sono:
- immunostimolante specifico e non
specifico monociti/macrofagi
- protezione radiologica e del parenchima
epatico
- inibitorio cellule maligne
- nessuna tossicità.
Un
preparato spesso usato: NEY-Tumorin, iniezione i.m. e i.v.
La
terapia ortomolecolare ha tre aspetti diversi:
- garantire un rifornimento adeguato di
biomolecole in caso di carenza latente e/o passeggera causata da malnutrizione,
stress, carico ambientale, riconvalescenza
- sostituire Vitamine (A, C, E, K, alcune
del gruppo B) e acidi lipidici essenziali distrutti da terapie aggressive e
sostenere il catabolismo di tossine provenienti dal tumore con aminoacidi
(p.es. Methionin, BURGERSTEIN), Selenio, Gluthation
- effetti diretti su certe forme
tumorali (p.es. A, B3, Gluthation) o proprietà immunomodulatorie di sostanze
come Vit. B1, B2, B6, C, Biotina, acido alfa-liponico, Selenio e Zinco.
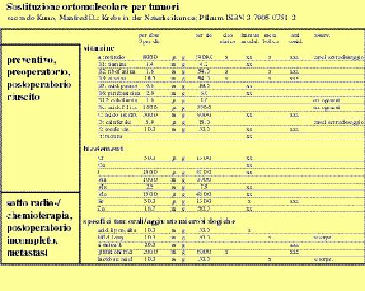
6.6 Terapia sistemica enzimatica
John
Beard 1911 ha proposto l¹uso di enzimi animali contro i tumori. Problematica
nella miscela di enzimi animali (pancreas) e di piante (ananas, papaya) con
sostanze vasoprotettive (rutina).
Impiego
recente:
- reumatologia, autoimmunitarie: MULSAL,
WOBENZYM, BROMELAIN
- infiammazioni croniche: PHLOGENZYM,
BROMELAIN
- tumorali: WOBE MUGOS, WOBENZYM, MULSAL.
Gli
enzimi proteolitici usati nella terapia di tumori hanno i seguenti effetti:
- sopprimono la formazione di molecole di
adesione (meccanismo di metastasi)
- sopprimono la capacità delle cellule
tumorali di ³mascherarsi² con fibrine (WRBA) o acido ialuronico
- stimolano il sistema immunitario umorale
e cellulare (attività fagocitica, produzione IL1, livello immunocomplessi
soppressivi)
- anti-edemigeni
- inibitore di aggregazione trombociti.
Cave! 3 giorni prima di un¹operazione interrompere.
Le
cellule tumorali sono un po¹ più sensibili a temperature alte che le cellule
normali; si usa per distruggere le cellule cancerogene.
Ipertermia
attiva: iniezione di sostanze che generano febbre. Difficile da dosare e da
controllare, perché reazioni individuali.
Ipertermia
passiva: riscaldamento del corpo a 41oC in un apparecchio e poi
surriscaldamento della zona tumorale a 42o43oC.
Pare
che oltre all¹effetto diretto sulle cellule tumorali ci siano anche effetti
immunologici, molecolari e biofisici propensi alla terapia antitumorale.
Nella
struttura ³psicospirituale² di pazienti tumorali si incontra spesso una
struttura di valori dominata dalla triade ³sacrificio-armonia-colpa²:
- conosco tante persone con questa
struttura che non hanno tumori
- conosco cani con tumori che non soffrono
di questa ³ideologia².
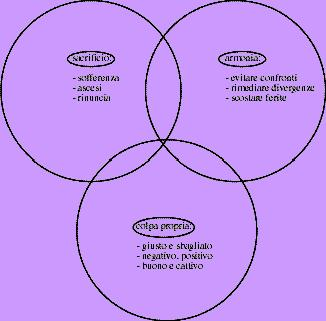
Nel
lavoro psiconcologico può servire come modello quello di scoprire ³valori
propri inconsci² patogeni. Ci servono però anche lavori comportamentali
(risorse di autostima e autoregolazione) oltre a ³strategie di combattimento
mentale².
6.8.1 Accompagnamento
psico-socio-spirituale
6.8.1 Accompagnamento
psico-socio-spirituale
Durante
una terapia tumorale ritengo importante un accompagnamento
³psico-socio-spirituale² professionale, perché sono notevolmente scombussolati
l¹identità, le relazioni e i ruoli sociali del paziente oltre allo stress
organico che deve subire al medesimo tempo.
Come introduzione al tema di ³psicooncologia² servono
le opere di LESHAN, SIMONTON,
GROSSARTH-MATICEK
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |