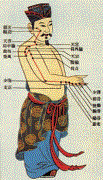|
|
Medicina popolare
per autodidatti
settembre 22, 2005 |
|
Indice della pagina 1.1 Medicina tradizionale cinese TCM
(Traditional Cinese Medicine) 1.2 Terapie derivate da tradizioni cinesi 2.1 Nessi con altre culture mediche 2.2 Modelli di medicina cinese 2.3
Interpretazioni occidentali 2.5 Tecnica di trattamento dei punti 6.0 Rischi e controindicazioni |
MN 4.6 Elementi di medicina cinese © Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: Temi di medicina popolare MmP
1 |
Indice
MN4.6: Elementi di medicina cinese
1.0 Metodi
1.1 Medicina tradizionale cinese TCM (Traditional Cinese Medicine)
1.2 Terapie derivate da tradizioni cinesi
1.2.1
Usando il
concetto di agopunti e meridiani
1.2.1.1
Agopuntura
1.2.1.2
Agopuntura
dell¹occhio (J. Boel)
1.2.1.3
Auriculoterapia
1.2.1.4
Agopuntura
ad iniezione
1.2.1.5
Digitopressione
1.2.1.6
Jin Shin Do
1.2.1.7
Moxibustione
1.2.1.8
Elettroagopuntura
(Voll)
1.2.1.9
Elettrostimolazione
1.2.1.10
Agopuntura a laser
1.2.1.11
Cromopuntura
1.2.2
Farmacologia
cinese
1.2.3 Lavoro
corporeo cinese
1.2.3.1
Massaggio
cinese
1.2.3.2
DO-IN
1.2.3.3
Digitopressione,
Jin Shin Do, Zero Balancing
1.2.3.4
Shiatsu
1.2.3.5
Kinestesia,
kinesiologia applicata, touch for health
1.2.3.6
Manipolazione
di ³trigger points²
1.2.4
Esercizi e
atteggiamenti, igiene cinese
1.2.4.1
Qi Gong
1.2.4.2
Tai Chi
1.2.4.3
Do-In
1.2.5
Dietetica
cinese
1.2.6
Architettura
cinese (FENG SHUI)
1.2.7
Filosofie,
previsioni cinesi
1.2.7.1
I King
1.2.7.2
Tao
2.0 Concetto e storia
2.1 Nessi con altre culture mediche
2.2 Modelli di medicina cinese
2.2.1
YIN, YANG,
QI
2.2.2
Fonti di
energia QI
2.2.3
Meridiani
2.2.4
La circolazione
energetica nei meridiani
2.2.5
Le cinque
fasi di mutamento
2.2.6
I cinque
induttori
2.2.7
Il modello
dei sei stadi
2.2.8
Il modello
dei quattro stadi
2.2.9
Meridiani e
agopunti
2.3 Interpretazioni occidentali
2.4 Diagnostica
2.4.1
Diagnosi
del polso
2.4.2
Diagnosi
della lingua
2.4.3
Palpazione
di punti d¹allarme e di punti di assentimento
2.5 Tecnica di trattamento dei punti
2.5.1
Modo di
stimolazione
2.5.2
Concetti di
stimolazione
2.5.2.1
Stimolazione
³locus dolendi²
2.5.2.2
Punti
maestri
2.5.2.3
Punti
sintomatici
2.5.2.4
Punti di
riassestamento energetico
3.0 Funzionamento
4.0 Applicazione
5.0 Studi
6.0 Rischi e controindicazioni
7.0 Durata della cura
8.0 Indirizzi
9.0 Annesso:
9.1 Elementi di ³anatomia e fisiologia cinese²
9.1.1
Meridiano
del cuore C
9.1.2
Meridiano
dell¹intestino tenue IT
9.1.3
Meridiano
della vescica urinaria VU
9.1.4
Meridiano
del rene R
9.1.5
Meridiano
del pericardio P
9.1.6
Meridiano
del triplice riscaldatore T
9.1.7 Meridiano
della cistifellea VF
9.1.8
Meridiano
del fegato H
9.1.9
Meridiano
del polmone P
9.1.10
Meridiano
dell¹intestino crasso IC
9.1.11
Meridiano dello stomaco
S
9.1.12
Meridiano di
milza/pancreas SP
9.1.13
Vaso di concezione
JENN-MO JC
9.1.14
Vaso di guida TOU-MO JM
9.2 Indicazioni per l¹agopuntura
Tabella separata
Metodo
diagnostico e di trattamento basato sulla tradizione di medicina cinese con
concetti propri per il ³funzionamento² del corpo umano.
1.1
Medicina tradizionale cinese TCM (Traditional Cinese Medicine)
1.2
Terapie derivate
da tradizioni cinesi
1.1 Medicina tradizionale cinese TCM (Traditional Cinese Medicine)
La medicina
tradizionale cinese è, da una parte, di un impressionante pragmatismo. Per noi
è difficile applicarla (salvo forse l¹agopuntura) perchè ci manca tutto un
contesto socioculturale. Si tratta di un sistema diagnostico e terapeutico
proveniente della tradizione cinese con elementi di taoismo, confucianesimo e
buddismo, che usa fra altri metodi come agopuntura, auriculoterapia,
digitopressione, moxibustione, una larga gamma di medicamenti propri, non
contando le diverse tecniche di lavoro corporeo ed esercizi fisici e di
concentrazione, una dietetica e regole igieniche molto sviluppate.
L¹agopuntura
in Cina era piuttosto rara, perché i medici erano pagati per tener sano il
cliente, non per curarlo. Di conseguenza erano molto più divulgati i metodi
preventivi che quelli ³di riparazione². Ma anche nel contesto della cura era ed
è tutt¹ora molto più divulgata in Cina la cura con rimedi a base di piante,
minerali e animali che non l¹uso di aghi, moxibustione o digitopressione.
Basi
dell¹ideologia medica cinese sono YANG (dinamica a costo della stabilità) e
YING (armonia a costo dell¹evoluzione) il cui contrasto crea Qi (energia
vitale).
Un eccesso,
una concentrazione, un blocco, un ristagno o un accumulo² di QI in un organo o
una funzione rende YANG questo organo, mentre un ³vuoto, deflusso, dispersione,
mancanza ² di QI lo rende YIN.
La teoria
dei mutamenti come secondo pilastro ideologico si basa sulle regole della
natura (TAO, andamento) non su criteri trascendentali. Conseguentemente, in
questo concetto la malattia non è definita come prodotto finale di una catena
di causa ed effetto (etiologia, patogenesi, diagnosi, terapia) ma un processo
continuo influenzabile fra l¹altro stimolando l¹energia vitale QI.
La
³diagnostica² cinese (fra l¹altro polso e lingua) porta a ³terapie² individuali
altamente differenziate, che durante il loro corso, vengono continuamente
mutate e adattate.
1.2 Terapie
derivate da tradizioni cinesi
Ci sono innumerevoli
derivati di metodi cinesi, in parte abbastanza ³autentici² anche se nella
medicina cinese questi metodi non hanno il medesimo significato che in Europa.
Altri derivati si servono dell¹²anatomia cinese² combinata con strumenti
europei, altri ancora di interpretazioni anche azzardate di terminologia cinese
in una traduzione discutibile.
Sono
trattati i seguenti temi:
1.2.1 Tecniche usate in
occidente
1.2.4 Esercizi
e atteggiamenti, igiene cinese
1.2.6 Architettura
cinese (FENG SHUI)
1.2.7 Filosofie,
previsioni cinesi
1.2. 1 Tecniche usate in occidente
1.2.1.2 Agopuntura
dell¹occhio (J. Boel)
1.2.1.4 Agopuntura
ad iniezione
1.2.1.8 Elettroagopuntura
(Voll)
1.2.1.1 Agopuntura
Metodo
della medicina tradizionale cinese: aghi inseriti in punti specifici lungo dei
³meridiani² secondo un¹anatomia particolare, contro i più diversi disturbi. Le
forme occidentali possono differire notevolmente dalle forme tradizionali
cinesi. Anzitutto partono spesso da una interpretazione occidentale della
patologia.
1.2.1.2 Agopuntura
dell¹occhio (J. Boel)
Applicazione
di aghi sull¹occhio, partendo dalla convinzione che diversi organi dispongono
di punti di riflesso specifici sull¹occhio.
Applicazione
di aghi, pressione, bastoncini sull¹orecchio, partendo dalla convinzione che
diversi organi dispongono di punti di riflesso sull¹orecchio.
1.2.1.4 Agopuntura
ad iniezione
Iniezione
di sostanze nei punti di agopuntura (da anestetici locali fino all¹urina).
Metodo
della medicina tradizionale cinese che usa punti dell¹ => agopuntura:
massaggio a pressione per calmare, stimolare o diminuire dolori. Possibile come
autoterapia.
Metodo americano specializzato nella digitopressione
(specialmente i punti del meridiano della ³vescica urinaria² e del vaso guida
TOU MO).
Applicazione di calore (invece dell¹ago) sui punti
dell¹agopuntura tramite ³sigari² o coni prevalentemente di Hb. Achillea.
1.2.1.8 Elettroagopuntura
(Voll)
Stimolazione di agopunti con correnti elettriche a basso
voltaggio.
Stimolazione di agopunti con impulsi elettrici.
Applicazione di luce laser di bassa energia sui punti di
agopuntura.
Applicazione
di luce di diverso colore sugli agopunti.
In Cina
esiste una ricchissima fitoterapia popolare (combinata con minerali e sostanze
animali) che per difficoltà di cultura e mancanza di sostanze base è divulgata
in Europa solo sporadicamente e sotto forma di ipotetici rimedi di potenza e di
ringiovanimento.
Il lavoro
sul corpo come massaggi e digitopressione era molto divulgato in Cina e ha
trovato seguaci di ogni genere nei nostri paraggi.
1.2.3.3 Digitopressione, Jin Shin Do, Zero Balancing
1.2.3.5 Kinestesia, kinesiologia applicata, touch for health
1.2.3.6 Manipolazione
di ³trigger points²
1.2.3.1 Massaggio cinese:
Basato
strettamente sull¹intero sistema di medicina tradizionale cinese, usa diversi
tocchi e strisci per scopi terapeutici precisi. In Europa è poco divulgato
vista la difficoltà culturale ad assimilare i concetti medici cinesi e la
richiesta di virtuosità tecnica del tatto.
Tecnica di
digitopressione (automassaggio) di agopunti. Revitalizzato nel corso di un
programma di automedicazione popolare nell¹era di MAO-TSETUNG e divulgato anche
in europa. Il DO-IN completo usa anche altre tecniche oltre alla digitopressione.
1.2.3.3 Digitopressione,
Jin Shin Do, Zero Balancing :
Deriva dal
Do-In (automassaggio) della medicina tradizionale cinese, combinata con
elementi di shiatsu e osteopatici usati come terapia passiva.
Normalmente
fa uso solo di pochi punti vista la difficoltà di impararli tutti.
Metodo di
massaggio giapponese divulgato in Europa. Prevalentemente digitopressione
combinata con elementi di judo, do-in e massaggio antico giapponese, arricchita
di elementi di osteopatia e chiropratica.
1.2.3.5 Kinestesia,
kinesiologia applicata, touch for health:
Negli anni
¹60 Goodheart, un chiropratico, scoprì legami riflessologici tra vertebre,
nervi, muscoli da una parte e sistemi neurolinfatici, neurovascolari, nervi
periferici, liquido cerebrospinale e ³meridiani² dell¹agopuntura cinese
dall¹altra. In base a ciò furono sviluppate tecniche diagnostiche e
terapeutiche usando e reintegrando diverse altre tecniche come la ³polarity²
(nel ³Touch for Health²), la digitopressione cinese e giapponese, l¹osteopatia,
il CranioSacrale e la chiropratica.
1.2.3.6 Manipolazione
di ³trigger points² (³trigger² -> grilletto):
Usa dei
nessi empiricamente osservati tra muscoli dolorosi e punti che rinforzano il
dolore (trigger point). Si stimola la zona di dolore, anestetizzando/ calmando
il trigger point allo scopo di far sparire il dolore. Tecnica molto simile al
trattamento ³locus dolendi² dell¹agopuntura e della digitopressione.
1.2.4 Esercizi
e atteggiamenti, igiene cinese
Esercizi di
tradizione cinese. In parte usati per scopi terapeutici.
Esercizi di
tradizione cinese. In parte usati per scopi terapeutici.
Tecnica di
autotrattamento cinese basata su un atteggiamento preciso usando digitopressione,
esercizi, massaggi, respirazioni, percussioni, martellamenti e frizioni allo
scopo di riequilibrare l¹energia del corpo.
In Cina,
fra le classi ricche, la dietetica era ed è molto importante grazie a una lunga
cultura che abbina al cibo un fondamentale posto nell¹apporto, asporto ed
equilibrio dell¹energia vitale. Nei nostri paraggi è poco conosciuta e mal
applicabile a causa delle diverse tradizioni alimentari.
Feng Shui e
altri metodi architettonici esterni e interni: metodo di medicina tradizionale
cinese per minimizzare gli influssi esterni provenienti dalla costruzione
architettonica e dalle ³forze ambientali².
Metodo
cinese di previsione del futuro. Raramente usato per scopi
diagnostici/terapeutici.
³Strada²:
filisofia/ideologia/modo di vivere cinese. Certe discipline sono usate per
scopi terapeutici.
La medicina
tradizionale cinese è originalmente frutto di concetti taoisti e di
confucianesimo, cresciuta su una ricca tradizione popolare. Più tardi fu anche
influenzata dal buddismo, specialmente per mediazione dei monaci tibetani. Fu
codificata la prima volta intorno al 200 a.C. e divenne soggetto di una
professione specializzata.
2.1 Nessi con altre culture mediche
2.2 Modelli di medicina cinese
2.3 Interpretazioni occidentali
2.5 Tecnica di trattamento dei punti
2.1 Nessi
con altre culture mediche
Sono tanti
i nessi storici con le culture mediche ayurvediche e tibetane, le quali sono
state introdotte nella medicina cinese taoista durante i periodi della
divulgazione di idee induiste e buddiste nel regno cinese.
YIN &
YANG, QI, meridiani, mutamenti, elementi, induttori,
2.2.4 La
circolazione energetica nei meridiani
2.2.5 Le
cinque fasi di mutamento
2.2.7 Il
modello dei sei stadi
2.2.8 Il
modello dei quattro stadi
. YIN
significava originariamente il pendio verso settentrione di una valle (ombroso,
umido, fresco)
. YANG
significava originariamente il pendio verso meridione di una valle (luminoso,
secco, caldo)
. QI
significava la forza del vapore che alzava il coperchio della pentola del riso
bollente.
In senso
figurato i vecchi cinesi si immaginavano un complemento equilibrato di YIN e
YANG abile a lasciar scorrere liberamente il QI (spesso tradotto come
³energia², ³energia vitale², ma anche come ³soffio²).
Secondo
Bertrand Russel, YANG è dinamica a scapito della stabilità, YIN è armonia a
scapito del progresso.
In questo
senso vennero e vengono abbinate a YIN e YANG tante proprietà polari come:
YANG YIN
cielo terra
giorno notte
luminoso scuro
primavera/estate autunno/inverno
uomo donna
in alto in
basso
verso l¹esterno verso
l¹interno
superficialità profondità
iperfunzioni ipofunzioni
energetico materiale
funzionale strutturale
dinamico statico
In senso
³patologico² lo YIN corrisponde all¹incirca a sottofunzioni (ipo- colinergico,
vagotonico ), lo YANG a sovrafunzioni (iper- adrenergico, simpatotonico ).
Secondo i
concetti taoisti ci sono diverse fonti energetiche:
genetica,
disposizione, costituzione
nutrizione
respirazione
ambiente
culturale e naturale
energie
cosmiche (stelle, pianeti )
energia
intersessuale (erotica)
L¹energia
consumata deve essere sostituita non importa da quale fonte. Se il livello
energetico scende sotto un determinato livello, la persona muore.
L¹energia
circola nell¹organismo lungo dei percorsi ben definiti e in ritmi stabiliti.
I percorsi
di circolazione energetica in occidente sono chiamati ³meridiani² (KING).
Esistono 12 meridiani disposti a coppia spettrale a destra e sinistra del corpo
(24 percorsi).
I meridiani
portano i nomi di organi o gruppi funzionali. Secondo la classificazione di
questi organi o funzioni, anche i meridiani sono classificati come YIN o YANG,
il che non significa che in essi circoli solo energia QI del tipo YIN o YANG.
denominazione qualità
regione
percorso
attività
mass effetti primordiali
ora
locale
I
cuore C
YIN interno,
volare torace
laterale => dita 1214
psichici
II
intestino tenue IT
YANG esterno,
dorsale dita
=> testa 1416
spasmolitici,
mucose
III
vescica (urinaria) VU
YANG esterno, dorsale testa
=> dita dei piedi 1618
equilibrio
elettrolitico
IV
rene R
YIN interno,
volare dita
dei piedi => torace lat. 1820
dissimilativi,
circolat.
V
pericardio PC
YIN interno,
volare torace
laterale => dita 2022
circolat./sessual.
VI
triplice riscal. T
YANG esterno,
dorsale dita
=> testa 2224
resp./digest./urogen.
VII
cistifellea VF
YANG esterno, dorsale testa
=> dita dei piedi 2402
spasmolitici/psichici
VIII
fegato (hepar) H
YIN interno,
volare dita
dei piedi => torace lat. 0204
assimilativi
IX
polmone P
YIN interno,
volare torace
laterale => dita 0406
respirazione,
ritenzioni
X
intestino crasso IC
YANG esterno,
dorsale dita
=> testa 0608
mucose,
escrezione
XI
stomaco S
YANG esterno,
dorsale testa
=> dita dei piedi 0810
digest./circol./psiche
XII
milza/pancreas SP
YIN interno,
volare dita
dei piedi => torace lat. 1012
tessuto
connettivo
Oltre
ai dodici paia di meridiani ci sono due ³vasi²:
XIII
vaso concezione JM-mediana
ventrale ano
=> mento -somatica
regionale
XIV vaso
governatore TM
-mediana dorsale ano
=> occipite => labbro sup. - caudale somatica; craniale psichica
Le
denominazioni, enumerazioni e abbreviazioni variano secondo la lingua e
l¹autore che li traspone dal Cinese. Per questo testo ho usato delle sigle che
sono frequenti nelle lingue latine.
Chi
intendesse studiare ³anatomia cinese² deve servirsi di tavole e tabelle che
indicano con cautela il percorso dei meridiani.
2.2.4 La
circolazione energetica nei meridiani
La
circolazione dell¹energia si immagina in tre ³cicli²a quattro percorsi seguendo
uno schema:
percorso 1o
ciclo 2
o ciclo 3
o ciclo
torace laterale => dita I
cuore C, V
pericardio PC IX
polmone P
dita => testa II
intestino tenue IT VI
triplice riscaldatore T X
intestino crasso IC
testa => dita dei piedi I II
vescica VU VII
cistifellea VF, XI
stomaco S
dita dei piedi=>torace lat IV
rene R VIII
fegato H, XII
milza/pancreas SP
L¹energia
circola ritmicamente in periodi di 24 ore così che il flusso in un meridiano a
una determinata ora è al massimo e a un¹altra al minimo.
2.2.5 Le cinque
fasi di mutamento e gli ³elementi²
Il concetto
taoista cinese si basa fra l¹altro sulle ³cinque fasi di mutamento², intese
come continuo processo di trasmutazione di tutte le cose. Le cinque fasi di
mutamento vennero ³battezzate² per scopi mnemonici con i nomi di legno, fuoco,
terra, metallo e acqua.
Questo
concetto viene spesso paragonato con i quattro elementi della tradizione
europea (acqua, fuoco, terra e aria), secondo me si tratta di un paragone che
ignora completamente il contrasto tra il modello strutturale/statico greco e il
concetto funzionale/dinamico taoista. Chi è pratico del concetto degli elementi
tradizionali europei noti bene nella seguente tabella i contrasti e le analogie
tra i due modelli che hanno in comune quasi solo i nomi di tre criteri (fuoco,
terra, acqua) senza ulteriori nessi.
Infatti
questo concetto (taoista) non serve per caratterizzare una persona, ma per
stabilire il suo stato attuale dinamico/energetico, per scoprire squilibri,
blocchi, impedimenti momentanei e per influenzarli in modo che possa scorrere
liberamente il
QI tra un
YIN e uno YANG equilibrati.
analogia
legno
fuoco
terra
metallo
a cqua
meridiano
YIN fegato H cuore
C milza/pancr.
SP polmone
P rene
R
YANG vescica bil. VF intest.tenue IT stomaco S intest.crasso IC vescica urin. VU
YIN
pericardo
P
YANG
tripl.risc. T
temperatura
tiepido
caldo
gradevole
fresco
gelido
gusto
aspro,
acido amaro
dolce
piccante
salato
colore
verde,
blu rosso
giallo
bianco
nero
voce
urlare
ridere
cantare
piangere
sospirare
comportamento
sforzato
agitato
orale
tossire
tremare
odore
rancido,
acido carbonizzato
aromatico
rancio,
muffa marcio
clima
vento
caldo
umidità
siccità freddo
sviluppo nascita
giovinezza
adulto
senescenza
morte,
saggezza
stagione
primavera
estate
estate
indiana autunno
inverno
direzione
occidente
(EU) meridione
centro oriente
(EU) settentrione
emozione
rabbia,
ira voglia,
gioia pensieroso
melanconia
paura
psiche
autoespressivo
sovravisione
riflessivo
vegetativo
dominante
tessuto
motorio
vasi
carne,
connettivo pelle
ossa
sensi
visivo lingua
gusto
olfatto
udito
pianeti
giove marte
saturno
venere
mercurio
rappresentazione
unghie viso
labbra pelo
capelli
virtù
bontà
morale,
costumi fiducia
giustizia
saggezza
polso
C.sin.:chord.
Po.dx.:exundans
C.dx.:longus
Po.dx.:superfic.
Pe.dx./sin.:mersus*
* C:
clusa => centro Po:
pollex => verso il pollice Pe:
pes => verso il gomito dx.
=> destra sin. => sinistra
chord(ialis) =>²cordoso² exundans => ³ondulante² longus => lungo superfic(ialis) => superficiale
Una tecnica
terapeutica della TCM consiste nella valutazione (diagnosi) del paziente circa
il suo stato attuale energetico, relativo alle cinque fasi di mutamenti e in
misura da facilitare il mutamento usando consigli comportamentali e dietetici,
esercizi, rimedi vegetali, minerali e animali, digitopressione e agopuntura su
punti definiti come ³cinque induttori² o punti antichi.
Secondo lo
stato attuale energetico di un paziente, certi medici cinesi usano punti ³dei
cinque induttori² che non corrispondono necessariamente alla teoria del flusso
energetico nei meridiani, per facilitare il mutamento servendosi delle regole
³madre- figlio², del ³ciclo di sheng² o della ³grande puntura²
2.2.7 Il
modello dei sei stadi
Modello di
equilibrio energetico usato per malattie infettive febbrili
2.2.8 il modello dei quattro stadi
Modello
usato sin dal 500 per cosidette malattie ³indotte da calore²
La maggior
parte degli agopunti si trovano lungo i meridiani e i vasi. Servono
terapeuticamente per equilibrare dei flussi energetici disturbati.
pass.
ass allarme
pti conc. disp. fonte Luo Shu Mu mass. min.
I cuore
C
9
C9
C7
C7
C5
VU15
JM14
1113
2301
II intestino
tenue IT
19
IT3 IT8 IT4 IT7 VU27 JM4 1315
0103
III vescica (urinaria) VU
67
VU67 VU65 VU64 VU58
VU28 M3 1517
0305
IV rene
R
27
R7 R1 R3
R4
VU23
VF25
1719
0507
V pericardo
PC
9
PC9
PC7 PC7 PC6 VU14 JM17 1921 0709
VI triplice
riscal. T
23
T3 T10 T4 T5
VU22
JM5
2123
0911
VII cistifellea
VF 44
VF43 VF38 VF40 VF37
VU19 VF23 2301
1113
VIII fegato
(hepar) H
14
H8 H2 H3
H5
VU18
H14
0103
1315
IX polmone
P
11 P9 P5 P9
P7
VU13
P1
0305
1517
X intestino
crasso IC
20
IC11 IC2 IC4 IC6 VU25 S25 0507
1719
XI stomaco
S 45
S41 S45 S42 S40 VU21 JM12 0709 1921
XII milza/pancreas
SP 21
SP2 SP5 SP3 SP4 VU20 H13 0911
2123
XIII vaso
di concez. JM
28
XIV vaso
di guida TM
24
Totale
361
Altri
autori parlano di 600700 punti che hanno tutti un preciso nome cinese (e non
un¹enumerazione) (gli altri punti non si trovano sui meridiani).
Punti
principali
di
concentrazione (tonificante): concentra l¹energia nel meridiano scarso di
energia (oro)
di
dispersione (sedativo): disperde l¹energia nel meridiano ³bloccato² (argento,
moxa)
Punti
speciali
di fonte:
amplifica l¹effetto dei punti di concentrazione e di dispersione
di
passaggio (luo): transizione di energia tra meridiani ³vuoti² e ³pieni²
di
allarme (mu): ipersensibile in caso di disturbo dell¹organo o della funzione
di
assentimento (shu): regolano l¹energia scarsa o ³bloccata² tramite
³tonificazione² o ³dispersione²
Punti
ausiliari
di
riunione: equilibra il flusso energetico di diversi meridiani in una volta sola
cardinali: deviano flussi energetici di meridiani
all¹infuori dei meridiani e personali: a scopo sintomatico o terapeutico
2.3 Interpretazioni
occidentali
La
naturopatia europea e nordamericana, di tutto il ricco patrimonio Cinese era
affascinata prevalentemente dalle terapie derivate dai meridiani e dagli
agopunti. È veramente seducente l¹idea che la stimolazione di determinati punti
sulla superficie dell¹organismo possa curare delle malattie.
Malauguratamente
è un¹idea europea che al riducente e semplicistico aggiunge una
generalizzazione che è estranea a concetti cinesi. Se fosse fattibile così, i
Cinesi come popolo pragmatico l¹avrebbero scoperto da centinaia di anni e
abbandonato il resto (maggior parte) della loro ricchissima cultura
medica/sanitaria. Non si sarebbero neanche sentiti costretti ad introdurre
negli ultimi cinquant¹anni nella loro società dei metodi diagnostici e
terapeutici razionali e cari agli europei (concetti a loro altrettanto estranei
come a noi i loro tradizionali).
Ciononostante
era ed è un arricchimento del repertorio medico naturalista, che in determinati
casi mostra anche notevoli successi (terapie palliative del dolore, complemento
a terapie di malattie croniche).
Sin
dall¹inizio dell¹applicazione occidentale ai nostri medici si poneva il problema
di trovare dei nessi tra una ³patologia occidentale² (p.es. mal di testa,
cinese ³vento del fegato²) e dei ³punti terapeutici orientali² (p.es. VC3,
TM16, VU31, JM6, VU2, IC20, ). Innumerevoli medici occidentali hanno lavorato
e lavorano per trovare delle indicazioni riproducibili. Alla fine di questo
testo ho elencato un esempio.
La
diagnostica cinese valuta lo stato energetico attuale del paziente e coinvolge
anamnesi:
- malattie
subite
- attuale
con sintomi in relazione dell¹ora (orario dei meridiani)
- modalità
simile all¹omeopatia
abitudini
nutritive
diagnosi
del polso
diagnosi
della lingua
palpazione di sensibilità e consistenza specialmente dei punti di allarme e
punti di assentimento (ma anche di altri).
2.4.3 Palpazione di punti d¹allarme e di punti di assentimento
2.4.1 diagnosi del polso
Il polso
viene palpato in 3 punti su ambedue le parti, sopra il polso e con due
pressioni diverse. L¹impressione delle qualità di queste 12 sensazioni fornisce
(a chi è in grado di percepirla, distinguerla e formularla) un¹informazione del
livello energetico dei 12 meridiani.
L¹ispezione
della lingua fornisce all¹esperto delle informazioni sia sullo stato energetico
di diversi meridiani, sul substrato corporeo e la costituzione e sull¹economia
dei liquidi corporei
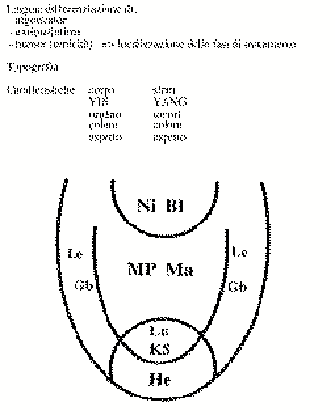
2.4.3 Palpazione
di punti d¹allarme e di punti di assentimento
Poiché la
diagnosi del polso e della lingua sono difficili da imparare, molti medici
occidentali si servono prevalentemente di questa tecnica per decifrare il
livello energetico dei diversi meridiani o per trovare in modo sintomatico
delle funzioni impedite.
2.5 Tecnica
di trattamento dei punti
Modi e
concetti di stimolazione.
2.5.2 Concetti
di stimolazione
Classicamente
si usava e si usa:
- il
massaggio del punto con l¹unghia a pressione forte in senso orario
(tonificante)
- il
massaggio del punto con il polpastrello a pressione dolce in senso antiorario
(sedativo)
- coppette
applicabili sui punti coinvolti
-
moxibustione (sigari di achillea) prevalentemente per tonificare stati YIN
- aghi di
argento prevalentemente per sedazione di stati YANG
- aghi di
oro prevalentemente per tonificare stati YIN
Oggi si usano
spesso anche:
- aghi
monouso di acciaio
-
stimolatori elettrici (anche per la localizzazione esatta del punto,
p.es.SEARCHNSTIM)
- luce
laser di bassa energia
- luce di
diversi colori (cromopuntura)
- iniezioni
e spray di anestetici locali (p.es.Xylocaina) su punti dolenti
- criospray
(freddo, p.es. etilcloride e i Sintetica, Mendrisio) su punti dolenti
Il discorso
di ³sedazione² e di ³tonificazione² scombussola spesso il principiante:
- ago
(sedativo) e moxibustione (tonificante);
- pressione
unghia senso orario (tonificante) o polpastrello antiorario (sedativo);
- ago in
oro (tonificante) o in argento (sedativo);
- coppette,
aghi di acciaio monouso, anestetici locali, luce, elettricità non definiti come
sedativi o tonificanti.
Nell¹agopuntura
occidentale la maggior parte dei terapisti è oggi del parere che qualsiasi
stimolo equilibri il flusso energetico in modo che in uno stato di ³vuoto² si
³riempie² e in uno stato di eccedenza si fa defluire. Secondo questo concetto,
la scelta di uno strumento piuttosto ³sedativo² o ³tonificante² facilita solo
il processo.
2.5.2 Concetti
di stimolazione
Secondo le
capacità del medico agopuntore, i suoi obiettivi terapeutici e le necessità del
caso, egli userà diversi concetti di stimolazione:
2.5.2.1 Stimolazione
³locus dolendi²
2.5.2.4 Punti di riassestamento energetico
2.5.2.1 Stimolazione
³locus dolendi²
Si stimola
il punto dolente con un ago ad una profondità di 4 20 mm.
Efficace
(spesso per un periodo limitato) in caso di spasmi muscolari e di nevralgie.
Punti non
necessariamente situati su meridiani che hanno una diretta relazione
diagnostica/terapeutica con la disfunzione di un determinato organo (riflesso
cuteoviscerale). Parecchi di loro sono punti di assentimento degli organi
principali secondo l¹anatomia cinese.
Esempio:
Il punto
maestro dello stomaco VU21 corrisponde al ³punto di assentimento SHU²: 2 cun
(dito, pollice) laterale alla mediana tra i processi laterali della 12a
vertebre toracica e la 1 a lombare:
- sensibile
in pressoché tutte le patologie strutturali e funzionali dello stomaco
- la
stimolazione cambia con grande probabilità la sintomatologia.
Con
l¹evoluzione dell¹agopuntura si scoprì una grande quantità di punti che erano
riferiti a specifici disturbi più o meno ristretti o vasti e più o meno
combinati con altri punti. Si tratta in totale di ca. 750 punti noti e
descritti. A chi è pratico e conosce bene il significato dei principali, questi
servono sia come strumento diagnostico che terapeutico, in modo che il medico
cinese esamina la loro sensibilità e trova così velocemente una combinazione da
stimolare che fa sparire almeno il sintomo e spesso riassesta l¹omeostasi
energetica.
Una
proposta, soprattutto di questo tipo, si trova nell¹annesso.
2.5.2.4 Punti di riassestamento
energetico
Il concetto
cinese interpreta la malattia come disturbo nei complicati meccanismi di regolazione delle funzioni
dell¹organismo. Oltre all¹intervento locale sul luogo dolente, sull¹organo
disturbato e sui sintomi, e a monte di tutto questo, interessa quindi come
ultimo obiettivo armonizzare tutti i processi regolativi, trattati come
energetici. È evidente che è importante intuire dove, quando e come intervenire
per dare un colpo di mano alla regolazione dell¹organismo sfasato.
Un
trattamento TCM auspica l¹equilibrio del flusso del QI impedito per togliere il
disagio corporeo alla base. Questo concetto è di difficile approccio per la
cultura medica occidentale.
Le
spiegazioni delle malattie secondo la TCM sono spesso in contrasto con quelle
occidentali.
All¹interno
del concetto taoistico cinese verso il mondo, la vita e la cultura umana è
spiegabile e plausibile il funzionamento della TCM: usando i nostri concetti
occidentali un tale tentativo o distorce il concetto taoista o porta a
deduzioni e analogie tirate per i capelli.
Nella Cina
di oggi la TCM viene applicata prevalentemente per disturbi neurovegetativi e
come complemento in malattie croniche o lesioni gravi di organi.
In
occidente secondo certi seguaci ³funziona² pressoché per tutte le malattie e
disturbi, altri la applicano prevalentemente per disturbi psicosomatici,
malattie croniche e per combattere dolori.
Lo studio
farmacologico di rimedi cinesi, tibetani e giapponesi è solo all¹inizio ed è
difficile per diverse cause. Esistono primi risultati positivi per malattie
dermiche.
6.0 Rischi
e controindicazioni
Rischioso
se usato come unico metodo diagnostico/terapeutico, perchè possono sfuggire
alterazioni organiche come neoplasmi e si può ritardare una cura adatta.
I rimedi (farmaci)
sono problematici per mancante assicurazione della qualità: si scoprono spesso
rimedi ³falsificati² e contaminati con metalli pesanti e altri tossici
ambientali.
Secondo il
caso e la tradizione cinese, da anni fino a ³vita natural durante², perché si
tratta di una continua correzione della dinamica regolativa dell¹organismo.
Schweizerische
Aerztegesellschaft für
Akupunktur
und Chinesische Medizin
Hus am
Sportplatz
Postfach
566
CH-8134
Adliswil
Bischko,
Johannes: Einführung in die Akupunktur Haug 1970
Hausser,
Peter (Hsg.): Energetische Medizin, Peter Lang, Bern 1988
Bettschart,
R et alt.: Bittere Naturmedizin, Kiepenheuer und Witsch 1995
Marcelli,
Stefano: Agopuntura in tasca; IPSA Editore, ISBN 88-7676-119-5
Tibaldi,
Ettore(pres.): L¹agopuntura; Accademia cinese di medicina tradizionale;
Teti
editore Yahiro, Yuji: keiraku shiatsu; edizione red.
9.1 Elementi di ³anatomia e fisiologia cinese²
9.2 Indicazioni per l¹agopuntura
9.1 Elementi
di ³anatomia e fisiologia cinese²
9.1.2 Meridiano
dell¹intestino tenue IT
9.1.3 Meridiano
della vescica urinaria VU
9.1.5 Meridiano
del pericardio P
9.1.6 Meridiano
del triplice riscaldatore T
9.1.7 Meridiano
della cistifellea VF
9.1.10 Meridiano
dell¹intestino crasso IC
9.1.11 Meridiano
dello stomaco S
9.1.12 Meridiano
di milza/pancreas SP
9.1.13 Vaso
di concezione JENN-MO JC
9.1.14 Vaso
di guida TOU-MO JM
Effetti
prevalentemente psichici.
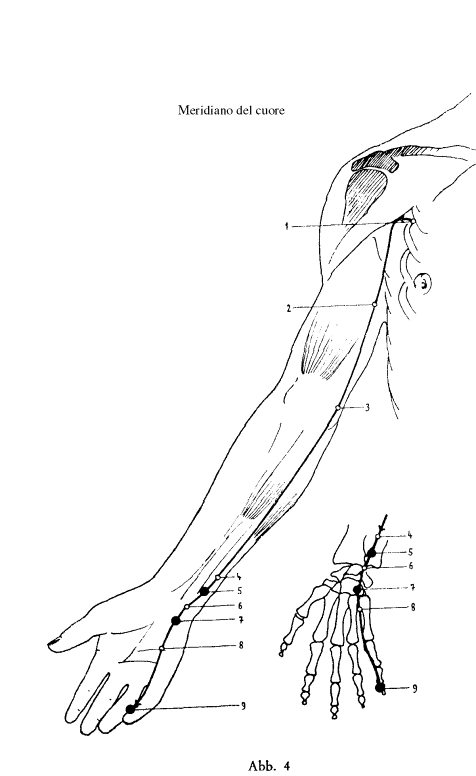
9.1.2 Meridiano dell¹intestino tenue IT
Spasmolitico
e effetti sulle mucose.
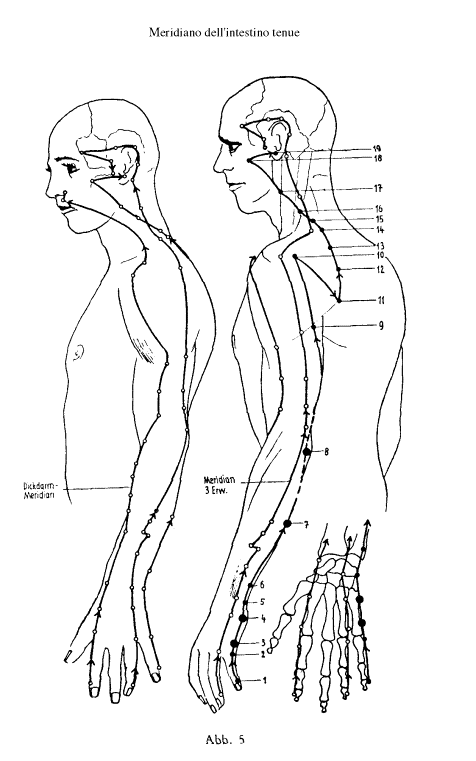
9.1.3 Meridiano della vescica urinaria VU
Effetti
sugli organi di escrezione.
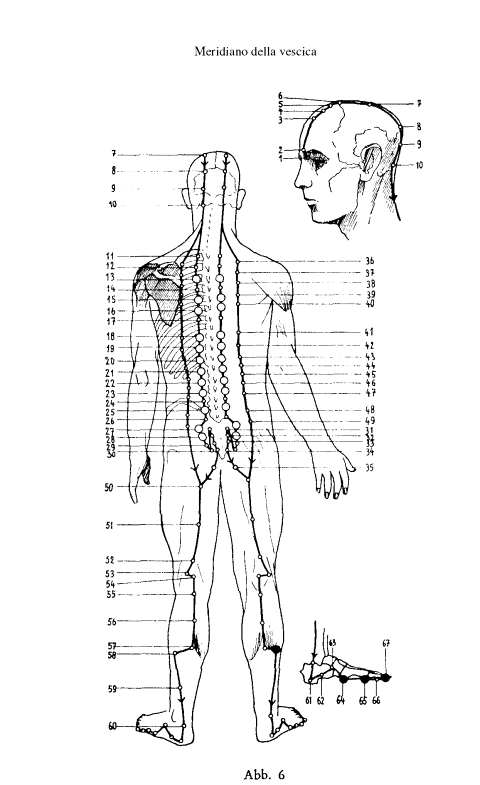
9.1.4 Meridiano del rene R
Effetti
dissimilativi ed effetti circolatori tramite le ghiandole surrenali.
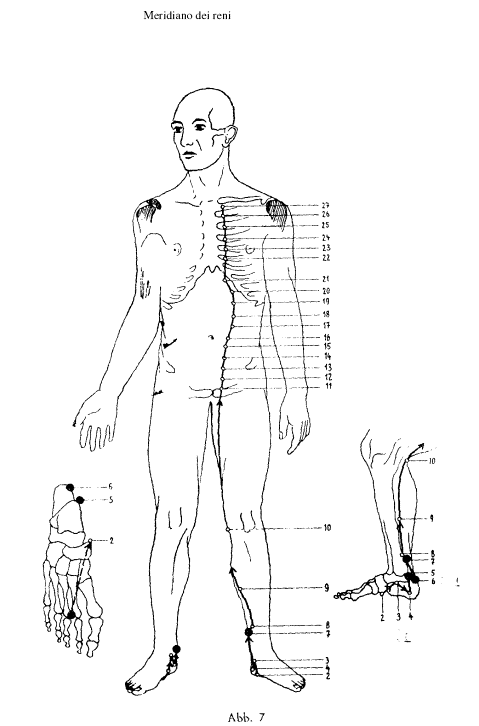
9.1.5 Meridiano del pericardio P
Effetti
sulla circolazione e la sessualità.
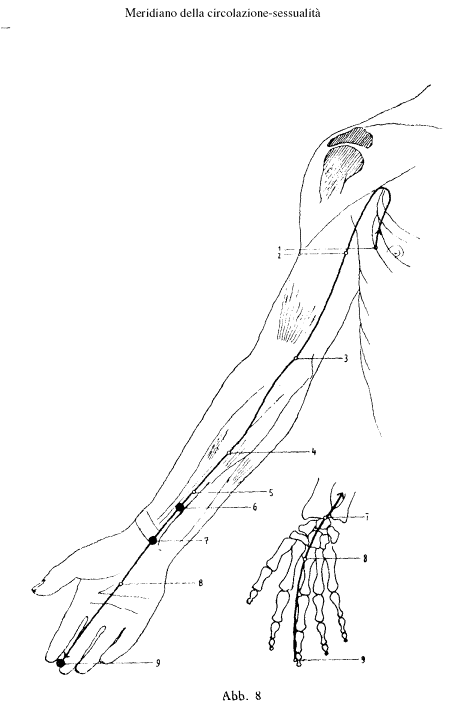
9.1.6 Meridiano del triplice riscaldatore T
Sostiene
funzioni di respirazione, digestione e urogenitali.
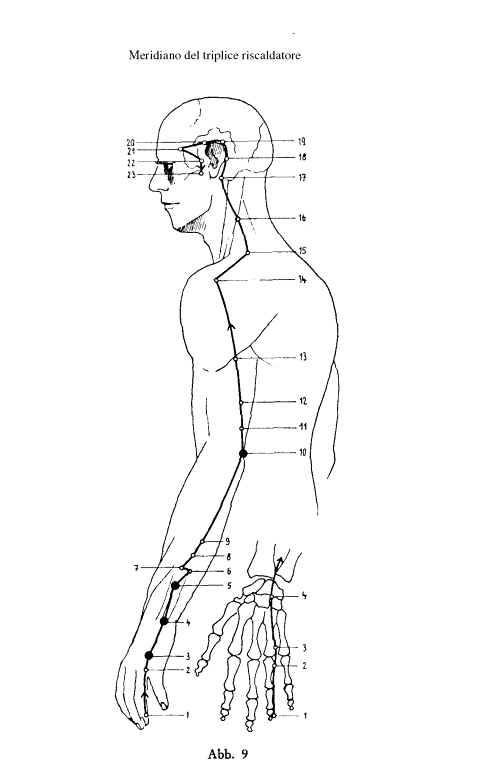
9.1.7 Meridiano della cistifellea VF (vescica fellea)
Effetti
spasmolitici e psichici.
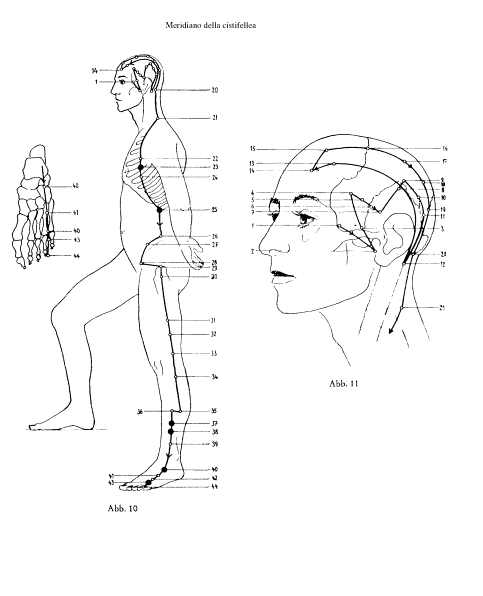
9.1.8 Meridiano del fegato H (hepar)
Funzioni di
assimilazione.
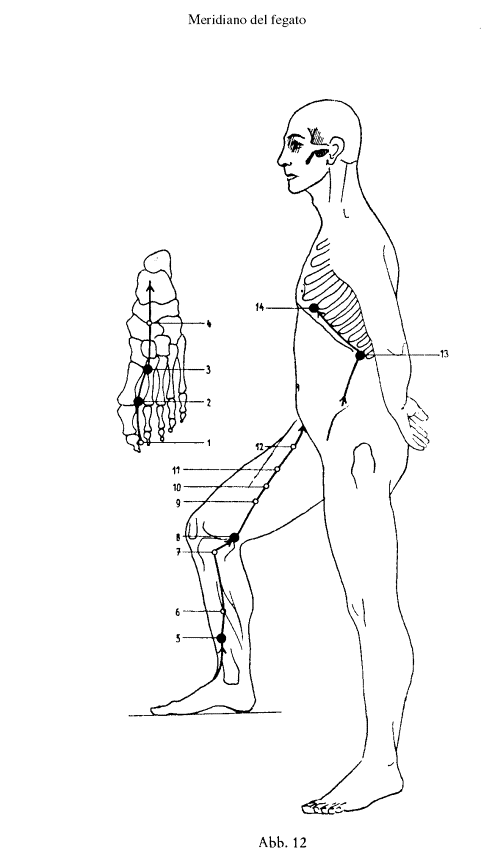
9.1.9 Meridiano del polmone P
Respirazione
e ritenzioni.
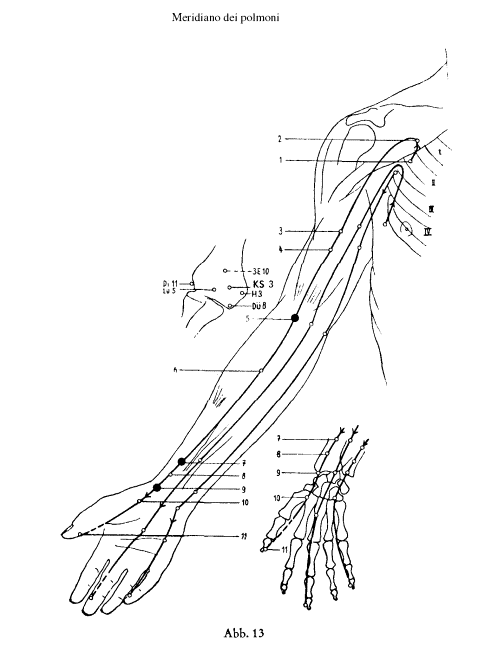
9.1.10 Meridiano dell¹intestino crasso IC
Effetti
sulle mucose e l¹escrezione.
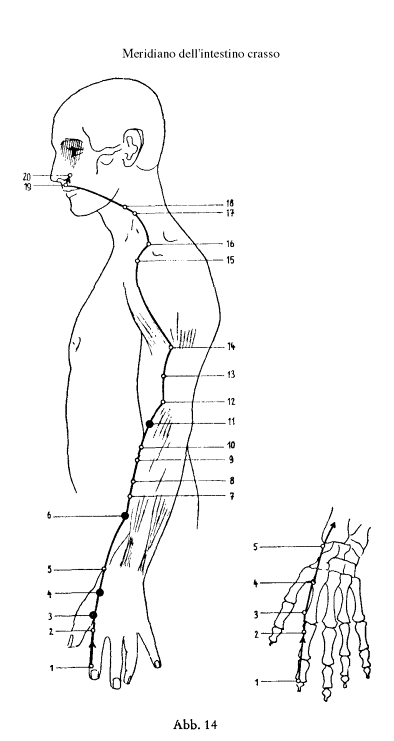
9.1.11 Meridiano dello stomaco S
Effetti
sulla digestione e circolazione, equilibrante psichico.
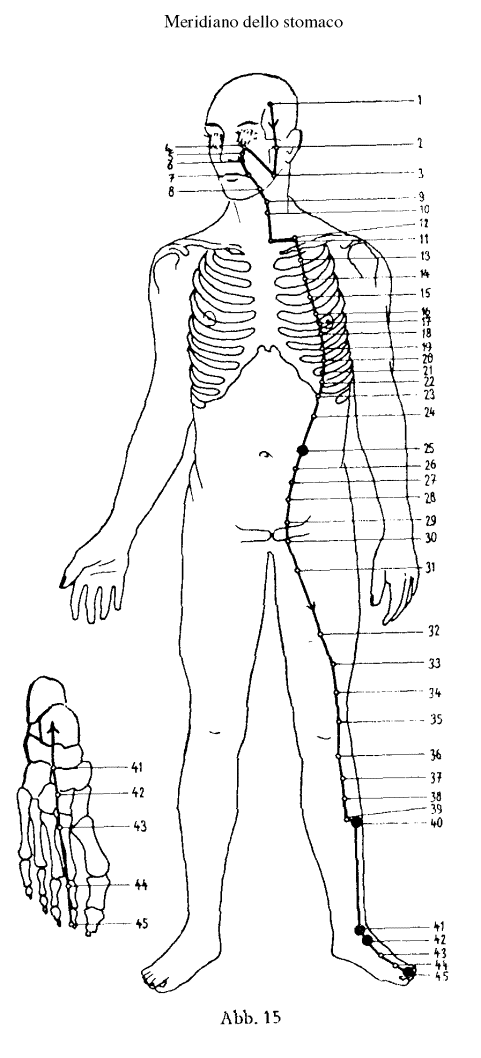
9.1.12 Meridiano di milza/pancreas SP (splen, pancreas)
Effetti
principali sul tessuto connettivo.
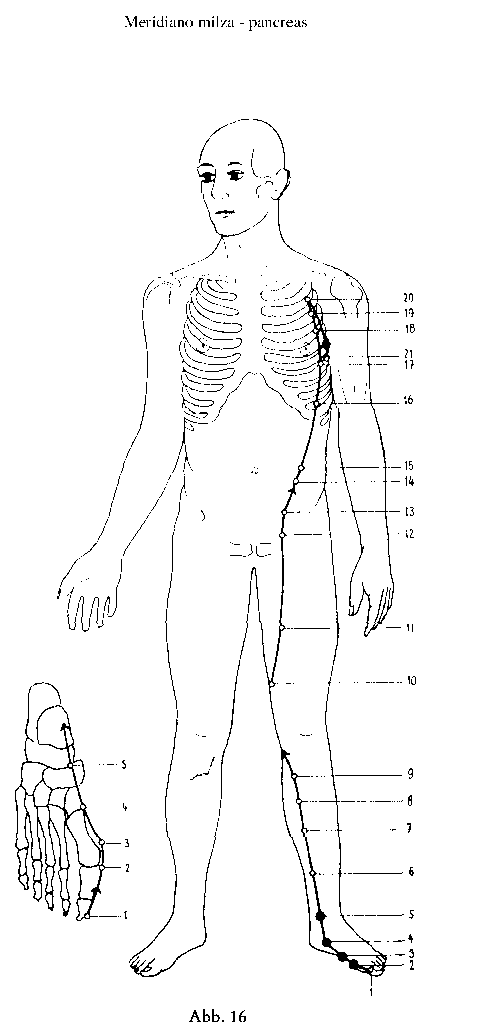
9.1.13 Vaso di concezione JENN-MO JC
Effetti
somatici sulla regione locale.
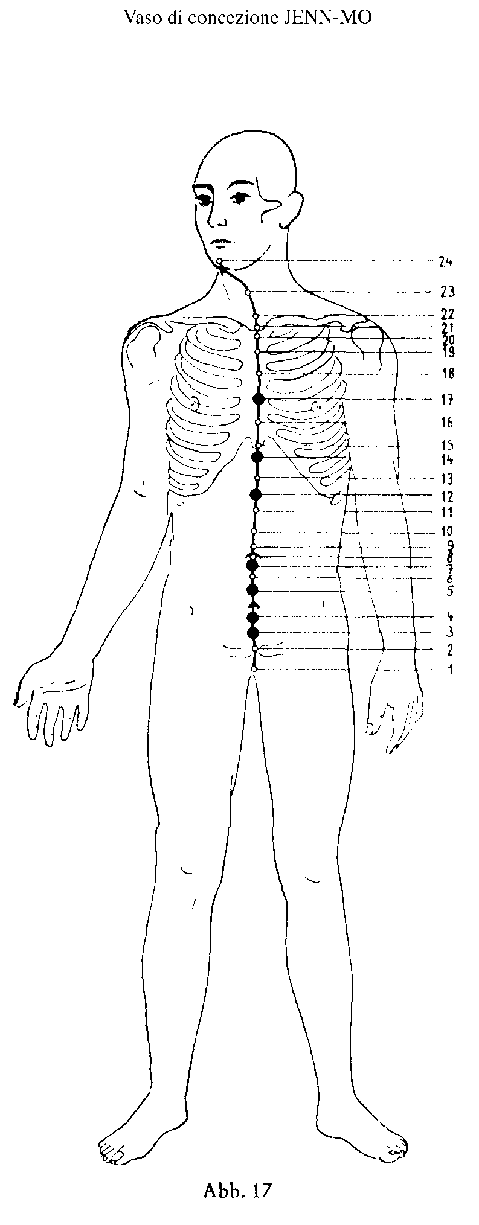
9.1.14 Vaso governatore TOU-MO JM
Parte
caudale: effetti somatici (spec. urogenitale); parte craniale: effetti
psichici.
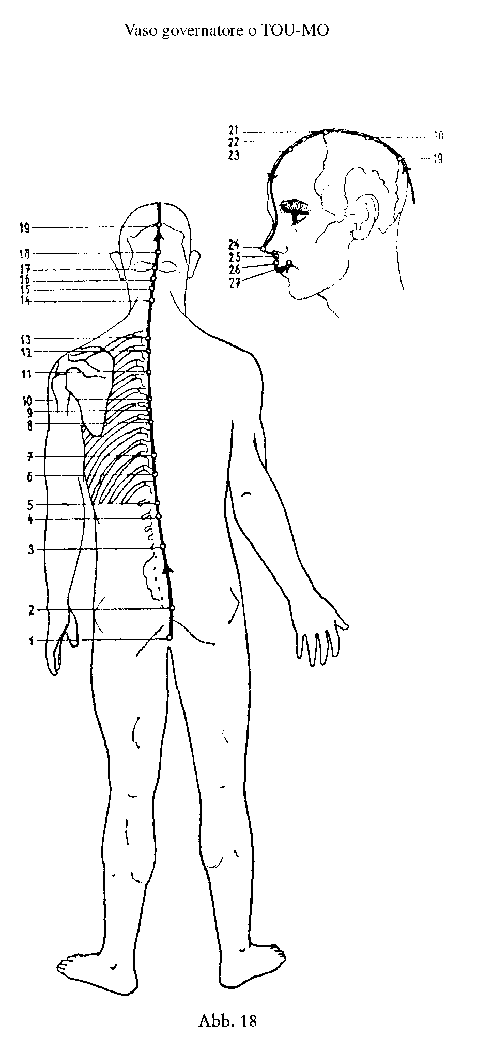
9.2 Indicazioni per l¹agopuntura
Vedi
tabella separata
Il testo stampato è reperibile
presso: LASER: Mario Santoro
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |