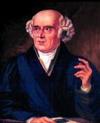|
|
Medicina popolare
per autodidatti
settembre 22, 2005 |
|
INDICE: Cenni omeopatici MN 4.3
1.0 Terminologia
1.1 Omeopatia
1.2 Allopatia
2.0 Caratteristiche omeopatiche
3.0 Metodologia dell¹omeopatia classica
3.1 Obiettivo
3.2 Formazione
3.3 Dall¹anamnesi al rimedio
3.4 Strumenti di lavoro
3.5 Aggiornamento
4.0 Preparazione e uso di rimedi omeopatici
4.1 Regolamenti
4.2 Prodotti standardizzati
4.2.1
Sostanze base per i rimedi
4.2.2
Potenze
4.2.3
Preparazioni
4.2.4
Posologia
4.3 Prodotti artigianali
4.3.1
Preparazione della tintura madre di
piante
4.3.2
Potenziamento
4.3.3
Uso del rimedio
4.3.4
Conservazione per uso futuro
4.3.5
Preparazione di minerali, tessuti e
metalli
4.3.5.1
Triturazione di minerali e
preparazione della tintura madre
4.3.5.2
Triturazione di tessuti e
preparazione della tintura madre
4.3.5.3
Rettifica di metalli
5.0 Cenni storici
6.0 Applicazione
e controindicazioni
6.1 Applicazioni e raccomandazioni
6.2 Controindicazioni, rischi
7.0 Principi,
massime e modelli omeopatici
7.1 Autoidentificazione degli omeopati
7.2 Delimitazioni
7.3 Interpretazione della malattia
7.4 Modello e massime terapeutiche
7.5 Criteri di valutazione medica omeopatica
7.6 Gerarchia dei livelli di manifestazione di
sintomi e malattie
7.7 Sequenze e procedure di guarigione
8.0 Metodi affini all¹omeopatia
8.1 Omeopatia classica
8.2 Medicina spagirica
8.3 Medicina antroposofica
8.4 Elettroagopuntura secondo Voll (EAV)
8.5 Omeopatia organotropa e funzionotropa
8.6 Nosode
8.7 Omotossicologia
8.8 Sali minerali in preparazioni omeopatiche
(Schüssler)
8.9 Fiori di Bach, fiori californiani, fiori
australiani,
9.0 Referenze
10.0
Bibliografia
- ³omeo² =
equo, uguale, simile
- ³pathos² =
dolore, malattia
Definizione
secondo Littré:
³Metodo
terapeutico che consiste nel curare le malattie somministrando a dosi
infinitesimali delle sostanze suscettibili a dosi sostanziali di provocare
nell¹uomo sano sintomi simili a quelli che si vogliono combattere
nell¹ammalato².
- La lingua
popolare indica spesso con ³omeopatia² tutte le terapie con rimedi non prodotti
dall¹industria farmaceutica, specie quelli ³naturali² come p.e. la fitoterapia.
- L¹uso
linguistico comune indica con il termine ³omeopatico² in genere le sostanze
³fortemente diluite², anche quando non hanno nulla a che vedere con i rimedi
omeopatici.
- ³allo² =
altro, diverso,
contrario;
- ³pathos² =
dolore, malattia;
-
Definizione secondo Garnier-Delamare:
³Trattamento
che si basa sul raggiungimento dell¹effetto inverso a quello causato dalla
malattia².
- Il
termine ³allopatia² venne usato per la prima volta da HAHNEMANN per designare
medicinali e terapie contrapposti all¹omeopatia. Nel frattempo è entrato
nell¹uso comune e spesso viene usato in modo dispregiativo.
2.0 Caratteristiche
omeopatiche
- Terapia
regolativa non materiale:
Utilizzando
meccanismi il cui funzionamento rimane sostanzialmente ignoto, benché esistano
diverse ipotesi esplicative, si tenta di sostenere l¹organismo nella sua lotta
contro la malattia.
- Dei tre
strumenti della medicina (parola, rimedio, tocco), quello nettamente
privilegiato è il rimedio.
La parola è
ampiamente usata durante l¹anamnesi e l¹inchiesta sui sintomi.
- Il punto
di partenza della terapia sono i sintomi individuali, interpretati come ³rumori
di battaglia² di uno specifico organismo contro una sua disfunzione. Non
vengono considerate le patologie generiche, anatomiche e fisiologiche. Per
questo motivo lo studio di anatomia, fisiologia e patologia è perfettamente
inutile per chi pratica esclusivamente omeopatia classica.
- Si cerca
un rimedio suscettibile di provocare a dosi sostanziali nell¹uomo sano sintomi
simili a quelli che si vogliono combattere nell¹ammalato.
- Il
rimedio è ³potenziato²: diluito a tappe fino a raggiungere dosi infinitesimali,
e dinamizzato (scosso o triturato in un mortaio) dopo ogni tappa di diluizione.
3.0 Metodologia
dell¹omeopatia classica
Trovare un
rimedio congruente al quadro dei sintomi del cliente, tenendo conto della sua
costituzione, dei disturbi e della disposizione.
Un medico
omeopatico classico subisce una lunga formazione severa e specializzata, ben
diversa da altre formazioni mediche, in quanto risponde ad altre esigenze.
La
patologia generica, l¹anatomia e la fisiologia interessano meno, poiché ci si
basa comunque su una sintomatologia individuale molto raffinata e sulla
conoscenza degli effetti sottili di rimedi di ogni genere.
In questo
contesto trovo strana la predisposizione contenuta nella legge sulle malattie e
infortuni, secondo la quale devono essere medici universitari a praticare
l¹omeopatia.
Gli studi
universitari, pagati dalla comunità (ca. 1 Mio. di Fr. per medico) sono
sbattutti via in quanto, per autodefinizione omeopatica, non sono applicati.
3.3 Dall¹anamnesi al rimedio
Il lavoro
del medico omeopatico consiste prevalentemente in:
- un
dialogo approfondito con il cliente nel quale tenta di individuare una vasta
gamma di sintomi particolari. Spesso questi non sono affatto evidenti,
trattandosi non solo di ³sintomi² nel senso classico di ³disturbi², ma anche di
elementi di costituzione, di disposizione o del modo di reagire tipico
dell¹organismo del cliente
-
un¹analisi e una valutazione dei risultati del dialogo ³a tavolino² con attenta
riflessione
- una
ricerca meticolosa ³a tavolino² di rimedi che si dimostrino simili secondo la
valutazione dei sintomi e delle caratteristiche del cliente, e la scelta per
eliminazione di uno o diversi di loro
-
determinazione della diluizione e posologia, istruzione, approvvigionamento e
consegna al cliente
-
sorveglianza delle reazioni del cliente ed eventuale ³correzione del tiro².
Si tratta
nel suo insieme di un lavoro che richiede tempo, non solo per l¹inchiesta
iniziale ma soprattutto per lo studio che il medico dedica alla scelta dei
rimedi. Non di rado una consultazione e il lavoro ³occulto² di ricerca dei
rimedi e di controllo sulle reazioni del cliente richiedono diverse ore:
calcolandone il costo secondo le tariffe orarie di medici o di naturopati, può
trattarsi di centinaia di franchi. Il costo dei medicamenti in confronto è
trascurabile.
Per il suo
lavoro, il medico omeopata si serve di diversi strumenti:
- moduli
per le inchieste, le analisi e le valutazioni
- grossi
volumi con esaurienti descrizioni di rimedi e dei loro effetti
- oggi
esistono anche programmi per ordinatori, utili specialmente nella prima fase
della ricerca.
L¹aggiornamento
del repertorio omeopatico è bene organizzato sin dai tempi del dottor
Hahnemann, in quanto escono regolarmente specifiche pubblicazioni con i
risultati dei vari progetti di ricerca, delle ³autoprove² e delle verifiche.
La raccolta
di tutti questi dati (autoprove, verifiche, collaudi, introduzione ed
esperimenti) è istituzionalizzata in modo che l¹omeopatia si evolve in
continuazione.
4.0 Preparazione
e uso di rimedi omeopatici
La
preparazione dei rimedi omeopatici è regolata fin dai tempi di Hahnemann nel
volume HAB (Hahnemann¹sches Arzneimittelbuch: libro dei rimedi hahnemanniani)
che descrive minuziosamente le sostanze usate e la preparazione dei singoli
rimedi nello stile della farmacopea.
Inoltre,
diverse legislazioni statali fissano condizioni e diritti di produzione e
commercio di tali prodotti semifiniti o finiti.
4.2 Prodotti standardizzati
È evidente
che il commercio di rimedi omeopatici richiede sostanze standardizzate,
prodotte sotto condizioni igieniche, conservate per lunghi periodi di tempo,
imballate e commercializzate professionalmente, nonché distribuite e documentate
per un largo pubblico (normalmente da farmacisti specializzati).
Le
procedure per la preparazione standardizzata di rimedi omeopatici sono
grossolanamente le seguenti:
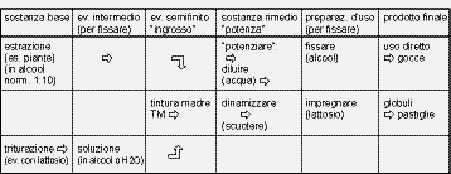
Si noti che
tutti questi procedimenti, ad eccezione di quelli per fabbricare globuli o
pastiglie destinati al commercio, non richiedono attrezzature né conoscenze
particolari.
Sono
trattati i seguenti temi:
4.2.1 Sostanze
base per i rimedi
4.2.1 Sostanze
base per i rimedi
Esiste una
grandissima quantità di sostanze base omeopatiche.
Christopher
Hammond, nel suo libro ³Krankheiten homöopathisch behandeln² propone una scelta
di ca. 40 sostanze base per il trattamento delle più frequenti patologie
³famigliari².
|
- Aconitum - Allium cepa - Antimonium
tartaricum - Arnica - Apis mellifica - Arsenicum
album - Belladonna - Bryonia - Calcium
carbonicum - Calendula - Cantharsis |
- Causticum - Chamomilla - Drosera - Dulcamara - Eupatorium
perfoliatum - Euphrasia - Ferrum
Phosphoricum - Gelsemium - Glonoinum - Hepar
sulfuris - Ipecacuanha |
- Kalium
bichromicum - Kalium
carbonicum - Lachesis - Ledum - Lycopodium - Mercurius
solubilis - Natrium
muriaticum - Nux vomica - Phosphorus - Pulsatilla - Rhus
toxicodendrum |
- Rumex - Silicea - Spigelia - Spongia - Staphisagria - Sulfur - Symphytum - Urtica urens |
4.2.2 Potenze
Nei paesi
germanici si usano normalmente le potenze D (decime) con tappe di diluizione
minori e dinamizzate più spesso, mentre nei paesi mediterranei si usano le
potenze
CH o C (CH
= centesimali hahnemanniani).
Per potenze
più alte si usano anche altre lettere (esempio Q) seguendo le cifre che
indicano i numeri romani.
D = potenziato
a tappe di 1:10 dalla tintura madre (Ø)
Es.:
D6 = diluizione 1:1¹000¹000 in 6 tappe con dinamizzazione intermedia
C o CH = potenziato
a tappe di 1:100 dalla tintura madre (Ø)
Es.:
C3 = diluizione 1:1¹000¹000 in 3 tappe con dinamizzazione intermedia
Q
=
potenziato a tappe di 1:50¹000 dalla tintura madre (Ø)
Es.:
Q2 = diluizione 1: 2¹500¹000¹000 in 2 tappe con dinamizzazione
intermedia
(corrisponde più o meno alla diluizione D9 o CH5).
Potenze
alte (superiori a CH30 o D60) reazione veloce, profonda e specifica, acuta.
Potenze
basse (inferiori a CH30 o D60) reazione lenta, spettro più largo, cronica.
Ad una
persona non esperta consiglierei di usare la potenza CH12: ha uno spettro più
largo del CH30 senza peraltro essere troppo specifico.
Quando
personalmente non sono sicuro della scelta della sostanza, opto per un D6.
La scelta
corretta della sostanza base è molto più importante della sua diluizione.
- Globuli
(lattosio imbevuto di rimedio).
- Gocce
(rimedio conservato in alcool).
- Pastiglie
(lattosio imbevuto di rimedio).
A seconda
del tipo di preparazione: 3 globuli, 2 gocce, 1 pastiglia per volta.
Non toccare
con le mani; sciogliere sotto la lingua; bocca pulita; non ingerire sostanze
con forti odori durante la cura.
Non
ripetere finché non va meglio o non peggiora. Stimolare in stasi!
Preparazione
della tintura, potenziamento, uso, conservazione.
Quando la
sostanza base è a disposizione, si consiglia di prepararsi personalmente i
rimedi per il proprio uso immediato. Questo era anche uno degli scopi di
Hahnemann, che auspicava una medicina ³per i poveri², cioè alla portata di
tutti.
Perché
prepararsi da soli il rimedio?
- Non è più
difficile o più impegnativo che prepararsi una tisana.
- Non ci
sono assolutamente problemi per il dosaggio.
- Stimola
la creatività autoterapeutica e la riflessione sul disagio.
Di seguito,
presento a titolo esemplare, la preparazione di un rimedio omeopatico come la
propone nel suo scritto ³Meine eigenen Heilmittel² il dottor Jürg Reinhart.
Sono
trattati i seguenti temi:
4.3.1 Preparazione
della tintura madre di piante
4.3.4 Conservazione
per uso futuro
4.3.5 Preparazione
di minerali, tessuti e metalli
4.3.1 Preparazione
della tintura madre di piante
Materiale:
coltello, vasetto con coperchio da ca. 2 cl, alcool (p.e. grappa), pianta.
-
Raccogliere e preparare la pianta con tatto, ³spiegandole² lo scopo delle
nostre azioni. Per esempio la cipolla: fa lacrimare gli occhi e servirà in
preparazione omeopatica a sgonfiare occhi lacrimanti e naso sgocciolante.
- Mettere
un pezzo della pianta nel vasetto riempito di alcool non denaturato (oppure
grappa o un altro superalcolico).
- Lasciar
macerare almeno 10 minuti, ma anche ore, giorni, mesi.
- Tutto è
ancora più efficace, se il preparato viene esposto al sole, trattato con
simpatia, magari anche parlandogli, e ogni tanto mosso.
4.3.2 Potenziamento
Diluizione
e dinamizzazione:
a) mettere
qualche goccia della tintura precedentemente preparata in un vaso di vetro che
si possa chiudere ermeticamente e ben pulito
b)
aggiungere ca. 0.5 dl di acqua del rubinetto
(diluizione
IC1 => IC = ³potenza Individuale Creativa²)
c) scuotere
energicamente per almeno 20 secondi, meglio se un minuto (dinamizzazione)
d) svuotare
il contenuto del vaso nel lavandino
e)
aggiungere ca. 0.5 dl di acqua del rubinetto (diluizione IC2)
f) ripetere
da c) fino a e) quattro volte, raggiungendo così IC6 (se si desidera una potenza
più alta, proseguire, ricordandosi di contare bene!)
g) il
risultato finale è un rimedio omeopatico che si chiama ³Allium cepa IC6²
h)
conservare, imbottigliare ed etichettare una parte
(vedi
³Conservazione per uso futuro²) Allium cepa IC6.
Uso
immediato e posologia.
- Uso
immediato: (es. Allium cepa IC6): bere il contenuto del vasetto alla potenza di
preparazione (IC6) potenziare di seguito una volta (IC7) e conservare per il
prossimo giorno (etichetta con contenuto e diluizione) proseguire così per 6
giorni (IC12).
- Posologia
della parte conservata:
casi acuti:
ogni 1 o 2 ore due gocce
casi
cronici: 3 volte al dì due gocce
4.3.4 Conservazione
per uso futuro
-
Aggiungere all¹ultima preparazione (o una parte di essa) ca. la stessa quantità
di alcool potabile (95%).
-
Imbottigliare in flacone con pipetta ed etichettare.
4.3.5 Preparazione
di minerali, tessuti e metalli
Sono
trattati i seguenti temi:
4.3.5.1 Triturazione di minerali e preparazione della tintura madre
4.3.5.2 Triturazione di tessuti e preparazione della tintura madre
4.3.5.1 Triturazione di minerali e preparazione
della tintura.
Materiale:
mortaio e pestello duro (es. agata), lima di diamante, lattosio, minerale (es.
gnesa), alcool (es. grappa), acqua
- grattare
nel mortaio con la lima di diamante un po¹ di polvere di minerale (p. es.
gnesa)
- triturare
per ca. 10 minuti
-
aggiungere lattosio (ca. 10 volte la quantità del minerale)
- triturare
per almeno 20 minuti (minerali duri come quarzo e vetro almeno un¹ora)
-
aggiungere alla polvere ottenuta un po¹ di acqua e ridurre a pasta fine
-
aggiungere alla pasta ca. 10 volte la stessa quantità di alcool (grappa)
-
imbottigliare ed etichettare (p. es. ³TM ø Gnesa²).
4.3.5.2 Triturazione di tessuti e
preparazione della tintura
Materiale:
mortaio e pestello, tessuto (p. es. unghia), argilla, alcool (es. grappa),
acqua
- triturare
per almeno 20 minuti
-
aggiungere tessuto finemente sminuzzato nel mortaio con l¹aggiunta di un po¹ di
argilla e aggiungere alla pasta ca. 10 volte la stessa quantità di alcool
(grappa)
- esporre
possibilmente al sole non meno di 10 minuti, ma anche alcuni giorni
-
imbottigliare ed etichettare (p. es. TM ø unghia Peter)
- minerali
e tessuti.
Materiale:
un pezzo di cote, limone, metallo (es. ferro), sale marino, acqua, alcool
-
rettificare il metallo con la cote bagnata e aggiungere limone (o altro succo
acido) fino ad ottenere una pasta fine
- il
metallo non si scioglie nell¹alcool, perciò non si procede con la tintura madre
-
potenziare subito con acqua p.e. IC6 aggiungendo un po¹ di sale marin alla
diluizione - conservare l preparazione come descritto nel paragrafo
³conservazione per uso futuro²
-
imbottigliare ed etichettare (p. es. ³TM ø Ferrum metallicum²).
5.0 Cenni storici
L¹inventore
dell¹omeopatia è il dottor Hahnemann, che nel suo libro ³Organon...² presentava
nell¹anno 1810 tutti gli elementi dell¹omeopatia classica, dalla diagnosi fino
alla cura.
Egli fa
riferimento ad una frase di Ippocrate contenuta in testi risalenti a 2000 anni
prima e fino ad allora rimasta oscura: ³...similia similibus curantur...² (il
simile si cura con il simile). Interessante il fatto che Ippocrate era sempre
molto esplicito nelle sue indicazioni, ma in questo caso non da nessun elemento
per spiegare il concetto.
In un
trattato di medicina ayurvedica, (che influì fortemente su Ippocrate) risalente
a 5000 anni fa, è scritto ³...quello che provoca una malattia la può anche
guarire...².
Stranamente,
anche nella medicina ayurvedica (³ayur²=salute ; ³veda²=trattato) i cui testi
sono sempre molto precisi e chiari, questo concetto non viene approfondito. Del
resto questa medicina è stata tramandata nei secoli e ancora oggi i suoi
principi sono largamente applicati nella medicina popolare in India, ma non si
trovano rimedi preparati secondo i criteri omeopatici.
Nella
medicina medioevale e rinascimentale europea e araba, come nella medicina
ayurvedica si usano preparazioni ³spagiriche², che in parte seguono il
principio del simile, ma più nel senso di analogie di struttura e funzione.
Anche
l¹idea di ³potenziamento² è presente, ma la sua realizzazione pratica è
raggiunta attraverso tecniche fisiche e chimiche più raffinate e complesse,
rispetto a quelle utilizzate in omeopatia (distillazione a circuito chiuso p.
es.).
Al tempo di
Hahnemann l¹arte medica ufficiale era drastica (purghe, salassi, vomito
indotto, medicamenti di dubbia origine e spesso velenosi).
La medicina
popolare dal canto suo, piuttosto superstiziosa e ciarlatana, aveva successo
soprattutto nel campo delle terapie cliniche e psichiatriche ed aveva seguaci
prevalentemente tra medici ed ecclesiastici.
Nella
moderna medicina clinica, dopo che Robert KOCH scoprì all¹inizio del secolo il
bacillo della tubercolosi e il vaccino contro questa malattia, esiste un
sorprendente parallelismo al principio omeopatico del simile che cura il
simile. Infatti una vaccinazione con germi inattivati ha come effetto quello di
stimolare il sistema immunitario ad una migliore difesa contro un particolare
germe patogeno in modo da evitare lo svilupparsi della malattia. In naturopatia
esiste una strana ambiguità in merito alle ³vaccinazioni² cliniche spesso
diabolizzate e metodi simili naturopatici glorificati (NOSADE, omotossicologia,
SPENGLERSAN, ) a scapito del povero utente disorientato.
La
naturopatia, oltre all¹omeopatia classica, conosce tutta una serie di metodi
terapeutici che sono deduzioni od ampliamenti dei principi omeopatici, o dove
l¹omeopatia fa parte di un concetto medico più ampio.
6.0 Applicazione e controindicazioni
6.1 Applicazioni e
raccomandazioni
6.1 Applicazioni
e raccomandazioni
-
molteplici disturbi anche cronici
- malattie
di origine psicosomatica
- malattie
remittenti
- terapia
complementare a quasi tutte le altre cure.
Secondo il
parere di certi omeopati, questa terapia è efficace contro quasi tutti i
disturbi, specialmente malattie croniche, psicosomatiche e debolezze del
sistema immunitario.
Altri ne
vedono l¹applicazione dove ci sono funzioni disturbate ma non distrutte,
escludendo quindi le patologie degenerative, consigliandone l¹uso complementare
ad altre terapie nelle malattie.
6.2
Controindicazioni e rischi
- seguendo
un trattamento professionale non si conoscono rischi
- potenze
inferiori a D8 o CH4 possono avere effetti allergici (specialmente se
iniettate)
- potenze
basse (inferiori a D6 o CH3) di rimedi a base di metalli pesanti o altre sostanze
molto tossiche possono causare intossicazioni, se vengono usate a lungo.
7.0 Principi,
massime e modelli omeopatici
7.1 Autoidentificazione
degli omeopati
7.3 Interpretazione
della malattia
7.4 Modello e
massime terapeutiche
7.5 Criteri di
valutazione medica omeopatica
7.6 Gerarchia di sintomi e malattie
7.7 Sequenze e
procedure di guarigione
7.1 Autoidentificazione degli omeopati
-
L¹omeopatia è un sistema medico completo.
- Rinforza
la capacità di autoguarigione dell¹organismo.
- Utilizza
rimedi che nel sano provocano i sintomi dell¹ammalato.
L¹omeopatia
si pone in un certo senso in contrasto con tutta quella medicina che definisce
³allopatica², cioè quella che invece di sostenere il concetto di autoguarigione
dell¹organismo, si oppone alla malattia.
7.3 Interpretazione della malattia
- Malattia
acuta:
³ribellione²
dell¹organismo contro una disfunzione.
- Malattia
cronica e recidiva:
l¹organismo
non è ancora riuscito ad organizzare la sua difesa contro quella disfunzione.
-
Disfunzione:
disturbo di
uno stato naturale funzionante.
-
Disponibilità:
inclinazione
alla malattia. In omeopatia questo è un fattore altrettanto importante che le
circostanze patologiche stesse. Inoltre, la disponibilità può aumentare
sensibilmente a seguito di problemi emotivi, relazionali e sociali.
- Malattia:
più che i
sintomi si prende in considerazione la disponibilità latente.
- Vitalità
e intelligenza corporea:
tramite
diversi sistemi, controllano la capacità di guarigione naturale dell¹organismo.
-
Equilibrio:
il
tentativo di ristabilire l¹equilibrio interno in situazioni difficili provoca
come reazione la comparsa di sintomi che sono segni di guarigione da una
malattia che probabilmente esiste da lungo tempo.
7.4 Modello e massime terapeutiche
- Il
sintomo viene considerato come segno di guarigione e l¹organismo viene
sostenuto con rimedi che nel sano creano una reazione simile.
- Un
insieme di sintomi viene letto non soltanto in relazione alla malattia, ma come
reazione individuale: dipendono quindi dalla costituzione e dalla reattività
momentanea del soggetto.
- Non
esiste quindi per definizione un rimedio omeopatico contro una determinata
malattia, ma ogni rimedio è studiato per un determinato individuo in
determinate condizioni.
- Malattie
acute: più rilevanti i sintomi tipici e la reattività momentanea.
- Malattie
croniche: diventano più importanti i fattori costituzionali e di vissuto.
- La
malattia agisce a livello corporeo, emotivo e mentale.
7.5 Criteri
di valutazione medica omeopatica
Attraverso
l¹anamnesi (inchiesta sui sintomi, osservazioni, analisi) il medico omeopatico
cerca di ordinare, interpretare e valutare:
- l¹attuale
stimolo patogeno e ³miasmi² (influssi ambientali patogeni),
- il
terreno costitutivo o personale sul quale questo stimolo si trova,
- dal
confronto dei due criteri, la reattività individuale.
7.6 Gerarchia
dei livelli di manifestazione di sintomi e malattie
Mentale => emotivo => corporeo
Mentale: paranoia,
distrazione... => dimenticanza
Emotivo: paure,
fobie... => irascibilità, nervosismo...
Corporeo: circolazione,
respirazione, cervello, nervi => muscoli, articolazioni,
intestino
=> epidermide, mucose esterne.
7.7 Sequenze
e procedure di guarigione
Si cura a
partire dal punto più alto della gerarchia, verso quello più basso.
I sintomi
dovrebbero sparire nell¹ordine inverso alla loro prima apparizione.
Questo
lavoro richiede un¹anamnesi meticolosa e un¹attenta valutazione dei dati.
8.0 Metodi
affini all¹omeopatia
Come per
ogni metodo terapeutico, anche all¹interno delle istituzioni omeopatiche ci
sono delle divergenze notevoli tra ³tradizionalisti, puristi, integralisti,
riducenti² e ³pragmatici, eclettici, evasivi, qualunquisti².
Nonostante
tutto questo, l¹omeopatia può essere considerata la madre di un approccio
medico diverso, che ha aperto la strada allo sviluppo di terapie meno
materialistiche, e dispone a tutt¹oggi di ottimi medici.
8.4 Elettroagopuntura
secondo Voll (EAV)
8.5 Omeopatia
organotropa e funzionotropa
8.9 Fiori di Bach, fiori
californiani, fiori australiani,
8.1 Omeopatia classica
Quella
sostanzialmente descritta in questo testo. Vedi anche il fascicolo ³Metodi
terapeutici alternativi².
Il termine
deriva da ³span² = separare e ³ageirein² = congiungere.
Molto più
antica dell¹omeopatia, era una branca della vecchia scienza alchemica, che
usava preparare sostanze vegetali, minerali o animali tramite processi fisici e
chimici come la distillazione, l¹incenerimento, la carburazione, la
sublimazione e la soluzione, per poi ricongiungere le frazioni ottenute.
Come per
l¹omeopatia, anche qui si segue il principio del simile (ma piuttosto inteso
nel senso della struttura e della funzione) e quello della dinamizzazione (ma
ottenuta tramite circuiti calorici e non con il semplice movimento meccanico).
Termine che
deriva da ³antropos² = uomo e ³sofia² = scienza.
Rudolf
Steiner (1861-1925) oltre alla sua opera umanistica, pedagogica e filosofica ha
concepito all¹inizio degli anni ¹20 in collaborazione con Ita Wegmann anche un
modello umano medico, il cui concetto di fondo può essere riassunto in questo
schema:
corpo fisico: fisico e chimico = minerale metabolismo,
movimento: volontà
corpo eterico: vitale = vegetativo EGO circolatorio, respiratorio, ritmico:
sentimento
corpo astrale: anima, coscienza, sensi,
nervi: percezioni, pensieri immaginazione
Molti
rimedi antroposofici (Weleda, Wala) sono preparati omeopaticamente (diluizione,
dinamizzazione potenziamento).
8.4 Elettroagopuntura
secondo Voll (EAV)
Il medico
tedesco Voll negli anni ¹50 ha sviluppato un apparecchio per diagnosticare
elettricamente delle malattie e disfunzioni utilizzando degli ³agopunti². In
seguito, ha sviluppato un metodo per testare i rimedi omeopatici e stabilire
quali siano in grado di guarire le malattie o regolare le disfunzioni.
Nel
frattempo diversi altri utenti di apparecchiature del genere hanno cominciato
ad usare rimedi omeopatici per la parte terapeutica del loro lavoro.
8.5 Omeopatia
organotropa e funzionotropa
Con questa
definizione si intende quel sistema terapeutico che fa riferimento all¹organo o
al sistema di organi oppure ad un sistema funzionale (p.e. sindrome) e che si
mette in relazione piuttosto con determinati disagi, che alla reattività
specifica e alla costituzione di un singolo individuo.
Lavora
prevalentemente con rimedi combinati di fabbricazione di massa.
Esempio:
BIORENAL per disturbi renali e delle vie urinarie.
Dal greco
³nosos² = malattia.
Concetto
elaborato da Costantin Hering nel 1830. Si tratta di una specie di vaccinazione
orale,cutanea o subcutanea con sangue, pus, germi patologici, tessuto canceroso
sterilizzato e diluito
Autonosode: con
materiale proprio dell¹individuo trattato
Eteronosode: con
materiale fabbricato industrialmente
Immunomodulator: nosode di combinazioni di germi
patologici sfregati sulla pelle (p.e. SPENGLERSAN)
In una lettura moderna si tratta di ³immunomodulatori² che
funzionano come ³vaccinazioni².
8.7 Omotossicologia
Deriva da
³omo² = uguale, simile e ³tossico² = velenoso.
H.H.
Reckeweg (1905-1985) oltre alle preparazioni omeopatiche classiche usa nosode,
preparati di organi, medicamenti e loro combinazioni potenziati (diluiti e
dinamizzati).
8.8 Sali
minerali in preparazioni omeopatiche
Il medico
Schussler ha semplificato l¹omeopatia, scegliendo circa una dozzina di rimedi
minerali, potenziati a D6 o D12 con tabelle indicative secondo criteri
patologici e sintomatici per l¹uso popolare.
Il termine
³mineraloterapia² con il quale spesso si indica questo sistema, può indurre in
errore i non esperti, facendo credere che si tratti di una terapia contro
carenze di sali minerali.
Questo
curare può costare molto caro a chi pensa di sostituire ³ferro² in un anemico o
³calcio² in un osteoperoso, mentre in realtà stimola ³l¹escrezione² dei due,
peggiorando la situazione.
8.9 Fiori
di Bach, fiori californiani, fiori australiani
Il medico
inglese Edward Bach elaborò, nel 1930, una terapia con 38 rimedi floreali
ottenuti facendo macerare i diversi fiori in acqua di sorgente alla luce del
sole e poi fissati in alcool come una specie di tintura madre.
Agiscono
sulle emozioni negative dell¹individuo che spesso sono la vera causa di
innumerevoli disturbi somatici. Completamente innocui, i rimedi floreali
ristabiliscono l¹armonia tra corpo e mente.
Spesso il
terapista di Bach usa il pendolo come strumento per testare il rimedio.
I Fiori
californiani sono una scoperta più recente (1978) e vengono considerati
l¹integrazione dei Fiori di Bach. Molti d essi curano disturbi psicologici
strettamente legati alla nostra epoca, come per esempio la difficoltà per certe
donne a conciliare il desiderio di maternità con quello di far carriera.
Al momento
sono entrati in circolazione in Europa circa una settantina di fiori, ma
un¹altra ventina è in fase di sperimentazione.
I Fiori
australiani sono centinaia e in Europa sono poco conosciuti.
Un gruppo
di terapisti in merito lavora su problemi spirituali, un altro gruppo su quelli
sessuali, altri ancora curano l¹individuo nella sua relazione con la società.
Il
principio terapeutico è sempre quello ideato dal dottor Bach: un tentativo di
conciliare l¹intrinseco conflitto tra biologia e civilizzazione.
Schweizerischer
Verein hömöopatischer Aerzte
Oberdorfstrasse
CH-8914
Augst
Internationale
Gesellschaft für Homotoxikologie
Postfach
504
D-76483
Baden-Baden
Dr.Edward
Bach Centre, Swiss Office
Mainaustrasse
15
CH-8034
Zürich
HAMMOND,
Christopher:² Krankheiten homöopathisch behandeln², Knaur 1993, ISBN
3-426-76013-4
REINHART,
Jürg; Dr.med.: ³Meine eigenen Heilmittel², Postfach 404, CH-3770 Zweisimmen
MASCI,
Walter ³L¹omeopatia per tutti² (ottima introduzione didattica!)
GARNIER-DELAMARE
³ Dizionario dei termini di medicina² Manduzzi editore
Ordinazione del testo stampato: LASER: Mario Santoro
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |