|
|
Medicina popolare
per autodidatti
ottobre 16, 2005 |
|
... , quando gli amanti nel bacio sincronizzano il loro respiro
... (Montherland)
Indice MN 4.10 Terapie respiratorie
1.0 Introduzione
1.1
Respiro autonomo e controllato
1.2
Condizioni di respirazione autonoma
1.2.1
Attività
1.2.2
Sforzo
1.2.3
Condizioni fisiche esterne e
interne
1.2.4
Emozioni e le loro espressioni
respiratorie
1.2.5
Espressione di condizioni
vegetative
1.2.6
Abitudini respiratorie
1.3
Respiro come strumento
1.3.1
Controllo del respiro
1.3.2
Allenamento e abitudini
respiratorie
1.3.3
Impiego fisiologico e ideologico
1.4
Scopi di respirazione controllata
1.4.1
Perfezionamento di attività
1.4.2
Controllo di emozioni
1.4.3
Manipolazione di funzioni
vegetative
1.4.4
Terapie respiratorie
1.4.4.1
Terapia di disfunzioni e patologie
respiratorie
1.4.4.2
Terapie alternative respiratorie
1.4.4.2.1
Terapie respiratorie di Schmitt, Dürckheim, Olschewski, ...
1.4.4.2.2
Prana Yoga
1.4.4.2.3
Meditazione
1.4.4.2.4
Training autogeno, metodo di distensione progressiva muscolare Jacobson
1.4.4.2.5
Terapie processuali
1.4.4.2.6
Rebirthing, regressione
1.4.5
Usurpazioni ideologiche
1.4.5.1
Adetti e ³maestri²
1.4.5.2
Effetti
2.0 Respirazione funzionale
2.1
Basi anatomiche e fisiologiche
2.1.1
Diaframma
2.1.2
Muscolatura respiratoria toracica
2.1.3
Idee sui movimenti respiratori
2.1.3.1
Modelli fisioterapeutici
2.1.3.2
Modello del Netter
2.1.3.3
Modello di Parow
2.2
Movimento respiratorio
2.2.1
Modello di meccanica respiratoria
2.2.2
Ruolo dinamico dei polmoni
2.2.3
Ispirazione afonica
2.2.4
Espirazione afonica
2.2.5
Respirazione nasale e orale
2.2.6
Squilibri e superstizioni
respiratori
2.3
Portamento e respirazione ³ordinaria²
2.3.1
Coinvolgimento della ³muscolatura
ausiliaria²
2.3.2
Postura e respirazione
2.3.3
Lavoro corporeo posturale
respiratorio
2.4
Respirazione durante sforzi fisici
2.5
Rendimento respiratorio
2.6
Forma respiratoria e scambio di gas
2.7
Regolazione respiratoria
2.8
Formazione del suono
2.8.1
Regolazione respiratoria nel suono
2.8.2
Tratti superiori respiratori
2.8.3
Fonazione e laringe/corde vocali
2.8.4
Sonorizzazione e faringe
2.8.5
Vocalizzazione/articolazione
2.8.5.1
Cavità nasale, muscolatura mimica
2.8.5.2
Cavità boccale, lingua, labbra,
mandibola
2.9
Ginnastica naturale respiratoria
2.9.1
Gemito
2.9.2
Sospiro
2.9.3
Sbadiglio
2.9.4
Sorriso
2.9.5
Soffiare e zufolare
2.9.6
Starnutire
2.9.7
Tossire
3.0 Respirazione
disfunzionale
3.1
Errori movimentali del tronco
3.2
Impedimento del diaframma
3.3
Errori movimentali addominali
3.4
Errori movimentali polmonari
3.5
Errori di regolazione respiratoria
3.6
Cause per la respirazione disfunzionale
3.6.1
Deformazioni spinali/toraciche
3.6.2
Rigidità muscolari lombo-addominali
3.6.3
Abitudini di abbigliamento
3.6.4
Debolezze di muscolatura toracica
3.6.5
Malattie nasali
3.6.6
Traumi fisici e psichici
3.6.7
Tensioni muscolari e abitudini
respiratorie emotive/psichiche
3.6.8
Disturbi vocali
3.7
Sviluppo della respirazione disfunzionale
3.7.1
Respirazione pressata
4.0 Trattamento
della respirazione disfunzionale
4.1
Generale
4.1.1
Massime per il lavoro respiratorio
4.2
Esercizi toracici
4.3
Regolazione respiratoria
4.4
Esercizi di respirazione ordinaria
4.4.1
Muscolatura lombo-addominale
4.4.2
Diaframma
4.4.3
Distensione generale
4.4.4
Regolazione respiratoria ausiliaria
4.5
Eliminazione di errori respiratori
4.5.1
Trattenimento respiratorio
4.5.2
Tosse
4.5.3
Disturbi vocali
4.6
Rinforzo della respirazione
4.7
Correzione della spina dorsale
4.8
Obiettivi e successi
5.0 Respirazione
patologica
5.1
Dilatazione polmonare (enfisema)
5.1.1
Sviluppo della dilatazione
5.1.1.1
Respirazione pressata continua
5.1.1.2
Movimenti toracici paradossali
5.1.1.3
Attacchi di asma a causa della
dilatazione polmonare
5.2
Asma bronchiale
5.2.1
Malattie asmatiche
5.2.2
Asma spastico-nervosa
5.2.3
Asma allergica-eczematosa
5.2.4
Nervosismo e asma
5.2.5
Asma e ipersensibilità emotiva
ansiosa
5.2.6
Asma catarrale
5.2.7
Evoluzione dell¹asma
6.0 Trattamento
delle patologie respiratorie
6.1
Dilatazioni polmonari (enfisemi)
6.1.1
Respirazione pressata negli
enfisemi
6.1.2
Movimenti toracici paradossali
6.1.3
Prevenzione di enfisemi, bronchiti
croniche
6.2
Bronchiestasie
6.3
Tubercolosi polmonare
6.4
Silicosi
6.5
Operazioni toraciche
6.6
Cicatrici pleuriche
6.7
Asma bronchiale
6.7.1
Cedimento della parete addominale
6.7.2
Stimolazione del diaframma
6.7.3
Disinserimento della respirazione
pressata
6.7.4
Diminuzione di attacchi
6.7.5
Trattamenti sintomatici
6.8
Altre patologie trattabili con la terapia
respiratoria funzionale
1.0 Introduzione
Ho deciso
di essere esplicito in questa dispensa per i seguenti motivi:
- Un
naturopata dovrebbe intendersi di una funzione elementare come il respiro.
- Sul
mercato alternativo girano le più diffuse idee in merito e spesso le loro
applicazioni sono antiterapeutiche.
- Nella
letteratura medica esiste poco di fondato, e di conseguenza anche le tecniche
paramediche sono spesso basate più su delle credenze che su dei fatti.
- L¹opera
di Julius PAROW che malauguratamente esiste solo in tedesco fornisce delle basi
pulite e plausibili, sia teoriche che tecniche, applicabili anche dal
terapista.
Nell¹introduzione
vengono trattati i seguenti temi:
1.1 Respiro autonomo e controllato
1.2 Condizioni di respirazione autonoma
1.4 Scopi di respirazione controllata
1.1 Respiro
autonomo e controllato
L¹inventore
ha previsto che il respiro funzioni automaticamente, né controllato né imposto
dalla volontà. Lo dimostrano dei fatti come il sonno, lo svenimento, la
narcosi, la limitata capacità di trattenere il fiato e che per fortuna la
maggior parte di noi, durante il giorno, ha meglio da fare che controllare e
guidare il proprio respiro.
D¹altra
parte siamo capaci di controllare e guidare il respiro entro certi limiti.
Questa grazia è sfruttabile come strumento per diversi scopi ed è comunemente
applicata nelle umane capacità di linguaggio e canto.
1.2 Condizioni
di respirazione autonoma
Ci sono
tanti tipi di respirazione autonoma che dipendono dall¹attività, dallo sforzo,
dalle condizioni fisiche, dall¹emozione e da condizioni vegetative nonché da
abitudini respiratorie.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
1.2.3 Condizioni
fisiche esterne e interne
1.2.4 Emozioni e
le loro espressioni respiratorie
1.2.5 Espressione
di condizioni vegetative
Nelle
attività contano i movimenti corporei, la voce e la lingua:
- I
movimenti corporei in senso lato, spaziano dal nuoto, la corsa, le attività
artigianali, i movimenti spontanei quotidiani, la passeggiata, fino al riposo,
al sonno e al sogno.
- Lingua e
voce interessano in modo particolare attività come la recitazione, il canto e
l¹esercizio di strumenti a fiato.
Lo sforzo
delle attività (anche del respiro, dei movimenti cardiaci e peristaltici)
richiede più o meno aria secondo:
- il
fabbisogno reale e
- l¹impiego
economico dei movimenti respiratori stessi (maggior effetto a minimo sforzo).
1.2.3 Condizioni
fisiche esterne e interne
Le
condizioni fisiche.
- Esterne
come temperatura, umidità, inquinamento, odori,
- e il
funzionamento individuale dell¹apparato respiratorio
- fino alle
patologie respiratorie di naso, gola, trachea, bronchi, polmoni, pleura e
muscolatura respiratoria) sono altrettanto determinanti per il respiro.

1.2.4 Emozioni
e le loro espressioni respiratorie
L¹emozione.
- Uno
spavento ci toglie il fiato.
- Un grande
sospiro è liberatorio.
- L¹attesa
rende il respiro corto e piatto,
- o calmo e
profondo in mezzo alla sfida dell¹opera dimenticandosi di sé stesso.
- Non si
esprime esclusivamente con il portamento, la gestualità e la mimica ma anche
con il pianto, i sospiri, i singhiozzi, i gemiti ..., ci fa ridere e urlare
fino a tipici meccanismi respiratori d¹emergenza come nell¹isterismo, o nel panico,
(³mortificato², ³rimanere di stucco²)
1.2.5 Espressione
di condizioni vegetative
Delle
condizioni vegetative si esprimono in movimenti come lo sbadiglio, lo starnuto,
la tosse, il raschio (pulirsi la gola), il vomito, l¹impulso di strozzamento,
il singhiozzo, il rutto, il russare
Anche altre
condizioni vegetative inconscie e coscienti (dolore, prurito, solletico, )
cambiano la respirazione.
Le
abitudini respiratorie vengono impostate con lungo esercizio di forme
respiratorie relate a determinate attività.
- Volute e
coscienti nell¹allenamento o
- inconsce
per via di:
-
innumerevoli ripetizioni spontanee o
- di traumi o frustrazioni subiti.
Vengono
trattati i seguenti temi:
1.3.2 Allenamento
e abitudini respiratorie
1.3.3 Impiego
fisiologico e ideologico
L¹inventore
ci ha regalato la grazia di sfruttare il respiro come strumento, di poter
controllarlo per determinati scopi consci o inconsci. Il più noto è l¹uso della
voce.
1.3.2 Allenamento
e abitudini respiratorie
Il
controllo del respiro come strumento permette di allenarlo (coscientemente o
incoscientemente), instaurando (o modificando) automatismi comodi o utili per
certe circostanze.
1.3.3 Impiego
fisiologico e ideologico
Come di
solito ci si pone la domanda sull¹uso dello strumento:
- Che gli
scopi o gli automatismi siano fisiologicamente economici.
-
Indipendentemente da quali effetti collaterali fisici e psichici essi abbiano.
- Che siano
relazionalmente e socialmente sostenibili o scusabili.
- Insomma,
che venga usato in modo saggio, spensierato o come se dovessimo, ancora una
volta, correggere l¹inventore, visto che pare abbia sbagliato proprio tutto.
1.4 Scopi
di respirazione controllata
I
principali scopi dell¹uso del respiro come strumento sono il perfezionamento di
determinate attività, il controllo di emozioni (e le loro espressioni), la
manipolazione di funzioni vegetative, tentativi terapeutici e l¹usurpazione
ideologica di funzioni corporee e mentali tramite il respiro.
Vengono
trattati i seguenti temi:
1.4.1 Perfezionamento
di attività
1.4.3 Manipolazione
di funzioni vegetative
1.4.1 Perfezionamento
di attività
Il
perfezionamento di determinate attività è un fattore comune della cultura
umana, lo fa l¹artigiano per economizzare gli sforzi del suo mestiere, il
nuotatore di competizione, il cantante lirico e il trombonista e parte della
loro bravura dipende proprio da quanto riescono ad automatizzare, coordinare,
sincronizzare, controllare il loro respiro.
Il
controllo di emozioni e delle loro espressioni si basa sulla semplice
esperienza umana individuale. Si può indirettamente riuscire a domare certe
emozioni tramite il respiro fino al punto di poter modificare degli stati
d¹animo. Chi da bambino non ha fatto l¹esperienza di sopprimere dolori psichici
trattenendo il fiato e facendo pressione sull¹addome, chi non ha mai trattenuto
le lacrime, il singhiozzo, lo starnuto o lo sbadiglio come espressioni
vegetative o emotive socialmente malviste?
1.4.3 Manipolazione
di funzioni vegetative
La
manipolazione di funzioni vegetative, tramite il respiro, può essere legata:
- Più verso
scopi emotivi spontanei come ai dolori. Il dentista ti fa respirare attraverso
il naso per minimizzare l¹impulso di strozzamento.
- Più verso
obiettivi generalizzati negli esercizi di respirazione distensivi (p.es.
Training autogeno, rilassamento muscolare progressivo Jacobson, distensione respiratoria).
- O più
verso obiettivi specifici fisiologici e psichici come in certe scuole di Prana
Yoga e nelle terapie respiratorie occidentali. Meglio tener presente che si
tratta qui di una specie di medicazione con precise indicazioni e
controindicazioni, effetti collaterali e non desiderati che sono taglienti e si
trovano meglio nelle mani dell¹esperto.
Da tempi
remoti e in tutte le culture mediche si usa il respiro a scopo terapeutico e
ciò è rimasto specialmente nelle tradizioni orientali. Anche la medicina
occidentale si serve di questo strumento sia clinicamente sia in modo
complementare e alternativo.
Vengono
trattati i seguenti temi:
1.4.4.1 Terapia
di disfunzioni e patologie respiratorie
1.4.4.2 Terapie
alternative respiratorie
1.4.4.1 Terapia
di disfunzioni e patologie respiratorie
La
possibilità di allenamento respiratorio permette di:
-
Ripristinare funzioni respiratorie lese come avviene negli ospedali p.es. dopo
gli infarti polmonari.
-
³Correggere² delle irregolarità posturali e anatomiche e movimentali come lo
tentano spesso i fisioterapisti.
- Curare
disfunzioni e patologie legate all¹apparato respiratorio dal naso fino ai
muscoli respiratori principali e ausiliari come viene proposto della medicina
complementare.
Come
terapista corporeo, personalmente utilizzo ampiamente il respiro del cliente:
- Lavoro
nel ritmo del suo respiro.
- Seguo i
micromovimenti respiratori ed, eventualmente, li amplifico.
- Ma non li
induco mai, né li ³correggo² attivamente.
- Uso molto
raramente ³esercizi respiratori², salvo in casi patologici (PAROW).
1.4.4.2 Terapie
alternative respiratorie
La
respirazione è un processo vitale. Funziona automaticamente. In certi limiti è
anche controllabile ed influenzabile. Su questo fatto si basano delle tecniche
respiratorie coscienti, che spesso sono più ideologiche che fisiologiche.
Molti
terapisti che lavorano con il tocco dedicano una grande attenzione alla
respirazione sia conscia sia inconscia: adattando il loro respiro al ritmo del
cliente, riattivando la muscolatura respiratoria non attiva, dando istruzioni
di respiro Altre terapie usano il respiro cosciente per scopi spirituali o per
il sostegno di esercizi fisici (Prana e Hatha Yoga), ancora altri per
raggiungere degli stati muscolari o emotivi alterati.
L¹altro
argomento è la qualità dell¹aria stessa in una certa regione. Nel secolo scorso
esistevano delle cliniche in alta montagna per la cura della tubercolosi che
sparirono o vennero trasformate con la quasi scomparsa della malattia. Chissà
quando riprenderà la tradizione visto l¹aumento delle malattie respiratorie.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
1.4.4.2.1 Terapie respiratorie di Schmitt, Dürckheim,
Olschewski, ...
1.4.4.2.4 Training autogeno, metodo di distensione progressiva
muscolare Jacobson
1.4.4.2.6 Rebirthing, regressione
1.4.4.2.1 Terapie
respiratorie di Schmitt, Dürckheim, Olschewski,
Serie di
esercizi respiratori con scopi prevalentemente distensivi.
Una parte
del Hatha Yoga della tradizione spirituale indiana.
Prana =>
fiato, tradotto anche come energia vitale, forza vitale,
Yoga =>
giogo, tradotto anche come disciplina, guida, controllo,
Hatha =>
fisico, tradotto anche come corpo, organismo, movimento, posizione, ...
Il Prana
Yoga insegna la respirazione cosciente spesso sincronizzata con esercizi fisici
per raggiungere effetti fisiologici ed emotivi. Il mio insegnante in merito
KERNEÎZ più di trent¹anni fa m¹insegnò le seguenti massime per l¹applicazione
medica:
-
L¹esercizio respiratorio va trattato come un medicamento, applicato in modo
discriminatorio valutando il minor male secondo indicazioni e controindicazioni,
effetto ed effetto collaterale.
- Quando il
medicamento diventa un¹abitudine, danneggia.
Spesso
respirazione cosciente connessa con determinate posizioni ed immaginazioni per
raggiungere stati di coscienza alterati.
1.4.4.2.4 Training
autogeno, metodo di distensione progressiva muscolare Jacobson
Una buona
parte di questo metodo consiste nella respirazione cosciente ³indirizzata² per
raggiungere stati di distensione muscolare ed emotiva.
Tante
terapie processuali basandosi su REICH, MINDELL, usano il respiro come
strumento.
1.4.4.2.6 Rebirthing,
regressione
Respirazione
cosciente forzata per raggiungere una iperventilazione con degli stati di
coscienza alterati.
L¹usurpazione
ideologica di funzioni corporee tramite il respiro si basa su due idee
fondamentali:
- Che
l¹inventore comunque abbia sbagliato, obbligandoci a vivere in qualcosa di così
profano come un corpo;
- e quindi
bisogna farlo funzionare secondo i nostri trascendentali concetti spirituali.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
- Adetti e
³maestri².
- Effetti.
- Gli
addetti più ignoranti di questo stampo si riconoscono quando tentano di
insegnare come si respira ³giustamente².
- I
³maestri² di questo genere fanno fare delle complicatissime teorie respiratorie
(che hanno contro di sé solo la realtà anatomica e fisiologica) e una vera
³farmacia² di esercizi (ma senza spiegare gli effetti, le indicazioni e le
controindicazioni).
Sembra un
divertimento come un altro ma non lo è più quando come terapista si tocca il
torace di un discepolo di questa disciplina dopo qualche anno:
- Quasi
tutti sono riusciti a disinserire il movimento della muscolatura respiratoria
principale.
-
Impiegando nel movimento quella ausiliaria che sarebbe prevista per la tenuta
delle forze respiratorie.
Si
accusano, in seguito, i più diversi sintomi neurovegetativi, motori, digestivi
e cardiocircolatori.
Vengono
trattati i seguenti temi:
2.1 Basi anatomiche e fisiologiche
2.3 Portamento e
respirazione ³ordinaria²
2.4 Respirazione
durante sforzi fisici
2.6 Forma respiratoria e
scambio di gas
2.9 Ginnastica
naturale respiratoria
2.1 Basi
anatomiche e fisiologiche
Il
movimento respiratorio è:
- l¹espansione
e la compressione dei polmoni tramite la pleura, un movimento perfettamente
passivo, provocato da movimento e forze sincronizzate di muscoli principali e
ausiliari di ispirazione ed espirazione.
Il seguente
ritratto di un plastinato di Von Hagens rende l¹idea della disposizione degli
organi toracici e addominali coinvolti. Visto che si tratta di un cadavere, il
diaframma è completamente atonico, cosa che non succede in un essere vivente.
Vengono
trattati i seguenti temi:
2.1.2 Muscolatura
respiratoria toracica
2.1.3 Idee sui
movimenti respiratori
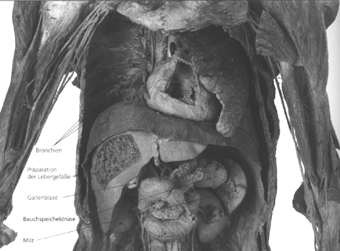
Il
diaframma è il muscolo principale del movimento respiratorio. Il seguente
dipinto del NETTER fa vedere particolarmente bene le ³sospensioni² posteriori
legamentose tra vertebre lombari L1...L4 e la punta della 12a vertebra. Lateralmente
e anteriormente il diaframma è fissato alle parti cartilaginose interne delle
ultime sei coste.
La
contrazione del diaframma lo appiattisce ed esercita delle forze verso
l¹interno (centripete):
- Sulle
vertebre lombari L1L4 (trazione ventro-craniale).
- Sulle
parti anteriori delle coste 612 e quindi sulle loro giunture costovertebrali
(rotazione caudale).
- Sul
processo xifoideo dello sterno (trazione craniale).
Queste
forze devono essere compensate maggiormente (non raffigurate sul dipinto):
- Dalla
muscolatura toracica (specialmente la parte intrinseca).
- Dalla
muscolatura dell¹erector trunchi tra le vertebre C7 e L4, fascia muscolare
posturale (di tenuta) per ecellenza.
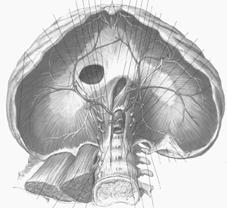
2.1.2 Muscolatura
respiratoria toracica
Il seguente
dipinto del NETTER (torace interno ventrale ed esterno dorsale) dà un¹idea
della muscolatura toracica capace della formazione attiva del torace e compensatoria
alle forze esercitate dal diaframma:
- Le fasce
muscolari diaframmali che appiattiscono la campana diaframmale
longitudinalmente.
- I muscoli
intercostali interni ed esterni che creano delle forze trasversali aprendo la
campana toracica e che si oppongono alle forze centripete del diaframma.
Il
movimento toracico è controbilanciato dai muscoli con prevalenti funzioni di
tenuta posturale:
-
Ventralmente (verso lo sterno) dai muscoli transversi toracali e
-
dorsalmente dai muscoli serrati, levatores costarum e transversospinalis in
competizione con l¹erector spinae con la primordiale funzione di mantenere la
postura longitudinale.
In
direzione craniale il torace è tenuto in posizione (appeso) dalla muscolatura
(posturale) collare profonda e dai muscoli scaleni e sternocleidomastoidei alla
spina cervicale e al cranio.
L¹appiattimento
del diaframma guadagna volume nella cavità toracica a scapito della cavità
ventrale-pelvica; gli organi si spostano e richiedono volume. Questo è regolato
dalla muscolatura lombo-ventrale dove:
- In
direzione trasversale i muscoli obliqui e il transversus abdominis regolano il
volume (per tenuta e movimento). - In direzione longitudinale i muscoli rectus
abdominis, quadratus lumborum e la relativa porzione dell¹erector trunchi
competono nel mantenimento posturale.
Si noti
anche ³l¹intreccio² delle origini del diaframma con il muscolo transversus
abdominis sulle parti cartilaginose delle sei coste inferiori e la fissazione
del diaframma al processo xifoideo.
P.S.: I
muscoli serrati posteriori fanno parte dell¹apparato che affranca il torace
alla spina dorsale e sono ³posturali². Il loro impiego come ³movimentali
respiratori² crea serie deformazioni sia spinali sia toracici.
2.1.3 Idee
su movimenti respiratori
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
2.1.3.1 Modelli
fisioterapeutici
2.1.3.1 Modelli
fisioterapeutici
La
classificazione della muscolatura respiratoria secondo gli abituali libri dei
fisioterapisti è ca. la seguente:
Muscoli
ispiratori:
-
Principali:
-
*Diaframma.
-
*Levatores costarum.
-
*Intercostales externi.
-
*Intercostales interni ventriculari.
-
Ausiliari:
- Scaleni.
-
Sternocleidomastoidei.
-
Trapezius.
- Serratus
anterior e posterior superior.
-
Pectoralis major e minor.
-
Latissimus dorsi.
- Estensori
della spina dorsale toracica.
-
Subclavius.
Muscoli
espiratori:
- Principali:
-
Addominali:
- Obliquus
internus e externus.
- Rectus
abdominis.
-
Transversus abdominis.
- Toracici:
-
Intercostales interni dorsales.
-
Transversus toracis.
-
Ausiliari:
-
Latissimus dorsi.
- Serratus
posterior inferior.
- Quadratus
lumborum.
-
Iliocostalis lumborum.
L¹elenco
rende forse l¹idea della complessità di movimento e forze/controforze
respiratorie ma è anche fonte di notevoli confusioni:
- *I
muscoli indicati con un asterisco sono gli unici muscoli di movimento in una
respirazione distesa ed efficace.
- Tutti gli
altri servono ³solo² come muscoli posturali ³ d¹affrancamento e seguono
³elasticamente² il movimento respiratorio toracico. In questo senso tutti i
muscoli dell¹organismo seguono il ritmo respiratorio in modo che:
- Aumentano
di tono in fase di ispirazione e trattenimento del fiato.
- Perdono
di tono in espirazione e durante la pausa respiratoria.
- Sforzando
la muscolatura ³posturale² respiratoria:
- ³Muscoli
ausiliari espiratori².
- ³Muscoli
ausiliari ispiratori².
Si impedisce
e col tempo si blocca il movimento fisiologico respiratorio primordiale: quello
del diaframma e della ³campana toracica².
-
Concentrarsi sulla muscolatura respiratoria è limitativo perché la ³guida del
respiro² nei tratti respiratori e ³la formazione del suono² sono altrettanto
importanti per il processo respiratorio.
Che proprio
la fisioterapia come grande arte terapeutica con accento sull¹apparato motorio
e i muscoli non faccia distinzione netta tra funzioni posturali, portanti,
tenenti e funzioni movimentali, per non parlare poi delle finezze di muscoli
ipercontratti e iperestesi e di variazione di tono, non m¹ispira una grande
fiducia in quanto concerne il loro lavoro terapeutico respiratorio.
Il NETTER
nel suo favoloso atlante d¹anatomia distingue in:
-
Muscolatura principale e accessoria d¹ispirazione ed espirazione ³calma² e
³attiva².
Il modello
mi sembra molto migliore di quelli confusionari fisioterapeutici, ma:
- Mi è
oscuro il senso dell¹espirazione ³attiva², che secondo me significa ³forzata².
Essendo
medico naturalista non riesco ad immaginarmi un campo d¹impiego previsto
dall¹inventore per dei giochetti d¹esercizio del genere. Saranno divertenti ma
non ³naturali² salvo forse in un attacco di starnuto o di tosse.
- È ambigua
la presentazione dell¹³ispirazione ausiliaria²: se è intesa come ³posturale, di
tenuta² mancano tanti altri muscoli con il medesimo compito, se è intesa come
³movimentale² è un¹abitudine deformante la postura e con altre del genere
farebbe buona figura solo in un libro di patologia respiratoria.
*PAROW,
Julius: Funktionelle Atmungstherapie; HAUG
*Dr. med.
Julius Parow studiò nel 1953 i principi anatomici-funzionali della
respirazione, basandosi prevalentemente su degli studi di malattie asmatiche.
Le sue
teorie vennero verificate nel 1958 dal reparto di ricerca polmonare della
clinica medica universitaria di Colonia e pubblicate nel 1959 e 1963. Nel 1966
ha trattato l¹evoluzione di deformazioni toraciche e la loro cura, tramite
degli esercizi della muscolatura toracica-costale.
Nell¹epilogo
alla quinta edizione 1988 scrisse:
³ la
delimitazione verso i diversi sistemi curativi respiratori è superflua:
- A coloro
che arricchivano i propri dogmi con della magia, la schiettezza scientifica e
le restrizioni della terapia respiratoria funzionale non saranno gradite
- Per chi
s¹impegna invece seriamente, la monografia fornisce le basi per conoscenze
esatte ed un lavoro sensato².
PAROW,
dapprima con l¹osservazione dell¹atto respiratorio ³naturale², forzato,
alterato e patologico, poi con lo studio di anatomia (costruzione) e fisiologia
(funzionamento) dell¹apparato respiratorio e infine con complicati esperimenti
e conferme per misurazioni ha sviluppato tra 1953 e 1963 un modello
respiratorio razionale, plausibile e applicabile.
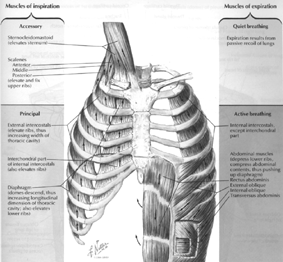
Eseguendo
regolarmente terapie corporee per le quali la conoscenza di movimenti e
tensioni respiratorie è elementare e non avendo trovato un testo sintetico sul
ramo mi sono deciso a trattare il tema in modo che possa essere usato come
strumento di studio a scopi pratici.
Per un atto
respiratorio ³economico² (massimo effetto a minimo sforzo) si capisce
intuitivamente che conviene:
-
Innanzitutto una perfetta collaborazione sincronizzata e tarata di forze e
movimenti.
-
Diaframmatici.
- Toracici.
- Contro le
forze elastiche centripete del tessuto connettivo e della muscolatura liscia
dei polmoni,
- e le
resistenze di flusso arioso in ambedue le direzioni (ispirazione ed
espirazione).
- Nei
tratti respiratori inferiori (bronchioli, bronchi, trachea)
- e
superiori (laringe con corde vocali, strette orofarigeali, deviazione
nasofaringeale, stretta nasale).
- Appese e
tenute dinamicamente (ma non mosse) dalla muscolatura di spalle, collo, cingolo
scapolo-clavicolare.
-
Compensate volumetricamente e tenute posturalmente (ma non ³rinforzate²) dalla
muscolatura ventro-lombale.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
2.2.1 Modello di
meccanica respiratoria
2.2.2 Ruolo dinamico
dei polmoni
2.2.5 Respirazione
nasale e orale
2.2.6 Squilibri e
superstizioni respiratori
2.2.1 Modello
di meccanica respiratoria
L¹unità
funzionale di movimento respiratorio si può immaginare come una ³doppia
campana² dove la campana diaframmatica è ³incastrata² nella campana toracica.
Contraendosi
(ispirazione):
- Il
diaframma si appiattisce e aumenta il volume toracico, mentre per la forza
esercitata sulla sua origine (tutto intorno all¹interno dell¹apertura toracica
inferiore) tende a chiudere quest¹ultima.
- La
muscolatura costale invece, contraendosi a sua volta, esercita controforze in
maniera che si apre anche la ³campana toracica² aumentando a sua volta il
volume toracico.
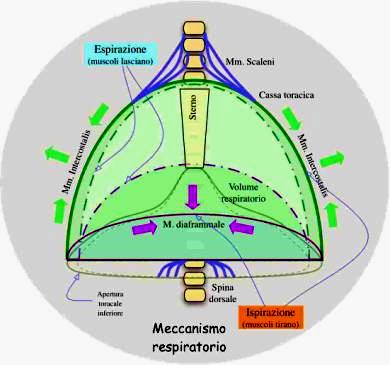
2.2.2 Il
ruolo dinamico dei polmoni
L¹idea
vigente è che i polmoni abbiano un ruolo completamente passivo nel movimento
respiratorio. Questa immagine è limitativa, come dimostra bene la patologia del
pneumotorace: i polmoni implodono quando vengono a mancare le controforze
esterne (toraciche e diaframmali) che, tramite la pleura, li dilata contro la
loro elasticità interna. Esercitano una forza elastica continua contro le forze
muscolari centrifughe di torace e diaframma.
In più pare
anche (come dimostrano delle radiografie durante delle fonazioni) che la loro
muscolatura liscia intrinseca sia capace di aumentare questa forza elastica
centripeta capace di formare dei suoni, in contrasto con una respirazione
afonica.
L¹aumento
volumetrico toracico in ispirazione avviene:
- Tramite
la forza adesiva della pleura che viene trasmessa ai polmoni che ³di natura²
con la loro elasticità tessutale tendono a ³implodere² (come si vede nella
patologia del pneumotorace).
- La forza
espansiva del torace, essendo più forte della tendenza contrattiva dei polmoni
li espande, tirando al loro interno dell¹aria proveniente dai bronchi, trachea
e vie respiratorie superiori (faringe, laringe naso e bocca).
- Il flusso
di aria nei ristretti canali respiratori per meccanismi di ³attritto di flusso²
oppongono un¹ulteriore resistenza alle forze toracico-diaframmali
dell¹ispirazione.
La
diminuzione volumetrica toracica in espirazione avviene semplicemente:
- Per
rilasciamento muscolare toracico-diaframmale.
- In
quanto, le forze contrattive (elastiche tessutali polmonari) opposte riportano
torace e diaframma nella loro posizione ³distesa².
- Che
questo non avvenga ³a scatto² è impedito dalla ³resistenza di flusso² dell¹aria
uscente nei ristretti canali respiratori.
2.2.5 Respirazione
nasale e orale
Durante la
respirazione nasale, la lingua chiude la buca orale verso i tratti respiratori
nasali appoggiandosi sul palato molle all¹altezza delle tonsille palatine.
Quando la lingua si stacca, la respirazione diventa orale perché la resistenza
al flusso arioso della stretta nasale è maggiore di quella della buca orale.
È quindi
più economica la respirazione orale (stesso effetto con meno sforzo) come lo
dimostrano gli esempi di sforzi fisici o di persone con tratti respiratori
inferiori ostrutti o spastici (asma). Come abitudine, nelle persone sane e a lungo
andare non è comunque conveniente, perché si atrofizza leggermente la
muscolatura movimentale e con questo la capacità respiratoria. Di solito questa
raccomandazione si motiva con la funzione del naso di scaldare e umidificare
l¹aria ispirata e il deposito di particelle sulle mucose nasali (bella
consolazione per chi soffre di sinusite cronica!).
2.2.6 Squilibri
e superstizioni respiratori
Nel lavoro
sul corpo si notano spesso squilibri tra capacità diframmatiche e toraciche:
- Se il
diaframma è più potente del torace: restrizione dell¹apertura toracica
inferiore.
- Se la
muscolatura toracica è più potente della diaframmale: apertura toracica
inferiore ³ad ala².
In più le
capacità dei vari gruppi muscolari toracici sono molto diverse tra di loro. Si
trovano ³disinseriti², spastici, sovraespansi, superattivi e passivi con
relative deformazioni del tessuto connettivo circostante e tipiche irregolarità
di movimento e forma su tutta la superficie toracica, indotte da traumi,
abitudini, protezione da disturbi, disagi, dolori . ³Gobbo cardiaco e gastrico²
sono solo due esempi di adattamento toracico a condizioni organiche.
Lo stesso
vale per fasce di fibre muscolari del diaframma dove spesso si notano rilevanti
differenze tra destra e sinistra, posteriore e anteriore, deducibili da
movimenti e tensioni lungo il percorso dell¹origine del diaframma:
- Processo
xifoideo.
- Porzione
cartilaginosa dalla settima costa in giù.
- Punta
della 12a costa.
- Processo
trasversale della vertebra L2.
- Vertebre
L2 L4.
Altri
squilibri, spesso combinati con i sovramenzionati, concernono l¹impiego della
cosiddetta ³muscolatura respiratoria ausiliaria²:
-
Muscolatura di portamento di spalle e collo e cingolo scapolo-clavicolare:
viene utilizzata per movimenti longitudinali toracici respiratori con l¹effetto
che si atrofizzano e disinseriscono le toraciche superiori.
-
Muscolatura di portamento e sostegno toracico-lombare: viene utilizzata per
movimenti longitudinali o trasversali oltre alle necessità di spostamento
volumetrico intestinale con vari effetti sul funzionamento
toracico-diaframmale.
Si noti in
questo contesto che, contro la convinzione della maggioranza dei terapisti e
professori del ramo, non è coinvolto alcun movimento longitudinale del torace
(in una respirazione ³naturale², economica, non forzata) come si può osservare
benissimo nella respirazione delle bestie e dei piccoli bambini e come lo
confermano le verifiche e misurazioni di laboratorio del PAROW. L¹unico
movimento longitudinale a questo punto è quello diframmale. Solo questo fatto
dimostra l¹assurdità di tante superstizioni e raccomandazioni di apostoli del
³respiro giusto², ³respiro profondo², ³respiro ventrale², e così via.
2.3 Portamento
e respirazione ³ordinaria²
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
2.3.1 Coinvolgimento
della ³muscolatura ausiliaria²
2.3.3 Lavoro
corporeo posturale respiratorio
2.3.1 Coinvolgimento
della ³muscolatura ausiliaria²
Il
movimento toracico-diaframmale come sopra descritto ha degli effetti
³collaterali² che incidono notevolmente sulla postura o all¹inverso la postura
induce caratteristiche respiratorie:
- L¹appiattimento
del diaframma in ispirazione guadagna volume toracico a scapito del volume
addominale che effettua movimenti e forze di compensazione specialmente della
muscolatura lombo-addominale verso il bacino; in espirazione gli effetti si
capovolgono e tornano ³in distesa².
- La
sospensione della doppia campana respiratoria.
- Del
diaframma a: spina dorsale lombare, proc. xifoideo dello sterno, parti
cartilaginose delle sei coste inferiori.
- Del
torace a: spina dorsale, muscolatura nuca-collare, muscolatura lombo-addominale
in ispirazione trasmette ed esercita delle forze notevoli sulla spina dorsale,
la testa, il cingolo scapolo-clavicolare e il bacino che devono essere
compensate ³posturalmente² e effettuano così anche movimenti compensatori; in
espirazione gli effetti si capovolgono e tornano ³in distesa².
- Più in là
e per compensazione tutte queste forze e micromovimenti si propagano anche
nelle estremità in modo, che un attento tocco ovunque sul corpo sano rivela dei
micromovimenti nel ritmo del respiro, un continuo aumento di tono tessutale in
ispirazione e di rilascio in espirazione.
La
cosiddetta ³muscolatura respiratoria ausiliaria² idealmente non crea una
respirazione ausiliaria, ma compensa in modo geniale ed economico il movimento
respiratorio toracodiaframmale in modo da adattare la postura alle condizioni
volumetriche e tensionali in ispirazione per tornare in espirazione allo stato
distensivo. A me sembra un sacrilegio voler impiegare questi muscoli ³per
sostenere, migliorare, facilitare, aiutare, ...² la respirazione (come se
l¹inventore avesse sbagliato il concetto) e terapeuticamente perverso cercare
di sviluppare i muscoli chiamati ³ausiliari² invece di ripristinare le capacità
principali e di, eventualmente, adattare ad esse l¹attività dei muscoli
posturali.
Di seguito
lo schizzo del PAROW in merito con il suo commento:
-
Inspirazione: ampliamento del volume toracico tramite tensione e abbassamento
del diaframma e allargamento dell¹apertura toracica inferiore.
-
Espirazione: contrazione polmonare (per elasticità polmonare) con rialzo del
diaframma e restrizione dell¹apertura toracica inferiore per via della
muscolatura lombo-addominale.
Qui non
sono d¹accordo con PAROW, perché semplicemente e passivamente gli organi
addominali tornano nello spazio liberato dal diaframma. La muscolatura
addominale può anche perdere di tono, basta che mantenga la postura in
equilibrio con quella lombare.
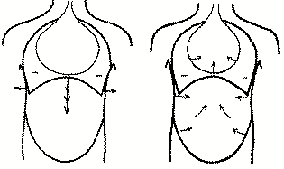
PAROW
mostra nello schizzo seguente un esempio divulgato d¹interdipendenza posturale-
respiratoria. Si noti:
- La
depressione toracica superiore-anteriore e in compenso la lordosi cervicale con
tenuta ³a tartaruga² della testa e la cifosi della spina toracica, immaginabile
la distorsione del cingolo scapolo-clavicolare in avanti con relativa tenuta
bracciale poco economica.
- La
restrizione lombolaterale (distanza torace-bacino) con lordosi lombare e tenuta
³a oca² del bacino e in compenso la muscolatura ventrale (Mm. transversus,
rectus, obliqui) iperestesa; immaginabile la tenuta di cosce e gambe poco
economica.
Il commento
del PAROW:
Portamento
spina dorsale, torace, ventre e cingolo pelvico.
a) Normale:
postura e tensione longitudinale intatta.
b)
Difettoso: postura e tensione longitudinale lesa.
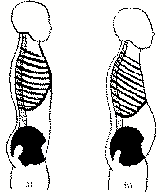
2.3.3 Lavoro
corporeo posturale respiratorio
Questi casi
richiedono dei lunghi lavori corporei posturali sia da parte del terapista sia
da parte del cliente, che consistono soprattutto nel:
-
Ripristinare un adeguato tono muscolare longitudinale, equilibrato tra
l¹anteriore iperesteso e il posteriore ipercontratto.
- Apertura
toracica superiore anteriore con elevazione dello sterno e distorsione
posteriore del cingolo scapolo-clavicolare.
-
Liberazione delle vie respiratorie inferiori e superiori.
-
Riequilibrio della posizione relativa tra torace e cingolo pelvico.
- Riattamento
delle articolazioni superiori e inferiori alle ripristinate condizioni di
tronco, testa e cingoli.
I
sopraelencati lavori non rispecchiano una sequenza operativa, si lavora di
solito durante un trattamento su tutte le funzioni anche se spesso una di loro
determina l¹accento lavorativo.
Da notare
anche che il lavoro posturale non è mai forzato, ma propone al corpo solo delle
alternative al portamento attuale che il corpo deve realizzare poi e da solo
tra le sedute. Anche la ³collaborazione imposta² dal cliente di solito
danneggia, perché ripete negli esercizi fisici vecchie abitudini. Può però
partecipare con pochissimi esercizi ben scelti di voce e respiro a crearsi
nuove abitudini.
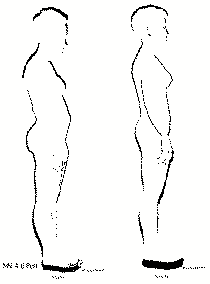
prima dopo
2.4 Respirazione
durante sforzi fisici
Come
esempio di respirazione sotto sforzo, il PAROW scelse un dipinto dell¹antica
Grecia e lo commentò come segue:
Respirazione
di corridori:
a) Espirato,
ventre represso.
b e c) Inspirato,
ventre sporgente.
Portamento
e posizione toracica invariata corrispondente a una respirazione ³normale².
PAROW sostiene che una respirazione ³forzata² non abbia dei movimenti concettualmente diversi da una respirazione distesa (che lui chiama ³normale²) a eccezione che a un certo punto la respirazione diventa ³orale².

a b
c
La funzione
della respirazione è lo scambio di gas necessario per il metabolismo energetico
dell¹organismo. Una bella parte della necessaria energia viene usata per il
lavoro respiratorio. L¹impiego economico della muscolatura respiratoria è quindi
primordiale per il rendimento respiratorio.
PAROW ha
dimostrato, e misurato in un suo studio, che l¹impiego della muscolatura
ausiliaria per il movimento respiratorio è assolutamente inefficace in quanto
richiede ca. il 30% in più d¹aria per gli stessi compiti ³non-respiratori².
Questo significa anche che dei criteri come volume respiratorio o estensione
toracica dicono poco sul rendimento respiratorio che è l¹unico criterio
razionale per valutarli.
2.6 Forma
respiratoria e scambio di gas
Lo scambio
di gas tra polmoni e sangue dipende principalmente:
- Dalla
superficie respiratoria: che evidentemente è maggiore a torace aperto e
diminuisce con la chiusura toracica come p.es. nell¹espirazione forzata).
- Dalla
microcircolazione, che a sua volta dipende dalla pressione all¹interno del
polmone in quanto:
- una
sovrapressione, come p.es. in espirazione forzata o peggio ancora pressata,
³schiaccia² i capillari e diminuisce la circolazione e quindi lo scambio di
gas;
- mentre
una leggera sottopressione (come p.es. la formazione di un tono) li apre,
aumenta la circolazione e quindi lo scambio di gas. È noto p.es. che cantando
si usa meno aria del solito, malgrado lo sforzo. Anche la pausa respiratoria
dopo un¹espirazione (non forzata) a torace aperto sostiene lo scambio perché la
superficie è grande e la pressione zero.
L¹idea che
un movimento respiratorio esteso possa migliorare in modo rilevante lo scambio
di gas è erronea perché:
- Il
paragone tra scambio di aria e volume polmonare insegna che nelle parti
inferiori delle vie respiratorie lo scambio non avviene per ventilazione, ma
per diffusione di gas. Negli alveoli l¹aria è pressoché stagnante.
- La
compressione toracica, in espirazione estesa, diminuisce a lunghe tratte la
superficie di scambio.
- La sovrapressione
dell¹espirazione estesa negli alveoli diminuisce il diametro dei capillari e
quindi lo scambio.
In
respirazione normale e distesa, la stretta del naso e la deviazione sulla
cupola della gola:
-
esercitano una resistenza nel flusso respiratorio opposta alle forze polmonari
e
- formano
il flusso arioso in modo che diventi laminare (senza vortici).
La
resistenza ³antagonista² è importante per il continuo esercizio del diaframma.
Una respirazione abituale con la bocca, pone molto meno resistenza al flusso
respiratorio ed è spesso esercitata da persone a respiro debole. L¹abitudine
indebolisce a lungo andare il muscolo diaframmatico e i toracici coinvolti.
La stretta
nasale (il passaggio delle ali nasali all¹osso nasale), oltre alle funzioni di
resistenza e formazione laminare del getto arioso, ha anche importanti funzioni
olfattive (annusare, fiutare). Nella polmonite e nella nefrite si nota il
tipico sintomo delle ali nasali aperte, una misura dell¹organismo per diminuire
la resistenza alle forze diaframmatiche e per ridurre il dolore. Una
muscolatura facciale mimica tesa deforma spesso la stretta nasale; fa parte di
terapie respiratorie da correggere, in un primo momento, è spesso utile tirare
leggermente la punta del naso.
I portatori
di occhiali respirano spesso con la bocca, perché gli occhiali che appoggiano
malamente sulla stretta nasale aumentano troppo la resistenza.
Sul mercato
esistono dei cerotti che aprono la stretta nasale, vengono applicati da
russatori e sportivi per evidenti motivi.
Una
scorretta formazione del flusso arioso o per via di respirazione boccale o per
posizione della cupola della gola muscolarmente tesa, lo rende turbulento e
irrita spesso le corde vocali.
Nello
schizzo, PAROW commenta: ³Naso come ³antagonista² della muscolatura
inspiratoria (diaframma, muscoli toracici) e della forza espiratoria del
polmone.²
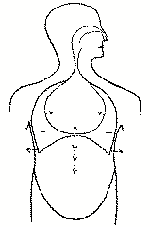
Da quando
ci passò l¹impulso di ridere e di cantare, aumentarono gli enfisemi polmonari e
l¹asma bronchiale (PAROW).
In una
terapia respiratoria non devono mancare la risata (il ballo del respiro) né il
canto (la sua ginnastica). Gli operatori del ramo dovrebbero quindi avere delle
relative conoscenze che sono reperibili meglio da attori e cantanti che da
medici e insegnanti di Yoga. Da parte mia, mi sono occupato di sintetizzare gli
elementi teorici.
Il suono
come espressione sociale umana nel linguaggio e nel canto coinvolge l¹apparato
motorio respiratorio in tutte le sue sfumature. Diagnosticamente l¹intenditore
riesce a dedurre parecchio in merito, ascoltando attentamente una persona
parlare, concentrandosi sul suono e non sul contenuto di quello che dice.
Il suono
viene formato dalle corde vocali (nella laringe) che dal flusso d¹aria vengono
fatte vibrare. L¹acutezza del suono è determinata dalla loro lunghezza e
tensione, il volume ³emesso² in parte dal volume di aria che passa attraverso
le corde e in gran parte dalla risonanza diaframmale e nelle cavità delle vie
respiratorie sovrastanti alle corde vocali; cavità faringeale, nasale e
boccale, e le loro relative tensioni muscolari parietali e apertura della
mandibola, formano, in parte, il volume e le vocali con i loro timbri.
L¹articolazione è fatta di movimenti e posizioni di labbra e lingua verso
denti, gengive, palato duro e molle, e faringe.
Durante
questo processo devono collaborare in modo coordinato ma indipendente uno
dall¹altro:
- Il
deflusso respiratorio in equilibrio tra forze elastiche del polmone e
muscolatura respiratoria principale e ausiliaria.
- La
fonizzazione tramite le corde vocali (acutezza e intensità).
- La
sonorizzazione per risonanza nelle cavità laringeali/faringeali.
- La
vocalizzazione/articolazione di vocali/consonanti tramite il gioco di lingua,
labbra, denti, gengive, palato duro e molle, formando la cavità boccale in
collaborazione con la posizione della mandibola e della cavità nasale
parzialmente formabile dalla muscolatura mimica.
Sono
evidenti le correlazioni tra questi quattro gruppi funzionali sonori di
collaborazione e di coordinazione in maggior parte automatici sui diversi
livelli:
-
Riflessivi come sbadiglio, starnuto, sospiro, gemito, sorriso.
- Formati
in prima infanzia come lingua e vocalizzazione.
- Formati
in discipline vocali come attori, cantanti, strumentisti a fiato.
-
Accidentali per traumi fisici o psichici o frustrazioni/gratificazioni (taglia
il fiato, fa male, non osi alzare la voce, ).
-
Abitudinali per ruolo, rango, professione (ufficiale, prete, insegnante,
venditore, ).
- Deformati
per autoimmagini e ideologie (una vera femmina respira col ventre, il maschio
galletto a petto alzato, ).
Dagli esempi
risulta intuitivamente che oltre a disfunzioni e patologie dei quattro gruppi
funzionali (respirazione, fonazione, sonorizzazione e vocalizzazione) anche la
loro collaborazione e la coordinazione è impedita, soprattutto per motivi di
socializzazione. Ma questo significa anche una fortuna terapeutica perché
permette la terapia di disfunzioni respiratorie/vocali con ca. il seguente
concetto:
- Tornando
alle basi di riflessi sonori e di formazione vocale infantile con relativi
esercizi si riesce spesso a riattivare ³vecchi programmi cerebrali² più potenti
delle convenzioni sociali mentre,
- traumi
subiti, frustrazioni e deformazioni organiche sono normalmente accessibili a un
cauto e sensato lavoro corporeo da parte del terapista.
- La parola
in questo contesto serve per motivare sempre di nuovo il cliente a proseguire
il suo viaggio verso una respirazione più economica, ma è assolutamente
antiterapeutico suggerirgli di controllare coscientemente il suo respiro o la
sua voce: è stata proprio questa illusione che spesso l¹ha portato al suo
disagio.
Le
patologie respiratorie come enfisemi polmonari, bronchite cronica,
bronchiestasie, silicosi, interventi toracici, malattie pleuriche, asma
bronchiale, deformazioni toraciche, certe malattie nasali, circolazione, addominali,
sindrome del Roemheld sono trattabili con gli stessi principi terapeutici
almeno con scopi palliativi o ³frenanti² con la differenza che sono da
aggiungere eventualmente dei rimedi e/o delle misure comportamentali e
dietetiche specifiche.
Vengono
trattati i seguenti temi:
2.8.1 Regolazione
respiratoria nel suono
2.8.2 Tratti
superiori respiratori
2.8.3 Fonazione e
laringe/corde vocali
2.8.4 Sonorizzazione
e faringe
2.8.5 Vocalizzazione/articolazione
2.8.1 Regolazione
respiratoria nel suono
Il
controllo respiratorio durante la fonazione è diverso dalla respirazione
³afonica²:
- Minimo,
costante e lento deflusso arioso regolato dalla forza elastica polmonare.
- Il
diaframma ³accompagna² il movimento polmonare, compensando la deviazione
volumetrica toracica per controllato cedimento ³teso² mentre,
- la
muscolatura toracica mantiene la tensione trasversale e diaframmatica.
- La
porzione alta (ca. le prime sei coste) mantiene l¹apertura e la tensione
trasversale a sterno rialzato.
- La
porzione bassa (attaccamento del diaframma) all¹inizio del suono sembra quasi
un po¹ alato mentre a suono trascorso si chiude leggermente (per compensazione
volumetrica), ma mantiene la tensione per non lasciar diventare flaccido il
diaframma.
- La
muscolatura lombo-addominale compensa la deviazione volumetrica addominale e
affranca l¹equilibrio di forze tra diaframma e torace. La muscolatura, tenendo
una certa tensione, segue la diminuzione del volume addominale (a spese di
quello toracico).
L¹ispirazione
durante il canto o la recitazione è orale, ³a scatto² e brevissima come si nota
anche nelle persone con logorrea (che chiacchierano senza apparentemente
prendere mai fiato).
Il PAROW
commenta il suo schizzo: ³Il suono². Dinamica della regolazione di aria e
pressione. Tensione di tutta la muscolatura respiratoria (sostegno del suono).
Coordinazione dei polmoni e intercapedine vocale.²
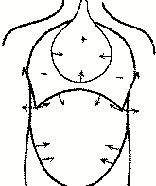
2.8.2 Tratti
superiori respiratori
Il dipinto
di NETTER mostra i tratti superiori in dettaglio: a lingua distesa la
respirazione è orale. Immaginandosi appoggiata la lingua contro il palato molle
si può intuire il flusso arioso con la resistenza della stretta nasale alla
deviazione naso-faringeale ... orofaringeale fino alla laringe con l¹apparato
vocale.
2.8.3 Fonazione
e laringe/corde vocali
Le corde
vocali sono azionate e tese da otto paia e un singolo muscolo durante la
fonazione. L¹avvicinamento delle corde vocali le fa vibrare nel flusso arioso
che trapassa, la loro lunghezza e tensione altera la frequenza di vibrazione e
quindi l¹acutezza del suono, la forza ariosa determina assieme con l¹ampiezza
dell¹intercapedine l¹intensità (amplitudo) dell¹oscillazione e quindi
l¹intensità del suono.
Come
dimostra la voce di bravi cantanti, un suono curato richiede pochissima aria
perché può essere tenuto molto a lungo. Infatti anche la fisica ci insegna che
il mantenimento di un¹oscillazione in corso richiede poca energia in confronto
all¹attacco.
Non viene a
mancare l¹aria emettendo un suono anche a lungo tempo, perché a torace aperto e
quindi superficie polmonare grande funziona benissimo lo scambio di gas nei
polmoni anche in fase di espirazione.
Durante la
normale respirazione afonica i muscoli intrinsechi laringeali sono distesi e
l¹intercapedine vocale è aperta.
2.8.4 Sonorizzazione
e faringe
La faringe
e in parte la laringe, per meccanismi di risonanza, ³amplificano² e formano il
suono dandogli i suoi molteplici timbri variabili e caratteristici; all¹incirca
come la cassa di risonanza di un violino, non solo amplifica la vibrazione
della corda trasmessa dal ponticello, ma aggiunge anche delle ³armoniche²
(multipli della vibrazione basale) composte in un determinato modo. A
differenza del corpo sonoro di un qualsiasi strumento musicale relativamente
fisso, le condizioni risonative del costrutto laringe/faringe, sono ampiamente
variabili nella dimensione, forma e tensione tramite una complessa muscolatura
coinvolta. Per chi intende approfondire questo tema, consiglio lo studio del
NETTER ed esperimenti con la propria voce.
Come guida
di relativo studio in breve il seguente:
Laringe,
osso ioideo e lingua, sono una costruzione altamente complessa, appesa al
cranio e alla mandibola, intelaiata verso lo sterno e le spalle e connessa con
la faringe.
Alla
laringe è appesa caudalmente la trachea e, come a un breve tubo, bronchi e
polmoni. All¹interno della laringe si trova l¹apparato di fonazione appena
descritto. Tramite l¹osso ioideo, la laringe è longitudinalmente spostabile,
prevalentemente per funzioni di deglutizione, ma anche per motivi di fonazione
e vocalizzazione. Posteriormente è intelaiata verso la faringe.
La faringe
(oro- e nasofaringe) è una cavità bislunga estesa posteriormente a laringe,
cavità orale e cavità nasale. In direzione ventrale è più aperta, in basso
all¹altezza dell¹epiglottide verso la laringe, sopra si estende verso la cavità
boccale e in alto con il suo ³tetto² verso la cavità nasale. Le sue pareti sono
formate da fasce muscolari toroidali e leggermente oblique in modo che la
faringe diventi restringibile, raccorciabile e spostabile nonché adattabile di
tensione parietale. Tutto questo, fra l¹altro, per impostare le più svariate
condizioni di risonanza per le espressioni vocali e la formazione dei ³getti²
d¹aria ispirati ed espirati. I muscoli faringeali sono appesi alla base del
cranio, mascella e mandibola e intelaiati con la lingua posteriore, la laringe
e l¹osso ioideo, in maniera che sono in grado di collaborare miracolosamente
nella formazione dei timbri della voce umana.
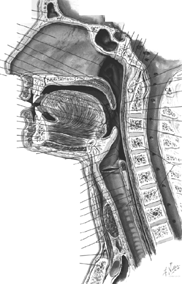
2.8.5 Vocalizzazione/articolazione
Il suono:
- Generato
dalle corde vocali per frizione del flusso arioso e
- formato
dalla risonanza faringeale a un determinato timbro,
- raggiunge
sottoforma di vibrazione d¹aria,
- le cavità
nasali (tramite la nasofaringe) e
- la cavità
orale (tramite l¹orofaringe),
-
direzionato dalla ³spalla linguale² più verso l¹una o l¹altra.
Le cavità
nasali e boccali ³amplificano² e formano ulteriormente il suono e lo
³strutturano², trasformandolo in voce umana:
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
2.8.5.1 Cavità
nasale, muscolatura mimica
2.8.5.2 Cavità
boccale, lingua, labbra, mandibola
2.8.5.1 Cavità
nasale, muscolatura mimica
La cavità
nasale è impiegata:
- Nella
formazione di fonemi nasali frequenti in lingue come il francese. Questo
avviene quando il collo della lingua chiude parzialmente l¹orofaringe e la
vibrazione sonora viene trasformata maggiormente dalla cavità nasale.
- È però
anche caratteristica nella voce di persone che abitualmente tengono alta la
spalla della lingua o tengono la bocca poco aperta per ipertensione della
muscolatura mascello-mandibolare. Tutte e due queste abitudini spesso sono
legate a stati emotivi caratteristici.
- Il
contrario avviene a naso tappato che disinserisce la risonanza nasale o in casi
di sinusite o polipi nasali che diminuiscono il volume della cavità nasale e
dimostrano che influsso può avere la risonanza nasale sulla caratteristica
vocale di una persona.
A prima
vista si direbbe che la cavità nasale non è formabile salvo che
chirurgicamente.
Ma non è
così: la muscolatura mimica influisce notevolmente e non solo sull¹ampiezza
della stretta nasale. Sembra strano, ma fa parte di una terapia manuale
respiratoria, di allentare la muscolatura mimica e ³sfilacciare² la punta del
naso.
2.8.5.2 Cavità
boccale, lingua, labbra, mandibola
L¹ampiezza
della cavità boccale è regolabile in larga misura dall¹apertura della mandibola
e dalla posizione e formazione della lingua.
La
mandibola si apre, quando si distende la muscolatura di masticazione. Stringere
i denti non è altro che ipertensione della muscolatura di masticazione, spesso
legata a caratteristici stati d¹animo. L¹apertura della bocca durante il canto
o la recitazione aumenta il volume della voce come lo fa un megafono.
La
collaborazione delle labbra, guance (muscolatura mimica) e della lingua
permette una quantità di forme della buca orale usata a generare le vocali
(vocalizzazione). Le principali vocali, mal rappresentate con le lettere:
- a, ä, è,
e, é, i, o, ö, u, ü,
(perché
nelle lingue parlate ci sono innumerevoli sfumature e nelle persone parlanti
ancora più caratteristiche).
L¹ingegnosa
collaborazione delle labbra, dei denti, della lingua, del palato duro, palato
molle, ulula e le strette naso- e orofaringeali genera le consonanti che, in
alternanza con delle vocali, creano delle interminabili sequenze di fonemi e
sillabe che chiamiamo canto, linguaggio, recitazione,

Riconosciamo
minime sfumature di formazione di consonanti, nelle lingue a noi più vicine:
- Esplosivi
acuti o addolciti come p, b, t., d, g, q (palatale o gutturale).
-
Frizionanti come v, f, s, sc.
- Combinati
esplosivi/frizionanti come pf, ts, c, ch, kh , qh, x, z (palatale o gutturale).
- Aspirati
come h (palatale o gutturale).
- Vibrati
come r (molle o gutturale).
-
³Suonanti² come l, m, n, w.
-
³Attacchi² per i quali nelle nostre lingue non abbiamo annotazioni ma sono
importanti p.es. nelle lingue semite.
Le lettere
usate per indicare le consonanti sono ancora più imprecise che quelle delle
vocali, perché la loro pronuncia dipende della lingua usata. A chi intende
farsi una cultura sui fonemi, consiglio lo studio del sanscrito con un bravo
maestro tradizionale, perché insegnano i fonemi in modo sistematico anche se
non completo.
Riconosciamo
delle sequenze fonemiche caratteristiche della specie umana nel balbettare di
un cosacco ubriaco come nell¹arte di una cantante lirica cinese, nel ricordo
dei sussurri della mamma ansiosa e delle grida di un papà arrabbiato, nella
retorica del politico come nella logorrea disinvolta di una paziente maniacale,
nel dolore di chi porta un lutto come nelle intimità verbali di una persona
amata.
È un
peccato terapeutico primordiale dedicare più attenzione, cura e riflessioni al
significato delle parole di un cliente che alla sua voce umana che ci insegna
tanto delle sue virtù e debolezze, delle sue glorie e ansie, delle sue paure e
speranze e che ci indica spesso direttamente l¹approccio terapeutico corporeo.
Come si fa?
Ascoltare attentamente e pazientemente per un po¹ di tempo la voce del cliente
come se parlasse il cinese, quindi senza registrare quello che dice.
2.9 Ginnastica
naturale respiratoria
La
ginnastica naturale del respiro consiste in particolare nel non sopprimere le
pulsazioni vegetative ed emotive che coinvolgono l¹apparato respiratorio e
sonoro. Si può anche abituarsi a provocarle ed eseguirle volutamente, il che è
non solo efficace ma anche più soddisfacente degli esercizi ³imposti².
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
Tensione
dell¹apparato respiratorio come per qualsiasi suono con leggero arresto, corde
vocali aperte o pressoché chiuse ma non tirate. Lasciare il respiro come in un
sussurro ma a torace aperto.
Serve alla
dilatazione dell¹apparato toracico per normalizzare le sue tensioni interne.
Espirazione
veloce e intensa per naso o per bocca a gola aperta e senza restringere il
petto.
Serve a
scaricare la muscolatura respiratoria e i polmoni quando involontariamente la
pressione pettorale è aumentata e strapazza polmoni e circolazione.
Combinazione
di gemito, leggero arresto respiratorio e sospiro:
-
Ispirazione relativamente profonda con una piccola resistenza nella faringe
come ³ch².
- Tensione
massima della muscolatura respiratoria con arresto respiratorio senza pressione
(anche i polmoni vanno in tensione come prima di un suono).
-
Espirazione con un sospiro con distensione toracica e diaframmale alla fine.
È un vero
stiramento di tutto l¹apparato respiratorio per riattivare la muscolatura e la
circolazione.
Il sorriso
è il rapido alternare tra suono ed espirazione, tra tensione e rilascio. Come
il canto è la ginnastica della respirazione, il sorriso è il suo ballo per
tenerla elastica. Il suono si sente come in una buona vocalizzazione in alto
della faringe.
Espirazione
controllata e lenta con posizioni toraciche come nel canto. Immaginarsi di
usare solamente ³l¹aria nella testa² e mantenere la tensione trasversale
toracica con sterno rialzato. Ottimo esercizio per la muscolatura toracica.
Suonare il flauto dolce o quello traverso ha simili effetti respiratori.
Ispirazione
forzata con susseguente espirazione forzata diaframmale a scatto e tratti
respiratori superiori contratti. Solo dopo si distende anche il torace. Molto
liberatorio per un diaframma impedito, ma non consigliabile in caso di
patologie polmonari (sovrapressione) o cardiache (botta circolatoria). Come
pulsione vegetativa serve a pulire le mucose dei tratti superiori respiratori
con un deciso getto d¹aria.
Espirazione
forzata diaframmale/toracica a scatto con tratti respiratori inferiori
contratti.
Come
pulsione vegetativa serve a pulire le mucose dei tratti inferiori respiratori
con un deciso getto d¹aria. Non consigliabile come esercizio a causa di inutile
sovrapressione polmonare e botta circolatoria. Frequente tosse ³pressata² e la
susseguente disfunzione respiratoria è una delle maggiori cause della
dilatazione polmonare (enfisemi).
3.0 Respirazione
disfunzionale
La foto
mostra una accentuata respirazione disfunzionale che si incontra frequentemente
e si chiama per sbaglio spesso ³respirazione profonda².

Vengono
trattati i seguenti temi:
3.1 Errori
movimentali del tronco
3.3 Errori
movimentali addominali
3.4 Errori movimentali
polmonari
3.5 Errori di
regolazione respiratoria
3.6 Cause per la
respirazione disfunzionale
3.7 Sviluppo della
respirazione disfunzionale
3.1 Errori
movimentali del tronco
Cominciano
con la mancanza di tensione trasversale del torace che impedisce l¹efficacia
del movimento diaframmale e la capacità respiratoria. L¹organismo tenta di
compensarla impiegando:
- La
muscolatura del cingolo scapolo-clavicolare.
- La
muscolatura posturale collare.
- La
muscolatura posturale dorsale.
Tirando il
torace in direzione craniale in ispirazione.
Comincia
con l¹impiego del M. pectoralis minor, si propaga per M. pectoralis major,
muscoli delle spalle e della nuca e il serratus post. sup. e coinvolge presto
anche la spina toracica che si erige in inspirazione (alza le coste davanti)
come i pettorali la tirano in direzione del cranio.
L¹espirazione
consiste nel lasciar cadere o tirare giù il torace in avanti tramite
l¹arrotondamento della spina toracica ed eventualmente la muscolatura
addominale.
Già
l¹inizio di questa disfunzione si riconosce bene per un movimento verticale
delle clavicole verso il cranio in inspirazione. Più tardi si nota anche
l¹elevazione dello sterno e delle spalle.
Questo tipo
di respirazione disfunzionale è molto divulgato senza apparenti svantaggi o
disagi, come in altri contesti si incontrano tanti deboli di piedi e di spina
dorsale.
movimento respiratorio movimento
respiratorio
toracico normale; toracico
disfunzionale
........... inspirazione _________
espirazione

Spesso
l¹impedimento diaframmatico è una diretta conseguenza della disfunzione
respiratoria toracica; il rialzo dell¹origine del diaframma agisce in direzione
opposta al movimento longitudinale del diaframma e diminuisce l¹estensione
longitudinale dei polmoni. In terapia si parla spesso di diaframma rialzato o
represso senza specificare e differenziare ulteriormente.
Bisogna
invece farlo, perché l¹approccio terapeutico è diverso per i vari casi di
dislocazione, disestensione e distonia.
Dislocazione
Si può
riferire alla posizione del diaframma nel tronco ed è rialzato quando il torace
è rialzato per la muscolatura cranio-spinale ipercontratta con una muscolatura
lombo-addominale iperestesa mentre è abbassato per lo squilibrio opposto. Si
tratta di una dislocazione diaframmale. L¹approccio terapeutico in questi casi
sarà prevalentemente di tipo ³posturale² e movimentale-respiratorio.
Disestensione
Si può
riferire alla differenza d¹inarcamento della cupola diaframmale in espirazione
e inspirazione e quindi all¹ipo- o iperestensione verticale diaframmale durante
la respirazione. Tutte e due le disestensioni possono essere combinate con le
due dislocazioni di prima. L¹approccio terapeutico in questo caso sarà
prevalentemente ³respiratorio².
Distonia
Si può
intendere nel senso di ³tono² (tensione) diaframmale tra ispirazione ed
espirazione e può diventare ipotonico (ptosi diaframmale con cupola abbassata
spesso nel seno di una ptosi generale) oppure la cupola può essere elevata per
organi addominali gonfiati (come stomaco pieno o eccessi di gas intestinali).
Anche queste due forme si trovano combinate con le variazioni delle disfunzioni
sopra menzionate. L¹approccio terapeutico sarà in questo caso prevalentemente
sistemico (si lavora sulle cause).
3.3 Errori
movimentali addominali
La
muscolatura ³tubolare² lombo-addominale deve compensare il cambiamento
volumetrico addominale durante la respirazione. Si riconoscono meglio squilibri
del genere in espirazione quando il cedimento ³soffice² della parete ventrale
termina prima della fase di espirazione (o manca completamente). In stadi
avanzati il movimento della parete ventrale può persino capovolgersi in un
movimento ventrale ³paradossale², frutto di eccessiva compensazione spinale di
movimenti respiratori primari. Anche i fianchi non seguono più il movimento
respiratorio.
La parete
ventrale può diventare parecchio tesa in espirazione nel tentativo di porgere
resistenza alla pressione interna, salvo in casi di progredito deperimento
respiratorio quando la parete toracica è diventata così debole che gli organi
interni riescono a dilatarla. Questa condizione non è molto rara.
3.4 Errori
movimentali polmonari
La somma di
tutti gli errori movimentali respiratori si ripercuote sui movimenti dei
polmoni (e si propaga sui tratti respiratori) perché seguono passivamente le
variazioni della cavità toracica.
In
espirazione errata:
- Invece di
raccorciarsi longitudinalmente i polmoni vengono schiacciati dal ventrale al
dorsale (sagittale) e nel medesimo tempo spostati leggermente in direzione
caudale.
- Lo
schiacciamento polmonare sagittale (ca. 1/3 dello spessore) preme anche sui
bronchi e diminuisce il loro lumen (mentre in espirazione ³normale² hanno
piuttosto la tendenza a dilatarsi), questo non solo pesa sullo scambio arioso
ma sfavorisce (per aumentata resistenza di flusso) anche la pressione
intratoracica (già sfavorita dai movimenti errati).
- Lo
schiacciamento sagittale deprime notevolmente gli alveoli e i capillari,
ulteriore motivo perché una respirazione disfunzionale diminuisce in modo
rilevante la capacità primaria dei polmoni, lo scambio di gas.
- Bronchi,
trachea e laringe vengono ³strappati² caudalmente e i bronchi per questo motivo
ulteriormente ristretti propagandosi la tensione tramite la trachea fino alla
laringe, l¹intercapedine vocale si chiude per riflesso e aumenta ulteriormente
la resistenza di flusso arioso.
Il PAROW
commenta così il suo schizzo:
Svantaggi
di disfunzioni respiratorie per i polmoni:
a)
ispirazione a spina eretta e torace portante (normale)
b)
espirazione a spina eretta (normale)
c)
espirazione con cedimento spinale e depressione toracica
d)
espirazione con flessione spinale
tratteggiato: espirazione normale
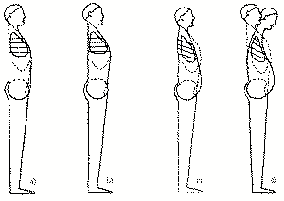
3.5 Errori
di regolazione respiratoria
In
concomitanza con disfunzioni movimentali respiratorie si incontrano quasi
sempre anche delle aberrazioni di guida del flusso respiratorio:
-
Dilatazione della stretta nasale per ipertensione di muscolatura delle guance
fino all¹aprirsi delle ali nasali in ispirazione.
- La
faringe diventa così l¹imbuto della guida del flusso e si deforma in modo che
il getto arioso diventa turbulento e rende sensibile la gola e il soggetto
afflitto da raffreddore.
- Fino allo
sviluppo di una respirazione ³pressata² quando di riflesso le corde vocali si
chiudono e si sente un rumore respiratorio in gola.
- Si notano
dei casi dove la resistenza dell¹intercapedine vocale al getto arioso fa
spostare la laringe col respiro.
Naturalmente
anche la formazione del suono è impedita in caso di disfunzioni respiratorie: -
Mancante ³tenuta sonora² (restrizione invece di dilatazione toracica) rovina il
suono.
- Mobilità
impedita di laringe e corde vocali e mancante flessibilità della faringe rende
incerta la fonazione e la sonorizzazione.
- La
vocalizzazione con la bocca perde di volume e portata, se sono impedite le
funzioni a monte.
Fremito,
sospiro, sbadiglio e sorriso sono altrettanto impediti e perdono il loro valore
come esercizi naturali, quando sono generati da restrizione e aumento di
pressione toracica; diventano uno strapazzo per respirazione e circolazione
specie per enfisematici. Idem per il soffio e il fischio.
3.6 Cause
della respirazione disfunzionale
La base per
una regolare respirazione può andare persa per diversi motivi.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
3.6.1 Deformazioni
spinali/toraciche
3.6.2 Rigidità
muscolari lombo-addominali
3.6.3 Abitudini
di abbigliamento
3.6.4 Debolezze
di muscolatura toracica
3.6.6 Traumi fisici
e psichici
3.6.7 Tensioni
muscolari e abitudini respiratorie emotive/psichiche
3.6.1
Deformazioni spinali/toracali
La forma della spina toracica determina la posizione delle coste e di conseguenza lo sviluppo della muscolatura parietale toracica, la posizione del diaframma e il movimento basilare respiratorio. Disfunzioni e deformazioni in questo contesto si determinano a vicenda. Come terapista devo aggiungere che è spesso più promettente usare le coste come ³leve² contro la deformazione spinale che viceversa, impiegando ampiamente il respiro stesso come massaggiatore 24-ore su 24.
Alle
disfunzioni e deformazioni spino-toracali, l¹organismo (e tante volte anche
terapisti, insegnanti ginnici e apostoli del respiro controllato-forzato)
rispondono con movimenti compensatori delle muscolature scapolo-clavicolari e
lombo-addominali il che a lungo peggiora la situazione.
La causa di
questa situazione è che l¹inventore non aveva previsto le sedie. Queste
provocano danni sin dai primi anni scolastici perché in questa posizione la
spina perde la sua tensione longitudinale, perché non più sostenuta da bacino e
gambe. Il deperimento della tensione longitudinale è seguito pari passo dalla
perdita di tensione trasversale toracica e con questo di capacità respiratoria.
Naturalmente
anche malattie (come Morbo di Scheuermann in adolescenza) o traumi
spinali/toracici senza adeguate terapie possono causare questi effetti.
3.6.2 Rigidità
muscolari lombo-addominali
Debolezze
respiratorie possono risultare:
- Da compensazioni
di deformazioni spino-toracici.
- Da
gravidanze.
- Da
malattie e operazioni addominali.
Già il
fatto di rimanere sdraiati nel letto per parecchio tempo lede la muscolatura
per normale distrofia. D¹altronde si incontrano tante persone con squilibri
muscolari tra Mm. ventrali e lombali, che impediscono ³l¹accompagnamento
disteso² dei movimenti respiratori toracali.
3.6.3 Abitudini
d¹abbigliamento
Le nostre
abitudini occidentali d¹abbigliamento sono probabilmente la principale causa
per le divulgate disfunzioni respiratorie nei nostri ambienti; cinture,
reggiseno, cravatte ed elastici stretti delle mutande impediscono parecchio il
libero gioco dei movimenti respiratori e favoriscono l¹impiego di muscolatura
respiratoria ausiliaria al posto della principale.
3.6.4 Debolezze
di muscolatura toracica
Operazioni,
traumi e malattie toraciche inducono l¹indebolirsi della relativa muscolatura
specialmente perché l¹organismo si protegge dal dolore, eseguendo il meno
possibile movimenti dolenti e sostituendoli con la muscolatura compensatoria.
Chiunque si sia già ferito le costole sa bene di che cosa sto parlando.
Malattie
nasali inducono spesso la respirazione orale abitudinaria che a lungo, in
mancanza di resistenza, indebolisce la muscolatura respiratoria, specie
diaframmatica.
3.6.6 Traumi
fisici e psichici
L¹organismo
si protegge dai dolori. Tenendo in considerazione le rindondanze motorie e la
sua creatività e inventiva ha tantissime possibilità di reagire a eventi come
colpi, ferite, incidenti e anche a situazioni durature scomode, esaurienti ecc.
Molto spesso, avendo trovato un ³nuovo equilibrio² (anche se meno economico)
non ha nessuna voglia di tornare alle vecchie abitudini (associate con dolori e
disagi). Cadute e colpi che ³ci tagliano il fiato², ferite di coste e sternali,
operazioni al torace lasciano spesso segni duraturi respiratori. Ogni tanto si
nota anche che dopo delle narcosi la coordinazione della muscolatura
respiratoria non è più ripristinata correttamente.
3.6.7 Tensioni
muscolari e abitudini respiratorie emotive/psichiche
Alcune
emozioni possono disturbare la respirazione in molteplici modi come:
-
Muscolatura addominale tesa che impedisce il lavoro del diaframma in maniera
tale da non abbassare la cupola diaframmatica, ma di elevare il torace.
-
Muscolatura mimica tesa che disturba il corretto funzionamento della stretta
nasale.
- Tensioni
di muscoli linguali, mandibola e collo anteriore che disturbano la posizione e
la funzione di laringe e faringe.
- L¹uso
abitudinario non appropriato della voce come il linguaggio pressato o quello
sottovoce.
- Tutte le
lesioni vocali sono errori funzionali dell¹uso muscolare; gli stessi muscoli
usati per la respirazione e per la vocalizzazione.
3.7 Sviluppo
della respirazione disfunzionale
Una
respirazione disfunzionale si nota poco in riposo o sotto poco sforzo, ma
peggiora con il progressivo indebolirsi della muscolatura respiratoria. Dopo il
sostegno dei muscoli pettorali, assistono anche quelli lombo-addominali e
quelli delle spalle, deformando a gobbo la spina dorsale toracica con movimenti
anacronistici.
Succede
ogni tanto spontaneamente alzando dei pesi, normalmente a fiato trattenuto. Lo
stadio finale catastrofico è raggiunto, quando invece di uscire quasi senza
pressione, il fiato viene pressato fuori dalla muscolatura toracica contro la
resistenza dell¹intercapedine vocale chiusa come si nota spesso in caso di
enfisemi.
4.0 Trattamento
della respirazione disfunzionale
KERNEÎZ mi
ha insegnato il significato del ritmo, la profondità e le pause respiratorie.
REICH ha
descritto in modo esemplare (anche se molto breve) nel suo saggio ³Die Funktion
des
Organismus²
movimenti e tensioni respiratorie in tutto il corpo come caratteristica di
organismi e le loro minime aberrazioni come legate a emozioni recenti o
passate. La loro conoscenza è di grande aiuto nel lavoro pratico corporeo
perché:
- Fa
scoprire molteplici micromovimenti respiratori inconsci paradossali.
- Permette
di ripristinare i micromovimenti ³naturali² adattando direzione, ritmo di tocco
e striscio in ogni momento alle necessità.
PAROW ha
chiarito il meccanismo dinamico della respirazione, specie l¹interdipendenza
tra il movimento e la ³tenuta², forze e controforze, e propone delle misure
terapeutiche razionali.
Vengono
trattati i seguenti temi:
4.4 Esercizi di
respirazione ordinaria
4.5 Eliminazione di
errori respiratori
4.6 Rinforzo della
respirazione
4.7 Correzione della
spina dorsale
Il
trattamento della respirazione disfunzionale consiste:
- In
correzioni verso una respirazione ³normale².
- Rinforzo
della respirazione in modo che diventi di nuovo sufficiente per affrontare
anche sforzi straordinari come per esempio restrizioni bronchiali spastiche.
Una grande
parte del trattamento è esercizio del cliente, così che il successo dipende
soprattutto da lui. Il terapista ha un ruolo:
-
Nell¹insegnamento di esercizi semplici e facilmente applicabili ovunque adatti
a degli errori respiratori specifici.
- Nel
lavoro sul corpo che apre dei blocchi, stimola la muscolatura principale ai
movimenti previsti e riporta la muscolatura ausiliaria al suo naturale ruolo di
portamento, sostegno e adattamento alle forze e ai movimenti.
- Nella
continua motivazione del cliente a proseguire il suo lavoro.
In
dettaglio il lavoro consiste nelle seguenti tappe:
1)
Correzione dei movimenti e rinforzo della muscolatura della parete toracica
tramite esercizio e stimolazione muscolare.
2)
Correzione della regolazione respiratoria in naso e faringe tramite esercizio e
allentamento di muscolatura facciale e faringeale.
3)
Esercizio della corretta respirazione normale fino all¹abitudine,
contemporaneamente con esercizio sorvegliato.
4)
Eliminazione di errori respiratori individuali con dimostrazione e inibizione.
5) Rinforzo
della respirazione fino al punto che soddisfa anche esigenze di sforzo
straordinario con esercizio specialmente di canto e recitazione.
6) In
parallelo lavoro corporeo posturale specialmente spina, torace, cingolo
scapolo-clavicolare, singolo pelvico e muscolatura lombo-addominale.
4.1.1 Massime per
il lavoro respiratorio
4.1.1 Massime
per il lavoro respiratorio
a) Minimo
impegno con il massimo effetto.
Respiro
soffice calmo e piatto. Il consiglio di ³respirare profondamente² sarebbe lo
stesso come indicare a un gastritico di mangiare smisuratamente. Singoli
respiri profondi si presentano automaticamente come pulsioni in sospiri,
sbadigli, ...
b) Il
respiro è automatico e non controllato dalla volontà.
Eccezioni
sono esercizi di allenamento per ripristinare gli automatismi di una
respirazione normale. Nel lavoro sul corpo si invoglia il cliente a lasciar
respirare il corpo come vuole e a non sopprimere delle pulsioni respiratorie.
Molti clienti hanno seri problemi in merito perché fanno fatica ad abbandonare
il controllo in presenza del terapista.
c) Il
movimento respiratorio viene eseguito dalla muscolatura parietale toracica e
diaframmatica.
Tutti gli
altri movimenti e ³ausiliari² hanno solo funzioni di portamento e
d¹adattamento.
Esercizi
per gli ³ausiliari² saranno divertenti e utili a chissà quali scopi, ma sono
respiratoriamente antiterapeutici perché indeboliscono le funzioni principali
respiratorie.
d) Si
respira finché è possibile con il naso.
La stretta
nasale e la deviazione alla cupola nasofaringeale è l¹antagonista della
muscolatura primaria respiratoria e la tiene in esercizio. La corretta
regolazione respiratoria coordina movimenti e tensioni.
Hanno lo
scopo di ripristinare il corretto funzionamento della muscolatura parietale
toracica senza collaborazione di ³ausiliari². Si tratta in particolare di
esercizi isometrici:
a) Tenere
largo e tondo solo il torace superiore senza impiegare la muscolatura delle
spalle e del collo mentre si va avanti a respirare in modo soffice, calmo e
piano. Il resto si lascia andare ³da sé² (esercizio ³gallo²).
b) Leggero
movimento di tutto il torace in direzione orizzontale (a fisarmonica) mentre si
va avanti a respirare in modo soffice, calmo e piano. Il resto si lascia andare
³da sé². Si impiega solo la muscolatura parietale toracica senza alcun impiego
degli ³ausiliari² (spalle, collo, addominali, serratus inferior); se viene
impiegato il M.serratus inferior si ritrae leggermente il torace superiore in
ispirazione (esercizio fisarmonica²).
c) Tenere
largo tutto il torace mentre si va avanti a respirare in modo soffice, calmo e
piano.
Il resto si
lascia andare ³da sé².
S¹impiega
poco la muscolatura parietale toracica e un po¹ di più il diaframma, mentre non
vengono impiegati gli ³ausiliari².
Come lavoro
d¹accompagnamento il terapista può eseguire:
- Breve e
tenero ³sfilacciamento² delle coste come se si volesse allargare per un attimo
il torace. Nel lavoro sul corpo per questa tecnica si usa spesso un fazzoletto
per poter tenere meglio.
-
Eventualmente lavoro corporeo respiratorio: appoggiare le mani sul torace
³chiuderle² (espirazione) e aprirle (ispirazione) nel ritmo del respiro con un
minimo di forza (sotto la soglia di percezione cosciente del cliente; tocco ³a
piuma²). Chi non lo sa fare bene è meglio che lo tralasci, ogni essere mosso
evita il muoversi ed è antiterapeutico perché indebolisce la muscolatura invece
di rinforzarla. Si tratta invece di ³invogliare² i muscoli parietali toracici a
muoversi da soli automaticamente ventiquattro ore al giorno.
Con questi
(anche solo i primi tre) esercizi si riesce a ripristinare, in settimane fino a
mesi, le funzioni respiratorie del torace, a condizione che siano fattibili,
cioè:
- Se la
muscolatura lombo-addominale incastra il movimento toracico orizzontale
inferiore: si noti che possono incastrare sia muscoli ipercontratti sia
iperestesi, come p.es. in accentuate lordosi lombali:
ipercontratti
i lombali, iperestesi gli addominali, tutti e due troppo tesi e poco capaci di
cedere alle variazioni volumetriche della cavità addominale. Non è una buona
idea ³rinforzare gli addominali² perché oltre ad aumentare la pressione sulle
vertebre lombari, incastra ancora di più il movimento respiratorio toracico. È
meglio allentare i lombari.
- Se la
muscolatura toracica stessa è ipertesa e non permette quindi movimenti:
torace
iperteso spesso in persone con serie difficoltà di calma e serenità, sempre
all¹attacco.
- Se il cingolo
scapolo-clavicolare è sovrasviluppato:
come in
tanti sportivi e artigiani. Il lavoro manuale forzato impedisce, disinserisce e
atrofizza la muscolatura parietale toracica superiore.
In questi
casi bisogna prima liberare le parti impedenti tramite il lavoro corporeo
posturale almeno fino al punto che gli ordinari movimenti respiratori non siano
più bloccati.
Appena è
possibile l¹esecuzione dei primi tre esercizi ³gallo², ³fisarmonica²,
³presenza² si inizia a fortificare il torace cantando, ronzando, gemendo,
sospirando in ogni occasione socialmente accettabile. Non importano stonature e
volume, basta che il portamento del torace sia corretto per il suono. Così ci
si abitua di nuovo all¹uso appropriato della voce per il linguaggio. Da solo in
macchina si hanno tante possibilità di esercitarsi.
Per chi
intende perfezionarsi, consiglio libro e cassette COBLENZER, HORST: Erfolgreich
sprechen;
Oesterreichischer Bundesverlag, Wien. ISBN3-215-06547-9 e ISBN 3-215-06548-7
e/o lezioni di canto o recitazione da un bravo maestro. Ai fedeli consiglio la
frequente partecipazione a messa cantata e litanie.
Una volta
ripreso (anche solo timidamente) il regolare movimento respiratorio del torace
e l¹uso appropriato della voce, migliora a vista anche la struttura (e non solo
toracica), perché c¹è di nuovo un massaggio dall¹interno ventiquattro ore su
ventiquattro e la ginnastica dell¹uso vocale come previsto dall¹inventore. È
molto efficace servirsi come terapista di questi meccanismi; anche rilevanti
deformazioni toracico-spinali recedono (persino in persone anziane) con i mesi
e gli anni.
La
regolazione respiratoria ordinaria avviene nella stretta nasale e nella
nasofaringe:
- La loro
resistenza è antagonistica a diaframma e muscolatura parietale toracica e tiene
in allenamento questi muscoli.
- Formano
un getto arioso laminare che disturba meno le corde vocali.
La
respirazione ordinaria è quindi nasale.
La
respirazione orale è riservata alle espressioni vocali, inevitabile in
specifici sforzi fisici (come nella corsa) e sintomo di disfunzione o patologia
respiratoria.
L¹istruzione
d¹esercizio di una corretta regolazione respiratoria ordinaria:
a) Labbra
aperte un millimetro per evitare tensioni facciali.
b) Lingua
sdraiata distesa in bocca un millimetro dietro i denti.
c) Respiro
con leggero rumore nella stretta nasale, ³risonanza in testa² e leggero rumore
sulla deviazione della cupola nasofaringeale.
In caso di
difficoltà di regolazione respiratoria ci sono una gamma d¹esercizi e
³manipolazioni² per niente spettacolari ma di lavoro minuto che servono a
ripristinare le funzioni regolari:
- Naso e
stretta nasale: tirare con mano leggera la pelle sopra e intorno al naso in
direzione caudale.
-
Collaborazione della cupola nasofaringeale: leggero ronfamento ³dietro il
naso², schioccare, e ³pronuncia di ³ch² in inspirazione.
- Allentare
ed esercitare la muscolatura facciale/nasale tramite massaggio e esercizi di
smorfia.
- Esercizi
di movimento, agilità e distensione della lingua aiutano anche la muscolatura
tra lingua e faringe.
- Esercizi
di movimento, agilità in tutte le direzioni e di distensione (lasciar pendere)
della mandibola.
- Esercizi
per distensione e abilitazione faringeale: distendere lingua e mandibola;
alzare la radice della lingua contro il velo palatale e verso la cupola
nasofaringeale, tenendo passivi il resto della lingua, la mandibola e le
labbra.
La
regolazione respiratoria nasale e i movimenti della muscolatura parietale
toracica sono i due pilastri della correzione e del rinforzo respiratorio.
4.4 Esercizi
di respirazione ordinaria
Quando il
movimento toracico e la regolazione respiratoria sono ripristinati e coordinati
si può proseguire a ripristinare la respirazione ordinaria normale tramite
esercizi con lo scopo che diventi di nuovo automatica. Così è stato all¹inizio
dei nostri giorni e da qualche parte nel cervelletto il programma ci sarà
ancora, solo che il nostro cliente ne usa un altro.
All¹inizio
questi esercizi richiedono tanta attenzione e concentrazione, rinforzandosi la
muscolatura diventano sempre più facili fino a diventare automatismo.
Naturalmente devono essere:
- Imparati
precisamente, perché si automatizzano anche eventuali errori.
-
Esercitati intensamente, perché solo lunghi esercizi sostituiscono vecchie
abitudini con nuove.
La tanto
temuta (con tutte le ragioni iperventilazione in esercizi respiratori si evita
con la semplice massima di mai usare più fiato di quello che l¹organismo
strettamente richiede (si prende). Respirazione ³profonda² non è respirazione
efficace.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
4.4.1 Muscolatura
lombo-addominale
4.4.4
Regolazione respiratoria ausiliaria
4.4.1 Muscolatura
lombo-addominale
Il
movimento respiratorio toracico-diaframmale varia continuamente anche il volume
addominale. La muscolatura lombo-addominale deve seguire elasticamente e
passivamente questo spostamento e quindi sono superflui se non danneggianti
degli esercizi di respirazione ³ventrali². Nota bene che il movimento
passivo-elastico si estende allo stesso modo sulle zone ventrali e sulle zone
dei fianchi!
Il nostro
stile di vita sedentario induce invece spesso un¹accentuata lordosi lombale con
i muscoli lombali ipercontratti, iperestesi gli addominali. Tutte e due queste
fasce di muscoli troppo tese e poco capaci di cedere alle variazioni
volumetriche della cava addominale. Non è una buona idea ³rinforzare gli
addominali² perché, oltre ad aumentare la pressione sulle vertebre lombali,
incastra ancora di più il movimento respiratorio toracico. È molto meglio
allentare e imparare a distendere tutta la muscolatura lomboaddominale. Senza
distensione ventrale, specialmente della porzione sotto l¹ombelico, diventa
impossibile una regolare ispirazione.
Queste
³deformazioni² non richiedono esercizi, salvo quelli distensivi, bensì la mano
di un terapista che se ne intende di lavori posturali. Non è poi così difficile
perché nel complesso del lavoro toracico si orienta facilmente la relativa
posizione di torace e bacino (tramite la spina), estendendo i muscoli lombali e
contraendo gli addominali, allentando tutti e due per riportarli al loro
equilibrio di tono.
Tecnicamente
è più proficuo riattivare il movimento passivo dei fianchi (Mm. Transversus
abd., Quadratus lumb., Erector spinae) ed allentare il ventre (Mm. Rectus abd.
Obliqui abdom.) che lavorare sulle vertebre lombali e sull¹apertura toracica
inferiore e anteriore.
Conviene
invece spesso lavorare il bordo del bacino anteriore e l¹apertura toracica
inferiore posteriore per raggiungere più efficacemente il traguardo del
riorientamento toracico-pelvico tramite la muscolatura lombo-addominale.
Solo in
casi eccezionali di erronea ³ginnastica respiratoria² o esercizi di Yoga mal
controllati, traumi anestetici e operativi o accidentali, lunghi forti dolori
toracici-addominali e altri sforzi che abbiano indotto perversioni movimentali,
inizialmente bisogna indurre, o per esercizio o per lavoro manuale, una
corretta coordinazione movimentale tra torace e cingolo pelvico.
La
normalizzazione del movimento toracico e la giusta reazione passiva e distesa
del cordone muscolare lombo-addominale con il susseguente riorientamento
toracicopelvico, ripristina automaticamente il movimento funzionale del
diaframma. Con la respirazione ordinaria nasale e la vocalizzazione come antagonisti
e regolatori di questo movimento, acquista efficacia in poco tempo.
Esercizi
diaframmali come ³respirazione ventrale² coinvolgono attivamente muscolatura di
portamento e adattamento e indeboliscono così la muscolatura respiratoria
principale.
Dei lavori
posturali ben fatti per ³liberare il diaframma² si rivolgono ai movimenti
intercostali e inducono solo indirettamente per reazione una risposta
diaframmale. Chi conosce esattamente ³la linea d¹origine diaframmale² potrà
riequilibrare e ricoordinare il movimento toracico-diaframmale in modo molto
efficace.
Spesso sono
³disinseriti² singoli areali di fibre muscolari diaframmatiche a causa di
traumi fisici. L¹abile ³operatore manuale² li trova e li riattiva seguendo
attentamente tutta la circonferenza di allacciamento diaframmatico tra xifoide
e vertebra coinvolte.
Il ³tono
muscolare² influisce notevolmente sulla respirazione. Sia:
- un tono
troppo alto ³teso² impedisce il libero movimento respiratorio, sia
- un tono
troppo basso ³floscio² fa ³aggrinzire² i polmoni.
Questo è da
valutare e considerare in pazienti tesi, carichi, esausti, esauriti ..., meglio
toccare che ascoltare in questo contesto. Spesso si incontrano anche strane
combinazioni di floscio e teso in diverse parti dell¹apparato motorio. In
opposizione all¹opinione corrente che gli esercizi di distenzione possano fare
solo bene, nel caso di un ³esaurito-floscio² essi sono antiterapeutici.
Ammetto che
la maggioranza, anche dei miei clienti, è ipertesa. L¹esercizio più efficace in
merito è:
-
Distendere la respirazione con diversi ³sospiri² senza pressione (lasciar
uscire il fiato) con le labbra appuntite.
- Sdraiarsi
nella posizione più comoda possibile e stare assolutamente fermo, senza il
minimo movimento, immaginandosi di appoggiare sempre più pesantemente sul
materassino (lettino).
Dopo
diverso tempo s¹impara così a distendersi bene anche in minor tempo e in altre
posizioni.
Le tecniche
distensive sono diventate un proficuo mercato e hanno senz¹altro anche
importanti funzioni sociali. Ma nessuna tecnica o suggestione è più efficace
della sopra menzionata.
4.4.4 Regolazione
respiratoria ausiliaria
In
disfunzioni o patologie della regolazione respiratoria ordinaria (stretta
nasale, cupola nasofaringeale) il cliente respira con la bocca. Se non è
possibile ripristinare con semplici trucchi e in tempo utile la respirazione
nasale, bisogna ricorrere a una regolazione respiratoria ausiliaria: si
sostituisce la resistenza naso-faringeale con una resistenza boccale.
-
Inspirazione ed espirazione su ³f², ³s², ³ch² o ³kch² cosa va meglio per il
cliente.
Pro
memoria: diaframma e muscoli toracici parietali necessitano di una resistenza
antagonista per tenersi o mettersi in ³forma².
È controproducente vocalizzare il suono, perché ³trattiene²
il fiato invece di ³lasciarlo andare².
4.5 Eliminazione
degli errori respiratori
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
4.5.1 Trattenimento
respiratorio
4.5.1 Trattenimento
respiratorio
La
respirazione rimane continuamente in stato di tensione e non trova mai pace.
Provoca
irritazione ai bronchi, polmoni mai lasciati in pace e induce attacchi nervosi.
Il continuo
³affollamento² dei polmoni facilita l¹evoluzione di enfisemi.
Se il
cliente non riesce a modificare l¹abitudine deve imparare ad accompagnare ogni
minimo sforzo (anche emotivo) con una leggera espirazione senza prendere fiato
prima e senza abbassare il torace. Spesso riesce meglio se l¹espirazione è
accompagnata da un leggero sospiro senza pressione. Ci vuole pazienza, perché è
fattibile solo dopo che il torace ha riacquistato la sua ³grinta².
Lasciar
correre il respiro e lasciarlo in pace si familiarizza bene con l¹immaginazione
di tenere sempre vuoti i polmoni a stomaco disteso e torace inferiore chiuso.
La necessaria ventilazione si presenta automaticamente.
Irritazione
della gola che sparisce a poco a poco con l¹impiego della regolazione
respiratoria corretta. Sparisce in fretta inspirando con le labbra aperte un
millimetro e movimento ³a fisarmonica² del torace; le coste si tengono larghe
non ³espirando² ma lasciando andare l¹aria. Al paziente sembra strano il fatto
di non espirare volutamente.
Nel tossire
si tende a ritirare il ventre basso. Meglio sarebbe alzare lo sterno, ma questo
è difficile per il principiante.
Per le
correzioni vedi capitolo 2.8 ³Formazione della voce². Dove non è possibile,
inizialmente si consiglia:
- Di
parlare piuttosto a voce bassa e polmoni poco riempiti.
- Di
espirare un pochettino prima di attaccare la voce e ripeterlo spesso anche
durante la relazione.
- Parlare
il più distesi possibile con la volontà di consumare il meno aria possibile.
4.6 Rinforzo
della respirazione
L¹applicazione
degli esercizi per il torace e la regolazione respiratoria rinforza
notevolmente e automaticamente la respirazione. Il massimo rigore lo si
acquista cantando estensivamente, all¹inizio sotto il controllo di un
insegnante di canto. Anche i seguenti esercizi possono aiutare a rinforzare una
respirazione ripristinata:
- ³Tirare
su² con il naso (quello che si proibisce ai bambini) a muscolatura mimica
distesa.
- Allargare
energicamente la vita (tutta, non solo la parte anteriore; identico al sostegno
respiratorio nel canto); serve solo se il resto del torace rimane immobile e la
spina sta ferma.
Meglio
farsi controllare dall¹esperto.
- Per
evitare ogni pressione, l¹espirazione si fa a bocca leggermente e gola
completamente aperta, lingua distesa sul fondo della bocca.
4.7 Correzione
della spina dorsale
La spina
dorsale deve portare il torace e fissarlo in respirazione. Questo lavoro viene
svolto soprattutto dai Mm. erectores spinae e serrati. Quando questi sono
deboli influenzano anche il funzionamento respiratorio. Nella nostra cultura
sedentaria è pressoché impossibile incontrare una spina dorsale in ordine, si
trova ancora nei popoli che abitualmente portano i loro pesi sulla testa (che
sarebbe già un ottimo esercizio, portarsi un libro sulla testa durante le
attività giornaliere; avvolto in un asciugamano intorno al cranio). Per il
resto consiglio esercizi per la schiena insegnati dalle varie scuole.
Applicando
i principi e le tecniche di cui sopra si riesce:
- A far
diventare automatica la meccanica respiratoria ordinaria.
- A
rinforzare sufficientemente la muscolatura respiratoria al punto di poter
reggere anche sforzi elevati come restrizioni bronchiali in spasmi e catarri e
durante la tosse.
- A
riformare l¹apparato respiratorio.
- A
ripristinare l¹elasticità e il vigore polmonare e a ³normalizzare² il volume
polmonare.
- Ad
eliminare errori respiratori che inducevano al deperimento respiratorio.
È quasi
sempre anche necessario eliminare esercizi respiratori controproducenti che
suggeriscono uno dei seguenti elementi:
-
Espirazione forzata.
-
Collaborazione respiratoria del dorso.
-
Repressione del torace in espirazione.
-
Collaborazione forzata della muscolatura lombo-addominale.
-
Collaborazione della muscolatura scapolo-clavicolare e collare.
- Forzata
³presa di fiato².
-
Trattenimento del respiro.
Respirare
coscientemente significa anzitutto raccogliere l¹aria con il naso e percepirla
coscientemente con i sensi del tatto e dell¹olfatto. Come il mangiare consiste
nel masticare e gustare il nutrimento, il respiro consiste nel sentire e
annusare l¹aria. Come è privo di senso riempirsi al massimo lo stomaco e il
ventre, è privo di senso riempirsi i polmoni e il torace con aria. Come alla
digestione debole e ammalata serve poco cibo in piccole porzioni, all¹apparato
respiratorio leso serve una respirazione con poca aria. Respirare più di quanto
l¹organismo richiede è stancante e carica smisuratamente la circolazione. Anche
gli esercizi saranno da eseguire lentamente e con meno aria possibile!
La
patogenesi della respirazione patologica:
- Errori
respiratori funzionali (e quindi ³l¹esercizio automatico² diminuito) riducono
il rendimento respiratorio.
- La
funzione errata sostituisce progressivamente la funzione normale e la
indebolisce ulteriormente.
- Errori
funzionali si amplificano a vicenda e diventano brutte abitudini respiratorie.
- Alle
esigenze respiratorie aumentate, il sistema risponde con aumentato impegno (non
redditizio; forza al posto di tecnica), di Mm. ³ausiliari respiratori².
Finché
questo meccanismo funziona, l¹insufficienza dell¹apparato è compensata, anche
se in modo poco economico.
- Poiché il
rapporto tra impegno e risultato è scarso, ciò porta a impegni sempre più
frequenti ma contemporaneamente sempre minori, così si raggiunge il limite e si
deve sforzare notevolmente.
- Questo
aumenta gli errori funzionali e presto o tardi si arriva al cedimento (è un
vero circolo vizioso) e allo scompenso respiratorio.
-
Inizialmente è passeggero e sparisce con il diminuire dell¹impegno.
In questo
stadio si presenta come ³debolezza² respiratoria.
- Sovraccarico,
mal funzione e frequente cedimento si amplificano a vicenda fino al punto che:
- ledono il
lavoro quotidiano e diventa così malattia.
-
Proseguendo per lo stesso circolo vizioso si arriva al punto che non si coprono
più le esigenze biologiche di riposo e diventa malattia ³inesorabile².
Simile alle
debolezze cardiache e dell¹apparato motorio la decompensazione comincia al
momento in cui l¹efficacia ridotta del sistema si scontra con esigenze
superiori ad essa. La differenza è che la diminuita resa dell¹apparato
respiratorio è nella maggior parte dei casi causata da errori e da ³brutte
abitudini² funzionali respiratorie, che, a loro volta sono sotto l¹influenza
della volontà individuale e quindi possono essere corrette prevalentemente con
esercizi.
Una carica
respiratoria aumentata s¹incontra:
- In sforzi
fisici.
- Gonfiore
mucotico per processi allergici o infiammatori delle vie respiratorie e
malattie acute o croniche dell¹apparato respiratorio (aumenta esigenze,
diminuisce resa).
-
³Strozzamento² muscolare di vie respiratorie per motivi emotivi e psichici.
- Funzioni
errate faringeali in tosse e vocalizzazione.
I primi
attacchi di ³sindrome asmatica² si incontrano spesso in ³deboli respiratori²
(con respirazione compensata) sotto carico come detto sopra, specie durante una
banale bronchite infettiva acuta.
Vengono
trattati i seguenti temi:
5.1 Dilatazione
polmonare (enfisema)
5.1 Dilatazione
polmonare (enfisema)
Nella
dilatazione polmonare (enfisema) i polmoni rimangono riempiti ed espansi anche
dopo l¹espirazione. Sono coinvolti due processi:
-
Trattenimento di fiato ed espirazione ³pressata² (come in tosse frequente) che
formano una pressione all¹interno dei polmoni combinati con
- mancante
vigore della muscolatura toracica parietale che non resiste alla pressione
interna.
Il polmone
pressato dall¹interno per ³brutte abitudini² respiratorie si comporta come la
vescica di un pallone che gonfia un involucro troppo debole per resistere.
Tutte e due gli elementi sono caratteristici di una respirazione errata.
Il parere
comune medico è che la ³tosse pressata² è all¹origine di dilatazione polmonare.
Altrettanto influente è invece il cedimento della muscolatura addominale-toracica:
finché è vigorosa, resiste anche alla tosse. Una debolezza muscolare addominale
può essere innata, causata da gravidanza o operazioni o far parte di
deperimento della muscolatura toracica o spinale.
Spesso si
nota una dilatazione polmonare prima per il rigonfiamento ventrale con
abbassamento toracico durante un colpo di tosse. I muscoli non tengono più in
forma l¹apertura toracica inferiore, perciò si apre la curvatura costale e man
mano il torace inferiore. In questi casi il processo è spesso accompagnato da
disturbi come prolassi, ernie addominali e pelviche. Con il tempo, le viscere e
con loro diaframma e polmoni si abbassano sempre di più nella cavità ventrale
sovraespansa, spinte da ogni colpo di tosse. Una spina dorsale indebolita accentua
questa progressione.
In altri
casi più rari cede dapprima il torace superiore posteriore. Cedono Mm. erettori
della spina e i serrati superiori deboli. Ciò permette al tronco di cadere in
avanti e di contrarsi. Il risultato è il dorso rotondo (gobbo).
Queste
forme di dilatazione polmonare (volumen pulmonum auctum) possono ripristinarsi
se i fattori provocatori vengono eliminati (tosse canina, bronchite/tosse
cronica, asma). Più a lungo però anche il tessuto polmonare perde prima di
elasticità e poi si altera (enfisema anatomico) in maniera ritenuta
³irreparabile². Forme lievi non sono rare in persone anziane e non creano
problemi sotto modeste cariche fisiche.
Vengono
trattati i seguenti temi:
5.1.1 Sviluppo
della dilatazione
5.1.1 Sviluppo
della dilatazione
Se una
dilatazione polmonare regredisce, rimane o progredisce dipende:
-
Dall¹eliminazione della prima causa (pressione intrapolmonare).
-
Ripristino della meccanica respiratoria.
È chiaro
che l¹infezione, l¹irritazione, la tosse, l¹attacco asmatico si combatte e la
medicina moderna ha fatto enormi progressi in merito. È già meno scontato che
si modifichino le correlate abitudini errate di regolazione respiratoria
(trattenimento del fiato, della respirazione e tosse pressata) e sembra non sia
per niente chiara la necessità di ripristinare il vigore muscolare trasversale
leso in torace, lombi e addome come nella spina dorsale. Questo spiega anche
perché, pur avendo curato le cause nel migliore dei modi, trascurando però i
fattori meccanici, la situazione dilatativa sia peggiorata.
A lungo
andare, però, il tessuto polmonare perde prima di elasticità e poi si altera
(enfisema anatomico) in maniera ritenuta ³irreparabile². Pare che (a parte
lesioni interne di alveoli) il processo duri più a lungo del pensato e che in
parte sia ripristinabile anche questo trattandosi di tessuto vivo con grandi
capacità di rinnovamento.
Se la
dilatazione polmonare progredisce, l¹organismo tenta di aiutarsi con:
5.1.1.1 Respirazione
pressata continua
5.1.1.2 Movimenti
toracici paradossali
5.1.1.3 Attacchi
di asma a causa della dilatazione polmonare
Questi
peggiorano la situazione fino al punto di attacchi ³asmatici enfisematici².
5.1.1.1 Respirazione
pressata continua
Quando la
resa respiratoria si avvicina alla decompensazione, la respirazione pressata
diventa frequente: la muscolatura ausiliaria lombo-addominale e dorsale si
impegna a sostituire l¹incapacità di quella principale. Questo restringe fra
l¹altro la stretta della glottide, peggiorando drammaticamente la regolazione
respiratoria. La spina dorsale è notevolmente coinvolta, in modo che invece di
³affrancare il torace², si muove con ogni respiro.
5.1.1.2 Movimenti
toracici paradossali
Quando
crolla completamente il vigore muscolare trasversale, il torace inferiore in
ispirazione si restringe, perché il diaframma tira verso l¹interno l¹apertura
³atonica².
5.1.1.3 Attacchi
di asma causati da dilatazione polmonare
Quando la resa respiratoria è arrivata al punto che basta ancora solo per lo stato di riposo, anche un minimo sforzo fisico o impedimento respiratorio fa crollare il sistema e si manifesta come attacco asmatico. È da distinguere bene dall¹asma autentica perché i medicamenti spasmolitici usati per quest¹ultima non servono e caricano inutilmente la circolazione.
Asma
bronchiale ³autentica² o ³genuina² si chiama la decompensazione, il crollo
respiratorio in attacchi spontanei.
Il carico
respiratorio aumentato consiste nella costrizione dei bronchi che aumenta la
resistenza respiratoria e rende più laboriosa l¹ispirazione. Finché la capacità
muscolare respiratoria è sufficiente ed efficace per superare la resistenza, la
costrizione bronchiale non provoca un attacco. Anche qui (come nella
dilatazione polmonare) si tratta di uno squilibrio tra carica respiratoria e
resa muscolare e bisogna considerare terapeuticamente sia la diminuzione della
carica sia l¹aumento della resa muscolare.
La
costrizione bronchiale può avere diversi motivi:
- Per
spasmi nervosi dei loro muscoli toroidali (molto rilevante).
- Per
rigonfiamento allergico della mucosa (rilevante).
- Per
gonfiore infiammatorio e secrezione smisurata di catarro bronchiale (meno
rilevante).
I primi due
meccanismi sono spesso correlati e non facili da distinguere. Il terzo
s¹incontra anche isolato e senza alcuna partecipazione dei primi. Si trova
spesso nei bambini afflitti da infezioni delle vie respiratorie e muscolarmente
deboli.
Quando il
diaframma non riesce più a superare la resistenza (per sovraccarico o
stanchezza), i muscoli ausiliari di cingolo scapolo-clavicolare, collo e dorso
già usati scorrettamente aiutano, tirando in su il torace in inspirazione. La
conseguenza è la pressione toracica in espirazione, impiegando anche la
muscolatura ventrale e la gravità. L¹esteso impiego della muscolatura
ausiliaria per la respirazione durante un attacco, indebolisce ancor di più la
già debole muscolatura principale toracica-parietale e il circolo vizioso si
chiude.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
5.2.3 Asma
allergica-eczematosa
5.2.5 Asma e
ipersensibilità emotiva ansiosa
Gruppo di
malattie con al centro la sindrome asmatica: decompensazione respiratoria,
quando una respirazione disfunzionale (con diminuita resa) cede sotto un carico
respiratorio.
Il
fabbisogno d¹ossigeno dell¹organismo aumenta sì il lavoro respiratorio ma
basato su disfunzioni respiratorie, questo lavoro consuma più ossigeno di
quello che aggiunge alla circolazione. La sindrome asmatica è una respirazione
forzata inefficace.
Le cause di
un ³attacco asmatico² sono:
- Sforzi
fisici generali che aumentano il fabbisogno di ossigeno.
-
Impedimenti delle vie respiratorie che aumentano lo sforzo respiratorio stesso.
Lo spasmo
neurovegetativo contrae la muscolatura toroidale bronchiale in misura che solo
una respirazione efficace riesce a superare l¹aumentata resistenza, una
respirazione anche leggermente disfunzionale non ce la fa più e risponde con un
attacco asmatico.
47
Pare che si
tratti di un¹iperreattività neurovegetativa che si manifesta anche nel
comportamento e portamento della persona ipercarica e spasmotendente a livello
emotivo caratterizzato come ³ansiosa ipertensione difensiva². Ha senz¹altro una
forte componente ³socio-psico-somatica² nel senso di circolo vizioso ma non
come causa-effetto. La dimostrazione è che l¹approccio somatico (imparare a
diminuire la tensione polmonare con esercizi di regolazione respiratoria) è
spesso più efficace di tentativi ³psicologici² (per influenzare il sistema
neurovegetativo tramite ragionamenti e simili).
Considerando,
oltre ai meccanismi neurovegetativi, anche quelli regolativi, ormonali,
immunitari e di regolazione basale si porta forse il discorso ancora di più
verso una visione olistica. Per la classificazione ³spastico-nervoso² è da
ritenere che funzionano spesso in questa forma dei medicamenti spasmolitici.
5.2.3 Asma
allergica-eczematosa
Si tratta
di una specie di ³orticaria² o ³eczema² della mucosa bronchiale, eventualmente
con ipersecrezioni, che gonfia le mucosa dei bronchi. Il loro diametro
diminuisce e aumenta la resistenza. Se sono coinvolte anche delle irritazioni,
per riflesso possono anche aggiungersi contrazioni muscolari bronchiali.
Il resto
delle reazioni è simile all¹asma spastico-nervosa anche se di solito i sintomi
sono un po¹ meno pesanti. Visto che anche eczemi e orticarie hanno una forte
componente neurovegetativa, ormonale, immunitaria e di regolazione basale, non
c¹è da meravigliarsi se ogni tanto sono difficili da distinguere. Per la
classificazione ³allergico-eczematosa² è da ritenere che spesso funzionano
misure antiallergiche e di regolazione basale.
Deregolazione
della coordinazione nervosa, disfunzione dell¹apparato motorio respiratorio e
deformazione pneumo-toracica sono concatenate in un circuito chiuso: la
deregolazione chiama la disfunzione e la instaura dopo tante ripetizioni, la
disfunzione chiama la deformazione e la instaura dopo innumerevoli ripetizioni,
la deformazione chiama la deregolazione (subito) e la deregolazione la
disfunzione (presto) e così via.
Il ³circolo
grazioso² sarebbe quindi: regolazione-funzionalizzazione-riformazione.
Visto che
la coordinazione nervosa dei meccanismi respiratori ha una forte componente
emotiva e inoltre fino a un certo punto è controllabile dalla volontà, sono
evidenti i nessi tra psiche e apparato motorio sia come soggetto sia come
oggetto. D¹altro canto non è un senso unico: l¹esperienza insegna che il
miglioramento funzionale respiratorio calma sia gli stati emotivi che quelli
asmatici. Psicoterapie ben fatte possono essere accompagnate da una terapia
respiratoria come supporto; da sole non riescono a ripristinare le disfunzioni
e deformazioni dell¹apparato motorio.
5.2.5 Asma
e ipersensibilità emotiva ansiosa
A livello
terapeutico alla componente somatica è contrapposta quella ³culturale-sociale².
Siamo continuamente costretti a equilibrare le due componenti con enormi
complicazioni emotive, comportamentali e pulsazioni.
Nel
classico paziente d¹asma spastica si nota raramente serenità, caratteristica
opposta per definizione allo stato ³nervino-spastico². In terapia bisogna tener
conto della ³caratteristica asmatica² non solo come approccio terapeutico ma
anche per evitare comportamenti ³terapeutici² che nutrano il meccanismo
psicosomatico dell¹asmatico. Con il rischio di generalizzare troppo, ma per
motivi didattici, oso ³caratterizzare² un aspetto rilevante per asma di tipo
spastico allergico:
La
sovraccarica nervosa dell¹asmatico è la reazione inconscia di un animo
ipersensibile a un¹autorità/³responsabilità²/dovere che teme di non reggere e
dalla quale si sente sopraffatto. Come il corpo anche l¹anima tenta di
rispondere alla carica con la forza. Spesso questo meccanismo viene instaurato
nella prima infanzia tra madre-figlio o padre-figlia che non permettono lo
sviluppo del bambino ma ³lo formano a loro immagine².
Questa
immagine è ancorata fortemente nell¹inconscio e tanti non riescono mai a
liberarsene.
Se questo
meccanismo infine si esprime in asma spastica dipende:
- Dalla
robustezza dell¹anima del colpito; la sua caricabilità e il limite del crollo
dove si manifesta in ipertensione ansiosa e continua prontezza di difesa.
- Dalla
costituzione e predisposizione allergica e dal funzionamento dell¹apparato
respiratorio.
- Dalle
condizioni attuali sia di carica emotiva autoritaria sia di carica
respiratoria/ allergica.
La tensione
ansiosa dell¹asmatico è un serio problema pratico per le terapie funzionali
respiratorie che consistono in tanto esercizio. Questo richiede responsabilità
propria, la condizione per avere successo e rende difficile l¹allenamento di
movimenti automatici ³giocosi² che sono il contrario del ³dovere obbligatorio
giusto e costretto² dell¹asmatico. L¹approccio del terapista a questa
problematica, la trasmissione del ³piacevole e utile² più che del ³giusto² e la
motivazione (mai tramite autorità, perché è già leso in merito), sono elementi
altrettanto incisivi per l¹esito quanto le capacità teoriche e tecniche del
terapista.

Si
distingue nettamente dalle altre due forme non solo per il fatto che si esprime
in forme più blande, ma anche per il fatto che colpisce spesso chi da bambino
era astenico, debole di costituzione e/o afflitto da frequenti malattie
catarrali. La resistenza respiratoria per via di secreti catarrali e la frequente
tosse in una costituzione debole inducono presto delle disfunzioni respiratorie
che possono evolversi fino all¹asma.
Anche
deformazioni toraciche, continue irritazioni dell¹apparato respiratorio (come
la bronchite cronica dei fumatori che non si muovono mai senza necessità) e
delle patologie come enfisemi possono arrivare a questo punto.
Visto che
l¹asma e la dilatazione polmonare sorgono dalle stesse disfunzioni
respiratorie, l¹evoluzione dell¹asma segue le orme dell¹enfisema e viceversa.
somatico sociale comportamenti pulsazioni emozioni
6.0 Trattamento
delle patologie respiratorie
In seguito
vengono trattati i seguenti temi:
6.1 Dilatazioni
polmonari (enfisemi)
6.8 Altre patologie trattabili con la terapia respiratoria
funzionale
6.1 Dilatazioni
polmonari (enfisemi)
In caso di
una respirazione debole: nessun esercizio respiratorio camminando, con
l¹eccezione della fase di rinforzo con l¹ausilio della voce. La respirazione
sana sopporta tanto, ma non necessita di esercizi.
Si eseguono
le seguenti tappe proseguendo alla prossima solo se sono stati raggiunti gli
obiettivi della precedente. Non correre, non sforzare, controllare cautamente
perché si tratta di ripristinare automatismi senza errori.
- Esercizi
basilari di respirazione ordinaria:
-
Respirazione nasale provvisoriamente corretta o regolazione provvisoria orale.
-
Possibilmente tenere vuoti o lasciarsi svuotare i polmoni.
-
Posizionamento del torace favorevole, passando man mano in posizione seduta e
poi eretta.
-
Correzioni toraciche e spinali.
-
Correzioni della tosse.
-
Eliminazione del sovrariempimento polmonare in ogni attività: espirare un po¹
con ogni sforzo (da esercitare p.es. facendo le scale).
-
Ripristinare la respirazione nasale automatica.
-
Regolazione respiratoria.
-
Trattamento della muscolatura mimica.
- Esercizi
della mascella, lingua, faringe.
-
Esercitare la respirazione orale corretta (per necessità degli sforzi che in
una respirazione e/o circolazione lesa consistono già nel passeggiare).
-
Conseguente applicazione della respirazione ordinaria con l¹idea di respirare
il minimo possibile e di tener vuoti i polmoni.
- Rinforzo
della respirazione se possibile con l¹uso del suono.
In seguito
vengono trattati i seguenti argomenti:
6.1.1 Respirazione
pressata negli enfisemi
6.1.2 Movimenti
toracici paradossali
6.1.3 Prevenzione
di enfisemi, bronchiti croniche
6.1.1 Respirazione
pressata negli enfisemi
Per prima
cosa bisogna disinserire la stretta faringeale tramite la regolazione ausiliaria
con rumore su ³sc² o ³khuff² in espirazione, lasciando ³implodere² il torace.
Dopo si può proseguire con qualsiasi regolazione ausiliaria. Quando questa
tecnica è domata in posizione eretta si può attaccare con il programma per i
semplici enfisemi, iniziando però ogni esercizio come sopradescritto, fino a
che diventa abitudine di evitare sovraffollamento, soprapressione e
trattenimento dei polmoni e del fiato.
6.1.2 Movimenti
toracici paradossali
Da
eliminare con degli esercizi controllati e guidati dal movimento dell¹apertura
toracica inferiore contro l¹impulso spontaneo, inizialmente più ampi del
necessario e con la tendenza a distendere il torace e a riportarlo nella forma
prevista dall¹inventore. Se va meglio l¹esercizio in espirazione o in ispirazione
è da provare. Inizialmente si esercita da seduti, poi eretti, applicando la
regolazione respiratoria ausiliaria sopra menzionata per respirazione pressata.
Poi si attacca con il programma per gli enfisemi. Con terapie manuali (ritmate
sulla respirazione) si riesce spesso a normalizzare questa disfunzione senza la
consapevolezza del cliente.
6.1.3 Prevenzione
di enfisemi, bronchiti croniche
Essendo gli
stessi errori respiratori che portano a bronchite cronica e a enfisemi, si
trattano allo stesso modo. Preventivamente è poco impegnativo:
-
Correzione della tosse.
-
Normalizzazione della respirazione raggiungibile spesso con pochi esercizi di
rinforzamento toracico e regolazione respiratoria.
- Calmare i polmoni tenendoli vuoti e distesi.
Non possono
essere guarite con la correzione respiratoria, ma si riesce a ridurre la loro
estensione, la quantità secretoria e i disagi. Oltre al programma per gli
enfisemi si cura specialmente:
- Lo
svuotamento dei polmoni.
- La
formazione del torace rafforzando la muscolatura toracica parietale.
- Il
trattamento della spina dorsale.
Lasciar in
pace i polmoni perché sono già lesi. Ogni respirazione forzata e movimento
toracico sono assolutamente da evitare. Solo se sono coinvolti rilevanti errori
respiratori si tenta di sfruttare meglio l¹aria con cauti esercizi ³statici²
(non di movimentazione), per la respirazione pressata si può correggere la
regolazione respiratoria.
L¹esperienza
dimostra che la lesione è un criterio e lo sfruttamento del rimanente un altro.
Ristabilendo
una respirazione ordinaria corretta si raggiungono notevoli risultati in questo
senso. Il programma di cura è quello descritto sotto ³enfisemi².
Le
operazioni al torace come:
- Polmonari
con resezione ed ev. toracoplastica.
- Cardiache
con apertura dello sterno.
- Di
mammella con ev. resezioni muscolari.
Causano
come minimo delle perdite di tensione muscolare toracica parietale che assieme
con ev. resezioni muscolari e misure plastiche cambiano notevolmente la
meccanica respiratoria.
La
resezione polmonare crea inoltre delle condizioni volumetriche cambiate.
È evidente
che secondo il tipo dell¹intervento la respirazione può subire gravi modifiche
per:
- Distrofie
muscolari.
- Seguenti
deformazioni toracico-spinali.
-
Deformazioni bronchiali.
Si nota
spesso che anche tanto tempo dopo un tale intervento si presentano sintomi di
insufficienza respiratoria, spesso di carattere asmatico, perché la
respirazione del colpito è forzata grazie ad abitudini respiratorie nefaste.
Il
trattamento di riabilitazione e ricostituzione respiratoria dopo traumi
toracici è identico al programma descritto sotto ³enfisemi² con delle
restrizioni importanti:
- Non
disturbare la guarigione tessutale con premura, impazienza, sforzi : il tessuto
connettivo impiega più di un anno per ricostruirsi completamente.
- Tutti gli
esercizi vanno eseguiti in modo particolarmente dolce.
Le seguenti
indicazioni possono servire:
- Al centro
si trova l¹allenamento della muscolatura toracica parietale con esercizi
isometrici, il diaframma riprende automaticamente tono con questi esercizi.
-
Trattamento della spina dorsale per ripristinarne completamente la fermezza e
quando è possibile anche la geometria.
- La
regolazione respiratoria avviene inizialmente con la minima resistenza
inspiratoria: p.es. esercizio come ³sorseggiare l¹acqua dalla mano², dopo con
un dito appoggiato sulle labbra leggermente aperte, solo poi i normali esercizi
di regolazione respiratoria fino a raggiungere l¹ordinaria respirazione nasale.
I disturbi
respiratori provenienti da cicatrici pleuriche sono ben curabili:
- Esercizi
di respirazione ordinaria.
- Un paio
di sospiri ogni tanto senza sforzare.
-
Migliorare la motilità toracica con esercizio di ³fisarmonica² specialmente
sulla parte colpita.
- Esercizi
di regolazione respiratoria corretta, ev. all¹inizio ausiliaria.
- In una
prima tappa si tratta di ripristinare una respirazione ordinaria come descritto
per la dilatazione polmonare.
- Punto
centrale sono gli esercizi per distendere e tener vuoti i polmoni tramite la
distensione ventrale e ³non espirare² ma ³lasciar uscire² il fiato.
- Questo
alleggerisce i sintomi ma non basta per l¹asma spastica: ci vogliono esercizi
per il rinforzo del torace.
- Raggiunto
questo, si riesce sempre più facilmente a reggere gli attacchi, anche perché la
migliorata regolazione respiratoria toglie tanta irritazione dai bronchi e li
rende più resistenti agli spasmi.
In un
attacco asmatico sono importanti due massime:
- Spina
vertebrale dritta per non ³schiacciare² i polmoni.
- Liberare
il diaframma tramite distensione ventrale.
- Impiegare
il meno possibile la muscolatura scapolo-clavicolare.
Questo si
può raggiungere in diverse posizioni:
- Sdraiati
ventre in giù (mani sotto il mento o sotto la faccia).
- Posizione
ginocchia-gomiti ad angolo acuto.
- Seduti
con dorso appoggiato.
- Seduti ³a
sella² con testa e mani sullo schienale.
- Seduti a
tavola con gomiti appoggiati e mento nelle mani.
Tutte
queste posizioni facilitano la distensione ventrale e con ciò quelle del
diaframma. È da evitare l¹usuale appoggio con le mani (per impiegare meglio la
muscolatura di spalle e collo) per non sostenere un errore cardinale di
respirazione.
In seguito
vengono trattati i seguenti argomenti:
6.7.1 Cedimento
della parete addominale
6.7.2 Stimolazione
del diaframma
6.7.3 Disinserimento
della respirazione pressata
6.7.1 Cedimento
della parete addominale
Un primo
passo importante durante un attacco è il cedimento della muscolatura della
vita; è impossibile una corretta ispirazione a muscolatura ventro-lombale tesa.
Questo riesce meglio sdraiati sul ventre. Nella posizione seduta, in compenso,
aiuta la gravità che fa scendere l¹intestino, ma impedisce la posizione lombale
e spesso tirano le spalle ed il collo. La posizione ginocchia-gomito ha i
vantaggi dei due.
6.7.2 Stimolazione
del diaframma
Aumentando
la resistenza inspiratoria si provoca il diaframma a tirare di più: si inspira
e si espira formando una lieve resistenza con le labbra ³f...² con la punta
della lingua ³s...² o con la gola ³ch...² tentando di distendere lingua,
faringe e laringe. Il rumore in inspirazione può essere abbastanza acuto, in
espirazione è importante ³non espirare² ma lasciar sfuggire il fiato quasi
senza rumore.
6.7.3 Disinserimento
della respirazione pressata
Ogni
espirazione attiva è un errore cardinale. Ci vuole invece tanto esercizio per
non farlo, se deve funzionare anche durante un attacco:
- ³Lasciar
sfuggire² il fiato lentamente senza alcuna pressione di torace o ventre,
distenderli.
- Non
respirare profondamente, ma soltanto quanto ne richiede il corpo.
- La
resistenza provvisoria con le labbra di ³f² con la punta della lingua ³s² o
con la gola ³ch...² sposta la stretta respiratoria dalle corde vocali e le
libera spesso dallo spasmo.
-
Immaginarsi di muovere l¹aria solo ³in testa² dietro la stretta provvisoria
tenendo il tronco quieto e disteso.
Questo
trattamento di attacchi inizialmente è solo possibile con un massimo di
concentrazione in un ambiente indisturbato e possibilmente guidato dal
terapista. Col tempo si riesce da soli e diventa sempre più breve e facile,
fino al punto che diventa possibile in ogni posizione e senza interrompere
l¹attuale attività. Non disturba più di quel tanto (come se fosse un catarro di
un non asmatico). Con la coscienza di saper domare l¹attacco asmatico sparisce
anche il panico previsionale e gli spasmi aggiunti dall¹impotenza.
L¹obiettivo
a lungo è di poter gestire l¹asma senza medicamenti. Se e quando un paziente
volesse raggiungere questo obiettivo sono affari suoi. Obbligare è sempre
controproducente, ma in particolare con un asmatico sensibil e suggestibile è
del tutto negativo.
6.8 Altre
patologie trattabili con la terapia respiratoria funzionale
La
descritta terapia respiratoria funzionale si presta come supporto o
ricostituente a una gamma di altre patologie come per il trattamento di:
-
Deformazioni toraciche.
- Malattie
del naso.
- Malattie
cardiovascolari.
- Malattie
degli organi addominali.
- Sindrome
del Roemheld.
Per
dettagli consiglio di consultare l¹opera di PAROW.
Il testo stampato
(quaderno A5) è reperibile presso: LASER:
Mario Santoro
dtp@laser-fd.ch
Impressum
Relatore
Peter
Forster, medico naturista NVS, docente di ³Materia medica Popolare² e terapista
di tecniche corporee.
Bianca
Buser, terapista di tecniche corporee, terapia ortomolecolare, aromaterapia e
fitoterapia applicata.
Testo a
cura di
Benedetta
Ceresa, linfodrenaggio manuale e terapia dell¹edema, terapia ortomolecolare e
metodi naturali.
Responsabile
corso
Bianca
Buser 6953 Lugaggia, Svizzera Tel. & Fax: + 41 91 943 57 93
E-mail: bianca.buser@bluewin.ch
Segretariato
Sabrina
Bettosini (raggiungibile dalle ore 14.00) +41 79
423 82 71
Impaginazione
e stampa:
Laser -
Fondazione Diamante - Lugano
Anatomia & Fisiologia, 2 a Edizione ©2003 by P. Forster e B.
Buser Fr. 14.-
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |
|||||||


