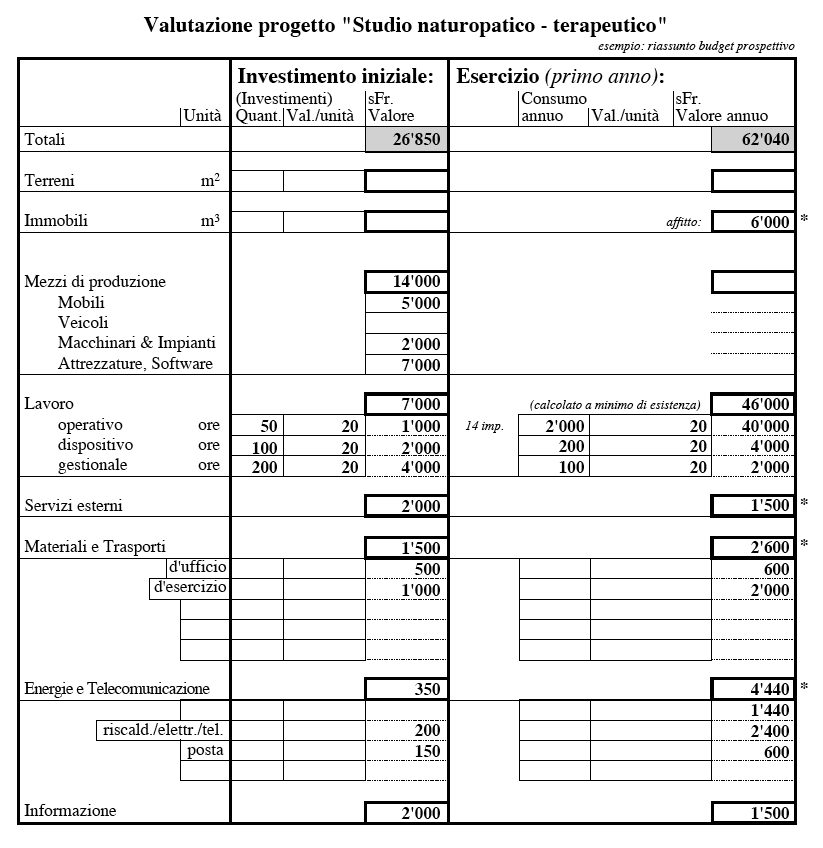|
|
Medicina popolareper autodidatti
luglio 27, 2005 |
|
Indice della pagina 4.0 Posizione della naturopatia sul mercato 5.0 L¹impresa sanitaria naturopatica 7.0 ³La creazione di un¹azienda nel Cantone
Ticino² 8.0 Esercizio di uno studio naturopatico |
MN 3.4 Nozioni
imprenditoriali
© Peter Forster Bianca Buser Pagine
correlate: MmP 4.4 |
Ho una visione sociale della mia
professione di medico naturalista e terapista come risposta alla situazione
insoddisfacente nel settore della sanità:
Aumentare la competenza
sanitaria individuale, specialmente delle mamme, per affrontare delle malattie
banali e piccoli disagi e ferite:
- in modo di scaricare la sanità
e i servizi pubblici dai relativi costi sanitari altissimi distribuiti in modo
solidale tra noi tutti.
- Divulgare così l¹esperienza
pratica della cura umana.
Per le nostre nonne era ancora
una conoscenza ovvia. È una perdita culturale non sapersi più arrangiare in
questi piccoli disagi della vita.
Rinforzare notevolmente le
professioni di ³artigianato medico², l¹uso di parola, rimedio e tocco come
strumenti terapeutici da parte di professionisti ³artigianali² come terapisti,
naturopati e medici naturali:
- A portata di mano di tutti a
prezzi modici.
- Per la consultazione e la cura
intensa di tempo per disagi che non richiedono necessariamente uno studio
universitario e investimenti rilevanti in attrezzature diagnostiche.
- Indipendenti da strutture
mediche pubbliche e private e da mediatori di mercato come le casse malati; una
sorta di ³medici scalzi² di una nazione moderna, industrializzata e ricca.
Nella mia regione di provenienza
(Svizzera orientale) questa tradizione, era ancora divulgata durante la mia
infanzia nelle figure dell¹infermiera e levatrice di paese e nel curatore; in
Germania è tuttora una rispettata professione quella dell¹²Heilpraktiker².
Ridurre l¹apparato sanitario
pubblico a modernissime strutture e infrastrutture efficacissime per eventi
clinici e ambulatori, acuti e cronici che richiedono l¹intervento di
universitari, specialisti e relativi mezzi intensi di capitale e di formazione.
Lasciare il resto a cliniche,
professori, correttori del mondo, a titolo privato auto regolandosi con i
loro clienti
Con questo spirito ho redatto il
seguente testo.
Il mercato sanitario Svizzero è
stimato a una cifra d¹affari di 42 miliardi di franchi annui, corrispondente a
fr. 7¹000.- annui pro capite o fr. 580.- mensili pro capite. Per una famiglia
di quattro persone corrisponde a fr. 28¹000.- annui o fr. 2¹320.- mensili.
Vengono trattati i seguenti temi:
2.2 Domanda e offerta sanitaria
Di questo ammontare ca. 16
miliardi (fr. 2¹700.- p.c.a. / fr. 225.- p.c.m.) sono obbligatoriamente
assicurati tramite le casse malati (obbligatori diretti) o provengono da
federazione, cantone o comune tramite tasse e imposte (obblighi indiretti). Per
una famiglia di quattro persone corrisponde a fr. 11¹000.- annui o fr. 900.-
mensili. Questa cifra è ritenuta politicamente e socialmente indispensabile per
un approvvigionamento sanitario base di una popolazione industrializzata ricca
come la Svizzera. Questa parte è regolamentata nella ³nuova legge malattie e
infortuni² federale, che funziona secondo criteri di solidarietà sociale
(contributo equo per tutti che deve coprire i differenti costi di ognuno). Le
casse malati in pratica li gestiscono in base alla legge. Sia le prestazioni
sia i diritti e obblighi materiali e ideali dei partecipanti (pazienti, casse,
strutture e operatori sanitari), sono dettagliatamente regolati. De facto si
tratta di un¹assicurazione sociale anche se gestita concorrenzialmente da
molteplici imprese private. In questo contesto le casse malati sono ³gestori di
beni pubblici².
I restanti 26 miliardi (fr.
4¹300.- p.c.a. / fr. 360.- p.c.m.) sono spesi o privatamente o tramite le casse
malati supplementari e private. Per una famiglia di quattro persone corrisponde
a fr. 17¹000.- annui o fr. 1¹400.- mensili. Questo settore non è
particolarmente regolato; fanno stato i codici delle obbligazioni e penale
nonché prescrizioni sull¹esercizio di professioni sanitarie e le leggi sui
medicamenti. Ma, con la nuova legge malattie e infortuni, questo settore è
completamente staccato dalla parte obbligatoria ed è diventato mercato libero
accessibile a ognuno.
2.2 Domanda e offerta sanitaria
Nella mia infanzia (anni cinquanta)
il mercato sanitario consisteva:
- Nel medico del paese vicino
per malattie e infortuni rilevanti.
- Ospedale nella città vicina
per le operazioni.
- Levatrice, infermiera e
curatore di paese per i casi meno critici acuti e le malattie croniche.
- Per casi un po¹ più difficili
o cronici ci si rivolgeva ad un naturopata nel vicino Cantone Appenzello.
- Si sapeva anche di qualcuno,
che era stato in una casa di cura per parecchio tempo per riabilitazione e di
un altro che aveva passato parecchio tempo in un sanatorio.
- Le ferite, danni e malanni
quotidiani e banali, erano curate e medicate da mamme e nonne e non
necessariamente dalle proprie, perché fra le donne c¹era parecchia
consultazione e assistenza.
Per problemi sociali,
relazionali, emotivi e spirituali serviva:
- Il manicomio in una cittadina
vicina per isolare i matti che non potevano stare a casa.
- Il prete fungeva da psicologo.
- Come psicoterapista una
qualche donna matura alla quale si chiedeva consiglio o gli amici con i quali si
dibatteva dei fatti comportamentali, ma tutto questo era ritenuto più sociale
che sanitario.
Gli anziani vivevano autonomi
finché ci riuscivano, spesso assistiti da una figlia celibe o, nella famiglia,
da un figlio. Se questo non era (più) possibile passavano il resto dei loro
giorni nella casa per gli anziani comunale. Questo, ancora meno era ritenuto
una faccenda sanitaria e spesso era un peso per ambo le parti, ammorbidito solo
dallo spirito di cristianità e dal rispetto per i genitori.
Sembra idilliaco a leggerlo
così, ma non lo era. Per i fortunati, potenti, autonomi, benestanti e bravi era
abbastanza soddisfacente, per i deboli, dipendenti, impotenti, poveri e
sfortunati era un giornaliero terrore di dover fare i conti con la grazia degli
altri, specie se quelli mettevano in atto la loro arroganza e disponevano di
scarse doti morali.
Per forza di condizioni
economiche, una grande parte di tutto questo era basato sull¹idea della
raternità. Nella misura in cui la fraternità fu sostituita dalle assicurazioni
sociali, queste strutture vennero modificate a favore dei meno fortunati e dei
disgraziati nei tempi cattivi. Perché si tratta di un mercato molto potente e
in forte crescita (per via dell¹evoluzione economica), oggi sono cambiate
radicalmente le strutture socio-economiche in merito. Abbiamo perso di vista,
quasi completamente, il fatto che tutto questo è finanziato esclusivamente dai
soldi di noi tutti che avanzano dalle necessità esistenziali. Almeno il
legislatore ha dei criteri chiari: il consenso sociale praticato circa malattie
e infortuni si limita espressis verbis alle cure che ristabiliscono la capacità
di autosufficienza e di abilità lavorativa. Per tutto il resto è responsabile
il singolo cittadino a proprie spese e con proprie competenze.
Vengono trattati i seguenti
temi:
2.2.3 Casse malati
(mediatori di mercato)
Utente
di prestazioni sanitarie è tutta la popolazione Svizzera, ca. sei milioni di
abitanti.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
2.2.1.1 Esigenze
dei consumatori sanitari
2.2.1.2 Finanziamento
di spese sanitarie
2.2.1.3 Aspettative
sanitarie della clientela
2.2.1.1 Esigenze dei consumatori sanitari
I
consumatori di prestazioni ³sanitarie² pretendono che sia retribuito tutto
quello che secondo il loro parere:
-
Potrebbe diminuire i loro disagi quotidiani (acuti e cronici).
-
Potrebbe prevenire futuri disagi (prevenzione).
-
Potrebbe ripristinare conseguenze di disagi passati (riabilitazione) siano
questi disagi motivati biologicamente, emotivamente o socialmente.
Esigono
inoltre:
-
Di mantenere e migliorare le capacità vitali (igiene, dietetica, tenersi in
forma, svaghi fisici, psichici, spirituali).
-
Formazione sociale, assistenza, custodia, tutela, cultura, manutenzione,
amministrazione delle più varie sfaccettature di una vita ricca, comoda e
annoiata.
-
Raggiungere la vita eterna prima della morte.
-
In piena capacità fisica, mentale e sociale.
-
Preferibilmente
non a proprie spese.
2.2.1.2
Finanziamento di spese sanitarie
È
fuori discussione che tutto questo è auspicabile per tante persone, ma che sia
retribuito da soldi pubblici (di noi tutti in modo solidale) non è mai stato
deciso democraticamente. Ricordo di nuovo che il patto sociale di solidarietà
si riferisce a cure che ristabiliscono la capacità di autosufficienza e di
abilità lavorativa. Il consumo di altro a spese pubbliche è semplicemente
parassitario e asociale.
Il
legislatore prevede di garantire a tutti un approvvigionamento base
medicosanitario degno di una nazione moderna, ricca e industrializzata. I
relativi diritti sulle prestazioni, sono meticolosamente descritti nella nuova
legge malattia e infortuni. È obbligatoria l¹ammissione a una cassa malati. A
chi dispone di un reddito sotto un certo limite, il relativo contributo viene
restituito dal comune.
Rimane
la completa libertà di assicurarsi ulteriormente per prestazioni supplementari
o per ³cura privata² a proprie spese o di consumare ulteriori servizi,
prestazioni e prodotti ³sanitari² a proprie spese.
2.2.1.3 Aspettative sanitarie della clientela
L¹utente
si aspetta dalla ³sanitಠche lo porti da uno stato di disagio a uno di salute
e che lo mantenga in questo stato:
Disagi:
Agio
(³salute²):
-
dolore* -
benessere
-
lesioni*, impedimenti*
- autosufficienza*, capacità lavorativa*, integrazione
-
depressioni -
voglia di vivere
-
ansia -
sicurezza
-
irrequietudine
- successo
-
disperazione -
progettualità
-
scombussolamento -
equilibrio interno tra eccitazione e rassegnazione
-
impotenza, dipendenza -
competenza, autonomia
*
dominio di sanità pubblica solidale.
Un
breve confronto dimostra che la sanità non vuole e non può creare queste
trasformazioni. Al massimo può tentare di partecipare all¹assenza dei disagi.
Ma
le esigenze occulte vanno più in là: belli, snelli, dinamici e lucidi in
eternità (dice il mio amico farmacista).
È
evidente che desideri, esigenze e domande di questo tipo provenienti inoltre da
un pubblico benestante richiama un¹offerta spietata, perché di questa dolce
torta tanti vogliono assicurarsi una fetta.
Gli
offerenti di servizi, prestazioni e prodotti che promettono la liberazione dai
disagi e/o il benessere si servono dell¹altissimo prestigio sociale di valori
come ³sano², ³salutare² e così via come mezzi propagandistici per vendere le
loro attività. Non centra poi se sono professori universitari o guaritori da
paese. La loro reputazione si basa comunque sulla superstiziosa stima sociale
³di chi toglie disagio e ti mette al tuo agio²; e chi di reputazione non ne ha,
sfrutta la stima degli altri per vendere anche la sua attività.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
2.2.2.1 Definizioni
e delimitazioni sanitarie
2.2.2.2 Definizioni e delimitazioni ³naturopatiche²
2.2.2.3 Imposture d¹etichetta e successo economico
2.2.2.4 Discorsi
di comportamenti parassitari
2.2.2.6 Terapisti
dipendenti dalle casse
2.2.2.7 Liberi
terapisti e naturopati
2.2.2.1 Definizioni e delimitazioni sanitarie
Le
delimitazioni tra:
-
sanitario acuto e cronico (autosufficienza, capacità lavorativa),
-
terapeutico acuto e cronico (liberazione di disagi, aumento delle capacità,
diminuzione dei limiti),
-
riabilitativo (ripristinare delle capacità),
-
preventivo (evitare disagi),
-
conservatore (manutenzione di capacità),
-
(in-)formativo (istruzione per autocura),
-
consultivo (dialogo comportamentistico),
-
evolutivo (divulgazione di idee, concetti, spirituali, esoterici, filosofici
per l¹autorealizzazione), si trovano vaghi e confusi in un grande stagno di
qualunquismo, trattandosi poi di argomenti biologici, emotivi, psichici,
relazionali, sociali, spirituali, rende indecifrabile il miscuglio. È
evidente che in un essere umano è da rispettare tutto questo, ma sommato sotto
il criterio di ³sanità, cura, terapia² serve solo a coloro che pescano in
questo scuro stagno.
Essendo
in senso vasto collegato un po¹ tutto con ³la salute² anche offerte per igiene,
estetica, fitness, wellness, dietetica come d¹altronde servizi consultivi spirituali,
esoterici, new age, psicologici e così via, anche operatori di questi mestieri
vengono annoverati tra i ³terapisti².
2.2.2.2
Definizioni e delimitazioni
³naturopatiche²
Come
medico naturalista e terapista mi distanzio da queste interpretazioni perché
l¹accento del mio lavoro è indirizzato direttamente a:
-
Autosufficienza e capacità lavorativa.
-
Liberazione di disagi che impediscono questa autosufficienza.
-
Aumento di capacità elementari vitali.
-
Diminuzione di limitazioni esistenziali biologiche.
-
Ripristino di abilità vitali in un contesto biopsicosociale.
Tutto
il resto farà anche parte del mio lavoro ma in secondo piano e nel contesto del
quadro cui sopra.
Parlando
di seguito di ³terapista² mi riferisco a questo concetto professionale ed
escludo attività riferite prevalentemente ad altri obiettivi.
2.2.2.3 Imposture d¹etichetta e successo
economico
Come
illustrazione un esempio.
Anni
fa mi fece visita una futura collega terapista per consultarsi circa le
attività ³terapeutiche² poiché voleva crearsi un¹attività indipendente nel
ramo.
Fra
noi si svolse, più o meno, il seguente dialogo:
Io Lei
-
³Allora, tratti disturbi motori con massaggi, ?² ³Mi
fa schifo toccare certe persone!²
-
³Almeno calmi i relativi dolori?² ³Non
saprei come!²
- Quindi sei specializzata sulla digestione
o la respirazione o
la circolazione?² ³Ritengo
troppo rischioso curare gli organi!²
-
³Allora tratti disturbi neurovegetativi di impiegati e artigiani?² ³Non me ne intendo!²
-
³Curi i disagi della senescenza?² ³Non
mi ispirano troppo le persone vecchie!²
-
³Allora ti dedichi ai bambini con i loro
disturbi di crescita e le
allergie?² ³I
bambini rompono!²
-
³Fai bene a dedicarti alle casalinghe stressate e frustrate!² ³Mi
danno sui nervi!²
-
³Quindi dai conforto alle ricche,
annoiate nevrotiche signore per
bene!² ³Che
dio mi salvi!²
-
³Rimangono emarginati e alternativi con i loro
molteplici disagi complessi?² ³Cosa
mi proponi, non hanno mai soldi!²
Rimasi
perplesso: ³Allora vuoi curare i sani, belli, spiritosi benestanti che non
rompono più di quel tanto. Scusami, ma pensavo che fosti terapista!² ³Sono
terapista e mi farò la mia clientela!². Aveva ragione; lo è diventata e se lo
scrive anche sul suo biglietto da visita. Ha notevole successo materiale e di
reputazione e anche se abbiamo dei concetti diversissimi mi ha insegnato i
criteri del suo successo:
-
Il cliente deve essere sano (capacità lavorativa, autosufficienza), solvibile e
almeno un po¹ simpatico.
-
Torna molto utile la sua paura di non essere all¹altezza, di invecchiare, di
ammalarsi, di morire; queste condizioni non devi assolutamente tentare di
modificarle, se lo fai, va a tue spese e li perdi, perché vanno dallo
psicoterapista.
-
Un po¹ di paranoia, misantropia, ipocondria, megalomania e superstizione aiuta
anche, basta tenerle sotto controllo al punto che il soggetto non diventi
troppo asociale (perdi il cliente che va dallo psichiatra).
-
Si deve sentire valutato per le sue doti e non preso sul serio nei suoi ³danni
e malanni² quotidiani del suo ambiente sociale. Anche questa condizione è
meglio (per te) mantenerla.
-
Ascolti bene le sue ultime scoperte e fai una ³diagnosi² al massimo
semplificata (ogni volta un¹altra), preferibilmente una che attualmente è di
moda in televisione.
-
Proponi come cura degli esercizi che non esegue (tanto sono noiosi e/o
impegnativi) ma che gli dimostrano che è o colpa sua o di un inconveniente o
avversario (a seconda del caso) se non guarisce. Vanno bene anche rimedi innocui,
solo che si può colpevolizzare meno il cliente, meglio sono quelli del tipo che
danno i primi effetti solo a lungo termine.
-
Così perpetui il suo disagio (per niente esistenziale poi), lo fai resistente a
terapie (non avvenute), lo rendi dipendente del tuo servizio.
-
Bastano pochi clienti fedeli ben scelti di questo genere e ti sei fatto
un¹assicurazione vita.
2.2.2.4 Discorsi di comportamenti parassitari
Inizialmente
ero scioccato da un approccio così cinico, ma forse era solo invidia da parte mia
e mi sono reso conto che tanti medici non fanno altro e che le relazioni
private altrui (anche se terapeutiche) non sono cavoli miei. Ognuno è libero di
scegliersi il suo terapista e il suo cliente e di stabilire il rapporto da
avere con lui (anche economico). Il discorso morale non regge se tutti e due
sono adulti, vaccinati e responsabili delle loro mosse.
L¹unica
cosa che non mi andava in realtà, era che una cassa malati finanziasse con
soldi pubblici (anche miei) questi (per me strani) rapporti. Ma questo problema
a livello naturopatico è quasi completamente risolto con l¹applicazione della
nuova legge che tali prestazioni non include più nelle tariffe obbligatorie e
quindi non si tratta più di soldi ³miei² (che sono assicurato in comune).
A
livello di medici approvati invece non è risolto per niente: chissà quanti
rapporti ³terapeutici² del genere sono sostenuti in un mercato dove per 270
persone c¹è un medico, e tutti vogliono vivere e bene. Il rischio che proprio i
medici di scarsa capacità si impadroniscono di questo tipo di clientela a spese
pubbliche (e anche mie) è abbastanza elevato. E non saprei come possa essere
controllato.
Tradizionalmente
l¹offerta sul mercato sanitario è (o era) organizzata sul modello delle corporazioni
medioevali e congiunta ad accordi con le casse malati e a leggi sanitarie
restrittive si è formata una sanitocrazia di carattere monopolistico da parte
dell¹offerta e una mentalità di tutto dovuto da parte degli utenti. Questo
causava non solo un¹esplosione di spese sanitarie ma anche un gonfiamento di
offerta a tutti i livelli: professionisti, strutture, attrezzature, materiali,
medicamenti,
Momentaneamente
ci troviamo a un punto in cui non possiamo più permetterci queste spese
sanitarie (o solo alcuni e gli altri non intendono pagare per questi).
Naturalmente sono tutti coinvolti: offerenti di prestazioni, servizi e prodotti
sanitari e si battono disperatamente per recuperare i loro privilegi
precedentemente raggiunti a spese della comunità.
2.2.2.6 Terapisti ³dipendenti dalle casse²
Per
i miei colleghi abituati a collaborare con le casse malati prevedo un futuro
arido:
-
Le casse malati modificheranno le condizioni di ammissione sotto la pressione
dei costi. Questo andrà a scapito dei deboli partecipanti, cioè paramedico,
naturopata, terapista fino a livelli irragiungibili o di modesti contributi che
coprono a malapena gli elevati costi. Inoltre, ognuno sarà in concorrenza con
il collega ³libero professionista² che non ha questi aggravi.
-
I clienti del tipo ³tutto dovuto² (che poi non guariscono mai ed erano come
³assicurazione vita²), o non sono disposti a pagare privatamente o non se lo
possono più permettere.
-
L¹altra clientela è poi più critica e sa valutare molto bene, se la cura vale i
soldi pagati di propria tasca.
-
Il passaggio dal ³terapista dipendente dalla cassa² al libero professionista è
difficile perché si tratta di un¹altra clientela da trattare diversamente e
spesso già ³piazzata² presso altri liberi terapisti, visto che si tratta di
relazioni terapeutiche di grande fiducia e rapporti umani che non sono
trasferibili a volontà da una persona all¹altra.
2.2.2.7 Liberi terapisti e naturopati
Per
me, come naturopata e terapista, è evidente che non devo preoccuparmi dei 16
miliardi obbligatori, per questa torta ci sono oltre alle troppe restrizioni
anche troppi offerenti che si battono per una loro fetta insistendo su
strutture inefficaci e prezzi smisurati. Invece per i 26 miliardi di potenziale
di mercato ³ausiliario² sono abbastanza vantaggiato:
-
Organizzandomi bene non dipendo della sanitocrazia ma posso collaborare a
necessità con il miglior offerente fornitore di prestazioni, servizi e prodotti
e anche lui è fuori dalle restrizioni monopolistiche.
-
Non ho da temere che ogni diversa cassa malati mi detti annualmente legge e
condizioni dispotiche che possono mettere in pericolo la mia esistenza
professionale.
-
Non avendo l¹amministrazione che la sanitocrazia e le casse malati richiedono
mi risparmio tanti costi e altri impegni del genere.
-
Non dovendomi attenere a tariffe o altri patti monopolizzanti posso adattare la
mia attività con flessibilità alle esigenze della mia clientela.
-
Tutto questo e altro mi garantisce vantaggi imprenditoriali che i partecipanti
alla sanitocrazia non possono avere e che influiscono notevolmente sulla
relazione tra prestazione, prezzo e qualità della mia opera.
2.2.3 Casse malati (mediatori di mercato)
Le casse malati come imprese assicurative hanno da una parte l¹onere di gestire i 16 miliardi di assicurazione obbligatoria, e con questi non fanno grandi affari, visto che c¹è da una parte una regolamentazione dettagliata e dall¹altra parte una gran concorrenza tra loro. Devono quindi tentare per forza di assicurarsi una fetta rilevante dei restanti 26 miliardi con tutti i mezzi di marketing di un¹assicurazione moderna.
Hanno la
difficoltà che non si tratta più dell¹esigenza base indispensabile sanitaria ma
di lusso sanitario. E quale persona sana di mente assicura il diritto sul
lusso: se se lo può permettere, non deve assicuralo, e in caso contrario, non
avrà i soldi neanche per i premi, visto che in questo settore i conti dovranno
tornare per tutti. Inoltre le casse si sono alleate ai fornitori sanitari più
cari (partecipanti alla sanitocrazia) e con il potere finanziario che hanno
comunque dalla gestione dei soldi della parte obbligatoria dettano legge ai
loro alleati produttori di prestazioni sanitarie (operatori medici, paramedici,
farmacisti, strutture sanitarie). L¹unica categoria, veramente fuori e libera,
è quella dei dentisti.
Personalmente
non comprerei azioni di una simile impresa e meno ancora mi metterei alle
dipendenze di un simile padrone: meglio fallire per i propri errori.
Per
l¹informazione del cliente nonché per la nostra distinzione naturopatica sul
mercato della sanità, è dovere di un naturopata conoscere a fondo il
funzionamento, la struttura e i punti deboli e forti dell¹attuale
organizzazione delle casse malati e sulla legge assicurazione malattie. Un
testo esauriente e affidabile è:
Krankenversicherung;
Beobachter-Buchverlag; Zürich 1998
Malauguratamente
il testo è reperibile solo in tedesco.
Il terapista che dispone di più
o meno strumenti operativi, li applica naturalmente in modo individuale,
adattandosi alla clientela che ha, e agli obiettivi ³terapeutici² che si
pongono lui e la sua clientela:
3.2 b) ³Fitness²
(essere in forma)
3.5 e) Disturbi
psicosomatici acuti
3.6 f) Malattie
e impedimenti acuti
3.7 g) Malattie
croniche e degenerative
3.8 h) Sollievo
in situazioni ³disperate²
L¹elenco rende nota la diversità di obiettivi, approcci, esigenze e desideri. Sarà improbabile che un terapista abbia una clientela che comprende tutta la gamma. È anche razionale pensare che non esista un metodo (strumento) unico per soddisfare tutte queste esigenze.
Personalmente ho una maggioranza
di clienti del settore g) ³Malattie croniche e degenerative² e pochi del
settore d) ³Fasi di riorientamento², e) ³Disturbi psicosomatici² e h)
³Situazioni disperate².
Dei primi tre settori
³Lifestile, Fitness, Wellness² non me ne occupo perché mi mancano strumenti e
voglia, e nel settore f) ³Malattie e impedimenti acuti² sono una frana, anche
se ho imparato tecnicamente come fare.
I primi tre settori (lifestile,
fitness, wellness) secondo i miei criteri non sono ³terapie². Sono socialmente
rilevanti nella nostra cultura, un grande mercato e un ricco e importante campo
d¹impiego per chi vuol praticare in quest¹ambito. Ma non dovrebbe chiamarsi
³terapia² perché non tratta ³ammalati², anche se spesso si incontrano sintomi
sociali, psichici e anche somatici tra i clienti coinvolti.
I due settori seguenti (fasi di
riorientamento e disturbi psicosomatici acuti) si rivolgono prevalentemente a
una clientela con disturbi che Freud ha descritto in modo geniale nel suo
saggio ³Il disagio nella cultura² e Grossarth-Maticek ha classificato bene nei
tipici meccanismi comportamentistici.
Mostrano spesso dei sintomi
neurovegetativi, ma secondo i miei criteri sono piuttosto soggetti di socio- e
psicoterapie che di naturopatia e di terapie corporee.
Naturopatia e terapie corporee
(o manuali) si rivolgono prevalentemente a clienti degli ultimi tre settori.
Questo non vuol dire che siano
esclusi elementi sociali, relazionali, emotivi; anzi, ma l¹esperienza mi
insegna che è più frequente la depressione per via di stati ormonali instabili,
la disperazione per via di continui dolori reumatici e stati di panico per
traumi subiti che viceversa.
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se fa piuttosto lavoro di ³lifestile²
per i ricchi annoiati e belli perché è di moda o prevalentemente ³estetica² per
motivi di gusto, voglia, svago o divertimento. Questa fetta di mercato è
dominata da clienti della media borghesia giovane e di mezza età (più donne che
uomini) relativamente benestante. Richiede uno studio in zona adatta, formazione
impressionante di tanti diplomi, arredamenti decenti ma cari e asettici,
strumenti e attrezzature moderne e atteggiamenti distanziati. Conviene tenersi
continuamente informato su cosa è ³in², specialmente nel settore sanitario.
3.2 b) ³Fitness² (essere in forma)
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se fa lavoro di ³fitness² per i
dilettanti sportivi e altre persone che intendono così affrontare meglio una
vita ³combattiva². La clientela è giovane lavorativa e sportiva (quasi equa tra
uomini e donne). Lo studio deve essere moderno e chic, strumenti e attrezzature
di ultimo grido e gli atteggiamenti sportivi, diretti, aperti e cordiali.
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se fa piuttosto lavoro di ³wellness²
per chi intende trattare bene il suo corpo in senso preventivo augurandosi di
star bene fino alla morte e di soffrire meno possibile o per chi ha un tale
terrore della vecchiaia e della morte che cerca di far tutto giusto per essere
più sano. La clientela è normalmente di mezza età, più donne che uomini, anche
coppie di piccola e media borghesia, quadri medi e indipendenti di istruzione
superiore.
Studio e
arredamento devono essere solidi e asettici. La formazione basata
sull¹esperienza e/o la tradizione, con spiccate capacità di ragionamento
medico-tecnico, strumenti e attrezzature funzionali e gli atteggiamenti di
educazione e di buone maniere. Niente di alternativo!
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se accompagna fasi transitorie nella
vita del cliente spesso legate anche a cambiamenti neurovegetativi, emotivi,
relazionali sociali e spirituali. Questa clientela può essere di qualsiasi
provenienza.
-
Si tratta maggiormente di donne intorno all¹età della menopausa, spesso con
figli che si staccano dalla famiglia e che vogliono dare un¹altra direzione
alla loro vita o cercano nuovi campi di attività o intendono realizzare dei
lati che hanno sognato da tanto ma erano impediti fin¹ora a causa dei loro
impegni famigliari.
-
Sempre di più si tratta anche di donne che subiscono crisi relazionali per il
pensionamento del loro marito o perché annoia con i capricci della sua seconda
primavera.
-
Ogni tanto sono anche adolescenti con i loro tipici problemi, spinti dalla
madre.
-
Quasi tutti cercano una dimensione ³spirituale² molto vaga. Arrivate all¹ultimo
terzo di una vita materialmente garantita, amano immaginarsi contemplative,
serene, ponderate, armoniose, solo che mancano loro dei modelli e il saper
fare. Vogliono curarsi e trattarsi bene.
Lo
studio e l¹arredamento per questi clienti deve essere accogliente, caldo e
famigliare. La formazione è meno importante a loro ma richiedono esperienza di
vita e naturale autorità morale, etica e spirituale. Si sentono molto attratti
da filosofie esotiche e da movimenti alternativi, basta che non abbiano niente
di socialmente estremo (mette in pericolo la loro sicurezza materiale così
duramente raggiunta).
3.5 e) Disturbi psicosomatici acuti
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se ha una clientela con cronici
problemi emotivi, relazionali, sociali e relativi sintomi somatici. Possono
essere di ³atteggiamento²:
-
Pacifico-positivo-inibito o bloccato (tendenzialmente afflitto da neoplasmi).
-
Scontroso-negativo-irritato o ambivalente (tendenzialmente afflitto da
patologie cardiovascolari).
-
Egocentrico-maniacale o depressivo (tendenzialmente afflitto da reazioni
psicotiche con patologie neurocardicache o isolazione-depressione con diverse
patologie somatiche).
-
Razionale-antiemozionale-impassibile o disinibito (tendenzialmente afflitto da
psicosi endogene in forme maniacali o depressive con patologie somatiche di
diverso tipo).
-
Narcistico-diffidente-irascibile o sovversivo (tendenzialmente afflitto da
poli-tossicodipendenza e aggressione aperta o occulta e patologie gastriche e
dermiche).
Comune
a tutti loro è:
-
che sono incapaci a crearsi autonomamente delle situazioni, condizioni e
relazioni nelle quali stanno bene e che possono godere e
-
che sono altrettanto incapaci di evitare o troncare delle situazioni,
condizioni e relazioni che li fanno star male.
Finché
gli altri stanno più o meno al loro gioco (situazione compensata) riescono a
gestirlo con tanti trucchi, compromessi e scostamenti, cognizione selettiva e
giustificazioni, quando diventa troppo (fase decompensata), crolla
l¹autoregolazione e si istaurano sintomi acuti psichici, sociali e relazionali
abbastanza pesanti. La tendenza è di ³somatizzare² lo stress cronico della fase
compensata sull¹organo o il sistema debole del loro organismo.
Questa
clientela si trova in tutta la popolazione, anche se la cronificazione
(disturbi somatici cronici) si evolve solo dalla mezza età fino alla senescenza
e sono o erano normalmente in psicoterapie. Al naturopata si rivolgono
soprattutto le donne. Lo studio e l¹arredamento come anche la formazione del
terapista sono a loro avviso di secondaria importanza. Richiede da parte del
terapista parecchia conoscenza psicoterapeutica per non lasciarsi coinvolgere
nei loro abituali giochi relazionali inconsci. La terapia può basarsi
prevalentemente o sul tocco o sulla parola o sul rimedio, ma normalmente
richiede una combinazione sensata dei tre almeno in fase acuta.
3.6 f) Malattie e impedimenti acuti
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se si è più concentrato su una
clientela con ³impedimenti acuti² che intendono essere ³riparati efficacemente²
al più presto possibile senza approfondire le cause.
In
questo gruppo si tratta di una clientela con recidive di disturbi dell¹apparato
motorio o di altri organi. Questo settore è piuttosto complementare o
sostitutivo al medico di condotta di una volta: il cliente si fa curare da
³minori danni e malanni² e ogni tanto si fa un ³controllo² o una ³spolverata².
La
clientela è composta per lo più da impiegati, artigiani e operai con relazioni
abbastanza ³biologiche² verso il loro organismo e un acuto buon senso per la
vita e l¹economia. Si trovano bene in uno studio ³famigliare², né alternativo,
né chic né troppo asettico né troppo caro. Dal terapista pretendono che sia un
bravo artigiano con solide conoscenze mediche.
3.7 g) Malattie croniche e degenerative
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se tratta una clientela con malattie
croniche e degenerative prevalentemente dell¹apparato motorio ma anche di altri
organi. Spesso si tratta di una clientela:
-
del tipo e) ³disturbi psicosomatici² che è riuscita abbastanza bene a gestire
un atteggiamento ³frustrante² senza lampanti disturbi psichici per lungo tempo
fino alla cronificazione di relativi disturbi somatici.
-
Altre volte simili sintomi sono causati da fattori costituzionali o
-
da disturbi metabolici subclinici o
-
da abitudini di vita che creano tali disturbi, ma normalmente si tratta di una
combinazione di tutti questi fattori. Normalmente sono clienti angosciati e
scoraggiati, se non rassegnati, da tentativi sanitari precedenti senza esito.
Si tratta per lo più di donne sopra una certa età che non pretendono un gran
che di arredamento e diplomi ma la capacità terapeutica di calmare i dolori e
mitigare impedimenti e quella umana di prenderle sul serio e di dar loro una
progettualità.
3.8 h) Sollievo in situazioni ³disperate²
L¹operatore
sanitario avrà questo tipo di clientela, se si dedica di dar sollievo (anche se
solo palliativo) a chi soffre di ³brutti danni e malanni² o impedimenti. È una
clientela eterogenea che ha bisogno di dedica perché colpita dal destino con
brutte prognosi e ogni tanto anche di isolamento sociale, vicini più impacciati
di loro e spesso anche disagi fisici. È un compito nobile per un terapista,
fare anche questo lavoro (almeno ogni tanto), per non dimenticarsi che, alla
fine di tutti i nostri sforzi, c¹è questa situazione. Meglio prepararsi,
professionalmente e umanamente, prima che capiti all¹improvviso.
4.0 Posizione della naturopatia sul mercato
Vengono trattati i seguenti
temi:
4.1 Paragoni tra Ticino e altri paesi
4.2 Posizione
del singolo naturopata
4.3 Errori da principianti e brutte abitudini
4.1 Paragoni tra Ticino e altri paesi
Nella Svizzera italiana, la
nostra professione ha poca tradizione, contrariamente a certi cantoni della
Svizzera interna e specialmente alla Germania, dove la professione di
³Heilpraktiker² (naturopata, medico empirico, guaritore, esperto di guarigione)
fa parte della ³sanitಠriconosciuta come professione indipendente, con
relative formazioni, esami e approvazioni sin dall¹inizio del 900. I
naturopati tedeschi servono una clientela più o meno del seguente tipo:
- Persone scettiche verso
consultazioni di ³universitari² per i banali danni e malanni quotidiani.
- Tradizionalisti, che si fidano
più del medico naturalista che dell¹universitario e che trovano esagerato
l¹impiego di tanti mezzi, per disturbi che la nonna curava con strumenti
casalinghi.
- Persone che cercano
consultazioni igieniche, dietetiche, preventive, complementari e alternative
alle proposte abituali dall¹esperto di guarigione empirico, perché intendono
loro stessi condurre una vita ³sana² e meno rischiosa.
- Persone frustrate
dall¹esercizio medico abituale, specializzato e privo di dedizione (per via dei
costi e degli orari).
- Persone resistenti ad altre
terapie, specialmente con disturbi e malattie croniche e disturbi
socio-psicosomatici.
- Persone con un quadro della
vita ³magico² che cercano in fondo la fata turchina che li libera di colpo da
tutti i loro disagi.
- Persone affette da malattie
con ³brutte prognosi² che si aspettano sollievo o guarigione dal curatore
alternativo
Tanto per dare un¹idea di come
potrebbero essere delle pretese sociali.
Fino agli anni ¹50, gli
³Heilpraktiker² erano un po¹ i figli poveri della medicina. Questa reputazione
in Germania, è cambiata parecchio negli ultimi vent¹anni in quanto:
- La competenza
dell¹²Heilpraktiker² è notevolmente aumentata grazie al facilitato accesso (non
universitario) alla materia medica e relativi strumenti, aggeggi e rimedi.
- I costi sanitari sono
diventati un grosso peso sociale, non da ultimo sostenuto da una
specializzazione medica, da esigenze amministrative e da diminuita dedica al
cliente, in assoluto contrasto alle pretese del ³consumatore sanitario².
- Sempre più medici devono dividersi una clientela stagnante che esprime delle esigenze abbastanza diverse dall¹offerta medica.
- Il potere finanziario delle
assicurazioni sociali sostiene delle cure economiche ed efficienti,
indipendentemente da chi li esegue.
- Un ramo della medicina
universitaria basata sull¹evidenza (empirico) ha guadagnato terreno e mitiga
parecchio i vecchi confronti tra empirismo e ideologia medica.
Tutto questo a lungo
significherà una concorrenza in questo settore tra medici universitari e medici
naturali (finché non si formano eventuali delimitazioni). Se ci sarà
collaborazione (ed esiste tutt¹oggi), tali deliminazioni saranno
indispensabili.
Dove si troverà il nostro
settore in Ticino e in una futura Europa è difficile da prevedere. Dipenderà
soprattutto dalla nostra capacità terapeutica con le relative prestazioni,
servizi e rimedi, dall¹esito (anche economico) delle nostre cure e dalla
capacità di soddisfare le esigenze della nostra clientela e di rispondere alle
loro aspettative.
4.2 Posizione del singolo
naturopata
Per il singolo naturopata è
importante posizionarsi sul mercato con:
- Programma
(diagnostico,consultativo, terapeutico, preventivo, igienico, ).
- Concernente frequenti disturbi
(motori, nervosi, circolatori, metabolici, ormonali, ).
- Rivolto ad un pubblico
definito (bambini, adolescenti, lavoratori, anziani).
- Di determinati giri sociali
(docenti, impiegati di stato, casalinghe, pensionati, artigiani, impiegati
d¹ufficio, ).
- In secondo tempo, con
un¹offerta chiara di prestazioni, servizi e rimedi, previsioni in tempo e soldi
e obiettivi terapeutici.
4.3 Errori da principianti e brutte abitudini
I principianti in materia,
sbagliano quasi sempre mettendo in rilievo le loro capacità tecniche e di
formazione. Se questo interessa qualcuno, allora solo in un secondo o terzo
tempo:
- Il cliente ha mal di testa o
mal di schiena e si aspetta un professionista che sappia mitigare i suoi
dolori. Gli interessa quale sia il suo impegno in tempo e soldi.
- In secondo luogo gli interessa
che il terapista parli il suo linguaggio, rispetti (non necessariamente divida)
il suo approccio al mondo e alla vita nonché il suo disturbo, lo metta a suo
agio, guadagni la sua fiducia per parlare di cose sue e lasciarsi toccare, e
che ispiri l¹aspettativa che possa aiutarlo.
- Solo in terzo luogo, più a
titolo di curiosità, forse si vuol informare con quali strumenti, rimedi e
servizi il terapista intende affrontare il suo disagio e che competenza possa
avere in merito.
Il secondo errore del
principiante in merito è di offrire troppe prestazioni e servizi nella
comprensibile premura di coprire una ³grande fetta di mercato² con un vasto
pubblico di potenziali clienti: non ispira fiducia professionale, anzi. È meglio
concentrarsi e avere (a sorpresa del cliente) ancora alcune frecce in faretra.
Più tardi, e a controllo di successo, si può sempre ampliare.
Una brutta abitudine
(proveniente da scuole esoteriche, di New Age, spirituali, ) è quella di
mescolare ³terapie² di gruppo e individuali, esercizi, insegnamento, formazione
spirituale e così via.
- La relazione terapeutica
(integrante) è fondamentalmente diversa da una relazione didattica
(differenziante).
- Il lavoro di gruppo (basato su
posizioni, ruoli, sociali) è estremamente contrastante al lavoro individuale
(basato su fatti biologici e situazioni psichiche bilaterali e individuali).
- Essendo ³un paziente² per
definizione uno che non sa gestire bene dei contrasti (li subisce più o meno
pazientemente), è antiterapeutico sottometterlo a bagni alternati e confonderlo
e stressarlo ancora di più, non è così che si cura (forse si insegna così o si
diventa guru).
- Capisco (perché la tentazione
ogni tanto è anche mia) che un nuovo istruito addetto all¹arte, voglia colmare
il proprio entusiasmo convincendo il resto del mondo delle sue scoperte; ma non
è una buona idea terapeutica (anche se una umanamente simpatica debolezza): si
risponda alle domande che pone il cliente e non a quelle non chieste (consiglio
imperativo di mia nonna). Per
questa esigenza si cerchi un altro foro e un altro pubblico.
5.0 L¹impresa sanitaria naturopatica
Vengono trattati i seguenti
temi:
5.1 Definizione dell¹impresa sanitaria
5.3 Modello
relazionale-funzionale
5.4 Coinvolgimenti e relazioni
5.5 Compiti, responsabilità e competenze
5.1 Definizione dell¹impresa sanitaria
³Un¹impresa è un costrutto
sociale con lo scopo di produrre dei beni² (definizione degli studenti di
economia).
Un¹azienda sanitaria:
- nasce, innanzitutto, come
risposta a delle esigenze ³di salute² di un pubblico,
- offre dei servizi sanitari che
tenta di svolgere in modo economico,
- rispettando le norme dettate
dalle autorità, in un mercato sanitario di offerenti e acquirenti.
Al centro delle attività si
trovano quelle di servizio sanitario qualunque siano. Per svolgere
questo, necessitano attività di
esercizio dall¹organizzazione fino alla contabilità.
Per le sue attività (di servizio
e di esercizio) un¹impresa si serve dei seguenti strumenti:
- Capitali investiti in proprio
o in affitto.
- Materiali usati per il
servizio e l¹esercizio.
- Lavoro di servizio e di
esercizio.
- Organizzazione di servizio e
di esercizio.
5.3 Modello relazionale-funzionale
Ciò richiede, fra l¹altro,
molteplici relazioni formali ed informali tra tutte le parti coinvolte. Le
relazioni vengono regolate (organizzate), al fine di poter arrivare a
soddisfare i principi economici.
L¹attività dell¹impresa
sanitaria è basata principalmente sulle relazioni fra le persone e istituzioni
che svolgono varie funzioni nell¹ambito seguente:
5.4 Coinvolgimenti e relazioni
Le funzioni aziendali richiedono
relazioni tra tutte le persone, gli enti e le imprese coinvolti:
Clienti e collaboratori della
società.
Fornitori e collaboratori
della società.
Autorità regionali, statali e
collaboratori della società.
Associazioni professionali e
collaboratori della società.
Ev. casse malati e
collaboratori della società.
Ev. altre imprese sanitarie e
collaboratori della società.
Ev. servizi esterni per funzioni
specializzate come la pulizia, la contabilità,
Molto spesso un¹impresa
sanitaria naturopatica consiste in una singola persona e forse dei servizi
esterni o di un qualche ³volontario² (come membri di famiglia, amici, ).
Questo sembra al principiante di facilitare le cose sotto aspetti di costi e di
organizzazione. In realtà è abbastanza esigente e forse neanche tanto
economico: approvvigionamento, ³marketing² e amministrazione richiedono tanto
tempo di esercizio e relazionale a scapito del servizio. D¹altronde l¹impiego
di collaboratori e servizi esterni richiede un maggiore grado organizzativo.
5.5 Compiti, responsabilità e competenze
(di titolare e collaboratori)
Se un¹impresa sanitaria consiste
in più di una persona, i compiti dei singoli dipendenti sono stabiliti tramite
contratti di lavoro, mansionari, procedure e specifici mandati a termine:
Con lo scopo che tutte le
attività mirino ad un alto livello di produttività e redditività di merce e
relativi servizi, rispettando le regole sociali.
Con il principio che ogni
compito richiede competenze specifiche e strumenti per eseguirlo autonomamente,
assumendone la relativa responsabilità.
Tenendo in considerazione la
complessità di relazioni e la molteplicità di:
Attività operative di servizio
e di esercizio (di concetto, pianificazione, realizzazione, controllo di
persone, mezzi, materiali, finanze).
Attività dispositive di
servizio e di esercizio (programmi, ordini, controlli di impiego persone,
mezzi, materiali, finanze, tempi).
Attività gestionali di
servizio e di esercizio (previsione, coordinazione, decisioni, controlli
concernenti persone, enti, progetti, finanze, prodotti e servizi).
È necessario che vi siano non
solo chiare strutture organizzative, ma anche che tutti i collaboratori ne
siano a conoscenza. Può sembrare esagerato per ³un¹azienda di quattro gatti² ma
non lo è, proprio perché ciascuno di loro svolge diversi compiti e si evitano
tanti disguidi e costi chiarendo concretamente e una volta per tutte queste
faccende.
Consiglio a tutti coloro che
intendono iniziare un¹attività indipendente (pur piccola che sia) di farsi i
seguenti ragionamenti e di annotarli. Fanno parte di un ³business plan² che
raggruppa un po¹ le intenzioni imprenditoriali.
È una nobile caratteristica
umana di sostituire, pianificando così, il caso con l¹errore.
Vengono trattati i seguenti
temi:
6.8 ³Unique selling proposition²
Vengono trattati i seguenti
argomenti:
6.1.2 Metodi e
procedimenti applicati
Sono da definire, per se stessi, le principali attività professionali (di lucro) con i loro impegni di tempo ed ev. di ricavi.
Esempio:
Attività principale: naturopatia e lavoro corporeo ca. 200 ore mensili,
parzialmente diviso con la mia collega :
- Lavoro
corporeo: ca. 150 ore mensili di ³massaggio².
-
Consultazioni mediche in generale e specifici ca. 30 ore mensili.
-
Elaborazione e prescrizione di medicazioni, regole igieniche e dietetiche,
ca. 20 ore mensili.
Attività ausiliaria: insegnamento di materie naturopatiche ca. 80 ore mensili
-
Docente: corso ³materia medica per naturopati² e seminari su temi specifici ca.
10 ore mensili.
-
Preparazione di relativi testi ca. 70 ore mensili.
Totale
lavoro di ³servizio² (senza esercizio) ca. 280 ore mensili
6.1.2 Metodi
e procedimenti applicati
Sono da
chiarire le intenzioni circa i metodi e procedimenti da applicare.
Esempio:
Diagnostici:
-
Analisi di laboratorio, referti, di medici curanti e specialisti.
-
Indicazioni per ev. ulteriori chiarimenti medici.
-
Anamnesi, inchieste e dialoghi con il cliente.
- Visita
propria con semplici strumenti, test, ispezione e palpazione.
Terapeutici:
-
Consultazione e consigli comportamentali, igienici, dietetici.
- Ogni tanto breve dialogo psicoterapeutico
comportamentale.
- Lavoro
sul corpo: diversi metodi e ³massaggi² del tipo ³biomeccanica², posturale e
riflessivi combinati spesso con aromaterapia.
- Ogni
tanto prescrizione di ³esercizi fisici, psichici, sociali e relazionali.²
-
Fitoterapia occidentale: prescrizione di prodotti o stesura di ricette
magistrali* individuali.
-
Terapia ortomolecolare: prescrizione di prodotti ³microalimentari² o stesura di
relative ricette magistrali* individuali.
-
Raramente applicazione di metodi devianti fisici (coppette, sanguisughe, ).
* Il
termine ³magistrale² sta ad indicare una ricetta preparata individualmente.
Sono da
elencare le formazioni, tirocini ed esperienze che servono nel settore.
Esempio:
Formazione teorica: autodidatta in anatomia, fisiologia, patologia,
naturopatia, diverse tecniche di lavoro corporeo, fitoterapia, terapia
ortomolecolare.
Formazione pratica: diversi corsi di lavoro sul corpo specialmente in
³Integrazione
Posturale².
Tirocinio: lavoro sul corpo a tempo parziale (gratuito) durante 3 anni in uno
studio di estetica e massaggio.
Legittimazione:
- Esame
come ³medico naturalista NVS²,
- membro
della ³Naturärztevereinigung Schweiz² e
- membro
del ³AKODH Arbeitskreis Onkologie Deutscher Heilpraktiker²
Formazione continua: seminari in diverse materie come attualmente in oncologia
naturopatica, terapie ortomolecolari
Serve parecchio inizialmente
ragionare sui seguenti punti:
- Cosa è il mio forte
³curativo².
- Chi potrebbe averne bisogno:
lista sintetizzata al massimo.
- A che condizioni posso
offrirlo che sia invitante per sperimentarlo: disponibilità, tempo, luogo,
prestazione, prezzo, condizioni di pagamento, organizzazione dell¹agenda,
Esempio:
- Disturbi acuti e cronici
dell¹apparato motorio.
- Disturbi circolatori, metabolici,
ormonali e menopausali.
- Disturbi immunologici di tipo
allergico e autoimmunitario.
- Disturbi neurovegetativi e
psichici.
- Malattie recidive infettive e
neoplasmi.
- Consultazione sporadica per
minori problemi medici quotidiani.
È abbastanza importante
inizialmente mirare una determinata clientela di destinazione. Servono i
seguenti ragionamenti:
- In che ³giro sociale² trovo
questi miei potenziali clienti e quale di questi giri mi è socialmente ed
emotivamente vicino.
- In che luogo, tipo di studio e
a quali orari si sentirebbero di subire delle terapie.
- Di quanti clienti ho bisogno,
quanti se ne trovano nella mia regione e da chi sono attualmente serviti?
Esempio:
- Impiegate d¹ufficio e docenti
con dolori più o meno cronici di spina dorsale.
- Casalinghe di mezza età con
disturbi neurovegetativi e menopausali.
- Pensionate con disturbi
cronici geriatrici.
- Ho bisogno di ca. 150 clienti
nella regione di Locarno con trattamento, media di ca. 1.5 ore al mese.
Il nostro mestiere è
caratterizzato da una relazione terapeutica. Il cliente cerca una persona che
lo guarisce dai suoi danni e malanni e dal suo disagio e guarda molto bene a
chi rivolgersi.
Normalmente chiede ai suoi amici
e conoscenti.
Molti colleghi giovani mi hanno
chiesto per altri metodi di acquisizione di clienti ma non ho mai scoperto un
altro efficace come la ³propaganda orale². Hanno fatto inserzioni, visitato
delle fiere e così via, ma oltre a notevoli spese hanno combinato ben poco.
La migliore propaganda è un
cliente soddisfatto e si può fargli anche capire che si è grati a lui quando ci
raccomanda ad altri. Lo farà forse nel suo giro, anche per questo è importante
mirare a una clientela non troppo eterogenea, perché i problemi di un certo
giro sono simili.
La maggioranza dei clienti di
naturopati sono donne e i pochi uomini arrivano di solito grazie alle loro
mogli, compagne o amiche.
Conviene riflettere bene sulle
possibilità di acquisizione clienti concentrandosi sui seguenti ragionamenti:
- Quali amici, colleghi,
conoscenti sarebbero disposti a fare una discreta pubblicità per i miei
servizi.
- Chi di loro è ascoltato e
credibile nel suo giro.
- Come posso arrivare che mi
faccia questo favore e che compenso posso offrire.
-
La prima consultazione di un
cliente è importante per:
- Informarlo sulle mie
prestazioni, servizi, rimedi, condizioni ecc. e per rispondere alle sue
domande.
Così è in grado di valutarmi ed
eventualmente cercarsi un altro terapista.
Esempio: Quando sente la
condizione che non lavoro con le casse malati, non è più interessato e mi
saluta ³amici come prima².
- Chiedere dei suoi danni e
malanni e delle sue aspettative per valutare il mio interesse di curarlo e
stimare le probabilità di riuscirci. Eventualmente gli indico un¹altra strada.
Esempio: Mi dice che le è stato
diagnosticato un tumore al seno con la proposta di operazione, chemioterapia e
radioterapia, che lei però non intende accettare, perché una voce angelica le
ha suggerito di farsi trattare alternativamente. A parte i discorsi seguenti,
rifiuto di trattarla e la informo che le mie cure oncologiche naturopatiche non
sono alternative ma complementari agli interventi oncologici clinici.
- Se cliente e terapista sono
d¹accordo di ³osare un tentativo² che rispetti, in linea di massima, le
aspettative del cliente come la disponibilità del terapista, (eventualmente
dopo un periodo di ripensamento da ambo le parti) proseguo con la parte
³diagnostica².
- Tirate le mie conclusioni dal
precedente colloquio, faccio una proposta circa l¹obiettivo, le procedure, le
prestazioni, i servizi, i rimedi, l¹impegno grossolano in tempo, soldi e durata
della cura (senza garanzia né promesse). Se il cliente è d¹accordo, comincio
subito con il primo trattamento. Molto spesso mi riservo invece una seconda o
terza consultazione/ trattamento per esprimermi dettagliatamente sull¹impegno.
Ritengo che sia leale verso il
cliente fare delle stime approssimative per la cura. Dipendono molto dalla
tariffa oraria, dall¹impegno consultativo e curativo per trattamenti
terapeutici e rimedi, e questo è enormemente variabile secondo il terapista e i
metodi applicati.
Esempio 1: malattie croniche o
disturbi funzionali duraturi
- Tariffa oraria 40.- fr. (non
lavorando con le casse malati ho tariffe pagabili anche dai meno benestanti).
- Trattamenti: mensilmente ca.
due ore a 40.- fr. => 80.- fr. per mese ca. 2.70 fr. per giorno per ca. due
anni corrisponde a ca. 1¹000 fr. per anno, complessivo di ca. 2¹000.- fr.
- Rimedi: tinture, pomate, sali
minerali, vitamine, 2.- 4.- fr. per giorno => 60.- 120.- fr. per mese
=> 700.- 1¹400.- fr. per anno, complessivamente ca. 1¹400 2¹800 fr.
- Costi totali: ca. 4.70 6.70
per giorno => 140.- 200.- fr. per mese => 1¹700.- 2¹400.- per anno,
complessivamente 3¹400.- 4¹800.-
Esempio 2: malattie e disturbi
acuti
- Tariffa oraria 40.- fr.
- Trattamenti: da uno fino a
quattro trattamenti di un¹ora a 40.- fr. => 40.- 160.- fr. Complessivi
nell¹arco di due fino a otto settimane => 2.90 fr. per giorno.
- Rimedi: tinture, pomate, sali
minerali, vitamine, 10.- 20.- fr. per giorno => complessivamente 140.-
1¹200.- fr.
- Costi totali: ca. 13.- 23.-
fr. per giorno, complessivamente 180.- ... 1¹400.- fr.
Il discorso sull¹impegno e sulla
cura porta spesso a una discussione sulla sanità, medici, farmacisti, casse
malati e simili. Non è direttamente terapeutico ma mi da l¹occasione di argomentare
il mio punto di vista. Il filo del discorso è per esempio:
- La prestazione terapeutica va
comunque pagata dal cliente: o direttamente a me o indirettamente tramite i
premi delle casse malati (quelle facoltative).
- In base alle mie tariffe, è
facilmente deducibile che da me riceve più prestazioni a minor prezzo che dal
medico o terapista dipendente dalle casse.
- Si rende conto che, pagandomi
direttamente, risparmia costi amministrativi (da me e dalle casse), servizi che
non lo interessano.
- Si accorge anche che con
l¹assicurazione facoltativa/aggiuntiva/complementare/privata:
- o paga ³solidalmente²
prestazioni non incluse nell¹assicurazione base (che non consuma)
- o approfitta di prestazioni
che altri pagano per lui facoltativamente
- e che tutto questo non incide
minimamente sui principi di rischio e di solidarietà dell¹assicurazione base.
Normalmente non vuole né l¹uno
né l¹altro.
- Ragionato tutto questo, molto
spesso si decide di disdire le assicurazioni aggiuntive, ausiliarie, complementari,
facoltative e private; perché se si può permettere il premio, può anche mettere
via i soldi per casi del genere e decidersi poi se impegnarli in tali cure.
- Inoltre consiglio (se non è
impiegato e se se lo può permettere) di aumentare la sua franchigia a 1¹500.-
fr. il che abbassa ulteriormente notevolmente i suoi premi.
Facendo bene tutti questi
calcoli arrivano di solito alla conclusione, che i risparmi fatti in
assicurazioni sanitarie coprono facilmente quello che spendono per me.
Diversi clienti mi hanno
confidato, che le spese per le mie cure (più efficaci secondo loro) erano
minori dei 10% di partecipazione alle fatture mediche / farmaceutiche, di cure
precedenti senza esito.
Stimo che negli ultimi due anni
abbiamo (in due terapisti) convinto ca. 100 clienti a modificare le loro
assicurazioni in questo modo. In media sono riusciti ad abbassare i loro premi
mensili da 600.- fr a 200.- fr. Vuol dire che si sono risparmiati in media
4¹800.- fr. di premi per un totale di 100 clienti quasi mezzo milione di
franchi, dedotti come cifra d¹affari e capacità di guadagno agli assicuratori
³ausiliari². Anche se sembra poco, agli assicuratori farà male, perché abbiamo
tolto a loro del volume di mercato in un ambiente dove persiste già la
concorrenza di rimozione, in un modo poi contro il quale avranno poche
risposte, perché nel contatto terapeutico sarò sempre più vicino io al mio
cliente che loro.
6.8 Unique selling proposition
Nelle dottrine di marketing
moderno c¹è una centrale che si chiame ³unique selling proposition² (proposta
esclusiva di vendita). Significa che si può vendere un prodotto o una
prestazione, se si distingue almeno in una caratteristica esclusiva
argomentabile da quelli concorrenziali.
Il tema può essere trattato a
due livelli:
- Naturopatia nei confronti
della medicina ³sanitaria².
- Distinzione di naturopati tra
loro.
Naturopatia nei confronti della
medicina ³sanitocratica²:
- Non dovendomi attenere a
codici, patti, procedure e amministrazioni della sanitocrazia sono in grado di
offrire prestazioni più tagliate sulle esigenze e aspettative del mio cliente.
- Posso farlo come indipendente
a condizioni imbattibili rispetto alla sanitocrazia.
- Il che fa risultare una
relazione prestazione / prezzo attraente per il cliente.
Essendo così in concorrenza alla
sanitocrazia, faccio parecchio per non dovermi alleare (perché mi
condizionerebbero grazie al loro potere di mercato), ma mi servo quanto
possibile dei loro servizi che non sono in grado di fornire o nei quali sarei
più mediocre di loro. In questo senso esiste una buona collaborazione con certi
medici e farmacisti della quale approfittano entrambi le parti, perché non ci
infiliamo a vicenda nel forte dell¹altro e lasciamo il guadagno a chi fornisce
la prestazione.
Come ³operatore naturopatico²
non ci vogliono grandi scervellamenti per l¹esclusività della mia prestazione:
sta nella mia persona. Il mio cliente non mi percepisce come esponente di una
tecnica, apparecchiatura o prodotto (almeno spero) ma compra la mia prestazione
in base ad un suo giudizio circa le mie capacità professionali e umane. È
sbagliatissimo credere che si possa trasferire clientela tra metodi e
terapisti, in ultimo ³il nostro prodotto² è il terapista stesso e per il mio
cliente sono io, Peter Forster.
Il mio cliente:
- Deve essere convinto della mia
competenza professionale (e poco importano diplomi e attestati). Se mi giudica
un ignorante in materia ...
- Deve rispettarmi nella mia
indole come io ho da rispettare la sua visione del mondo e il suo disagio. Se
mi prende per scemo, ... o se io voglio modificarlo ...
- Fa parte del rispetto la
dedizione e la concentrazione completa durante la terapia e la disponibilità
entro i limiti pattuiti espressis verbis o tacitamente.
- Deve essere pronto ad instaurare
un rapporto terapeutico che è molto intimo e questo dipende soprattutto dalle
mie capacità relazionali. Se lui non è disposto a dare del suo o io del mio,
mancherà il successo per tutti e due.
- Deve essere convinto, che il
lume vale la candela (cosa difficile da valutare, se non paga di propria tasca
la candela). Io anzitutto:
- Nel primo incontro devo
valutare la probabilità di un successo terapeutico e come definirlo.
Se è scarsa per qualsiasi motivo
devo rinunciare al trattamento nell¹interesse del richiedente come nel mio.
- Devo riuscire nella cura,
perché mi serve un cliente soddisfatto. (Questo non significa che curo la
gente. Voltaire ha giustamente fatto notare che, ³... è compito del medico
divertire bene il paziente durante il periodo che la natura impiega per
guarirlo ...²): la reputazione mia dipende dai clienti soddisfatti e dalla
reputazione dipende la mia clientela e quindi la mia impresa.
- Farsi rispettare significa
anche non entrare nei soliti giochetti relazionali (p.es. vittimismo e
prepotenza, ...).
- Gira tanto la ³dottrina² che
per guarire sia necessaria empatia, amore e così via. Non ho questo genere di
problema: io mi sento medico anzitutto, e se Hitler avesse dolori e mi
chiedesse di curarlo e ci fosse una probabilità di miglioramento, lo tratterei,
ma certo che non mi troverei in simpatia con un megalomane paranoico assassino.
Probabilmente avrei compassione per lui, perché il suo ambiente l¹ha
glorificato invece di curare la sua malattia mentale e certamente avrei il massimo
rispetto del suo povero organismo tanto violentato, ma empatia o amore, che
idea oscena!
È evidente che questi
ragionamenti non sono conformi a una ³mentalità d¹impiegato² né per gli addetti
del ³pensiero positivo². Ma se deve funzionare a lungo il mio piccolo
³cronicario²(perché i clienti soddisfatti mi indicano ad altri) è grazie alla
mia persona, al mio atteggiamento e alle mie capacità terapeutiche; non mi
rimane granché di diverso. E se non mi sento di farlo così, devo cercarmi un
posto sicuro come impiegato, forse in un centro sanitario.
Una vera e propria propaganda
con i mass-media sul settore sanitario è obsoleta. Le regole e i codici delle
relative associazioni professionali la escludono (vedi relative istruzioni nel
materiale di documentazione).
Tanto più importante è una
presentazione pulita, semplice e sintetizzata su eventuali:
vedi
esempio seguente, punto:
- moduli per lettere, ricevute,
...: a),
b), c)
- biglietti da visita e per
appuntamenti: a),
b), c)
- insegne dello studio a),
b), d), e)
- diplomi fissati alla parete
dello studio
- foglio illustrativo con breve
spiegazione delle cure applicate:
a), b), c), d), e)
- ev. (a richiesta del cliente)
breve curriculum terapeutico a),
b), c), d), e)
Per l¹impostazione di tali
incarti può servire il seguente esempio. Personalmente lascerei via d) ed e) se
non sul foglio illustrativo e nel curriculum, perché d) serve per
l¹acquisizione che non avviene nel mio settore per via di incarti ma per raccomandazione
personale ed e) mi puzza tanto di ³giustificazione² che non ho bisogno. Inoltre
l¹esempio punto e) lascia mancare le tecniche diagnostiche (il medicamento è
giusto, solo la malattia è sbagliata). Lascia del resto il sospetto di un
conglomerato di tecniche aleatorie. Meglio non dire niente che creare sospetti
(forse completamente infondati) del genere.
Esempio:
a)
nome di terapista Salvatore Curato
ev.
titolo, legittimazione approvazione medico naturalista NVS
ev.
nome dello studio Studio Sanintegro
b)
ev. attività terapie corporee, naturopatia
c)
recapito v. Budella
13, 6666-Scodinzolo
appuntamenti:
079 211 87 13
d) ev.
specialità trattamento di: stress, emicrania, insonnia depressioni,
disturbi psicosomatici, mal di schiena
e)
ev. metodi, tecniche aggiustamento base spinale, Breuss
terapie antidolorifiche
agopuntura
reiki,
fiori di Bach
orientamento
professionale
7.0 ³La creazione di un¹azienda nel Cantone Ticino²
Questo è il titolo di un
prontuario per operatori economici del dott. rer. pol. Adriano Cavadini,
Consigliere nazionale e già direttore della Camera di Commercio dell¹industria
e dell¹artigianato del Cantone Ticino, reperibile alla Camera di Commercio, corso
Elvezia 16, 6901 Lugano.
Consiglio vivamente a coloro che
intendono iniziare un¹impresa del genere (e a quelli che l¹hanno già fatto) di
studiare attentamente questo libro anche se è del 1990. Nel seguente capitolo
mi riferisco soprattutto a questo testo.
La popolazione residente in
Ticino conta ca. 300¹000 anime delle quali ca. la metà lavorativamente attiva,
e di queste ca. il 60% nei servizi (gli altri in industria, edilizia e
agricoltura). Il reddito sociale cantonale è di ca. 8 miliardi di franchi con
un reddito pro capite, in media di ca. 30¹000 fr. annui.
Dati esaurienti, precisi e
aggiornati sono rilevabili degli annuari statistici federali e cantonali
(Ufficio cantonale di statistica).
Vengono trattati i seguenti
temi:
7.1 Ditta individuale (società di una sola persona
fisica)
7.2 Norme per le professioni sanitarie
7.5 Progettazione di uno studio naturopatico
7.1 Ditta individuale (società di una sola persona
fisica)
Ogni persona con residenza nel
cantone, cittadino svizzero o con permesso di lavoro può crearsi una ditta
individuale senza ulteriori formalità. Quando la cifra d¹affari supera i
100'000 fr. annui, è obbligatoria l¹inserzione nel registro di commercio e di
conseguenza una contabilità industriale. Di seguito le spiegazioni del dott.
Cavadini:
1. La scelta del tipo di società
e della sede
Una persona che desideri
iniziare un¹attività indipendente nei settori industriale, commerciale o dei
servizi, deve pure decidere quale forma giuridica dare alla sua iniziativa, tenendo
naturalmente conto delle leggi o regolamenti esistenti in Svizzera e delle
norme che disciplinano a livello federale o cantonale l¹esercizio di una
determinata professione. Per la scelta della forma giuridica esistono diverse
possibilità secondo che il nuovo imprenditore intenda agire direttamente quale persona fisica o in comunione con
altre persone oppure indirettamente attraverso una per persona giuridica. Nelle spiegazioni seguenti
faremo perciò una distinzione fra questi tre tipi di società.
2. Il caso di una sola persona
fisica (ditta individuale)
Una persona fisica può
esercitare un¹attività commerciale in qualità di unico titolare dell¹azienda.
Egli crea così una ditta individuale, gestita con il suo nome e sotto l¹intera
sua responsabilità. Per la fondazione non sono richieste formalità particolari;
basta che l¹azienda venga aperta dal suo proprietario. Può però fondare
unicamente una ditta individuale ed esercitarvi un¹attività lucrativa
indipendente di regola solo una persona di nazionalità svizzera o uno straniero
in possesso di un permesso di domicilio. Ritorneremo, al paragrafo II, 2. sulle
condizioni richieste a una persona di nazionalità straniera per iniziare
un¹attività indipendente. Per uno straniero in possesso di un permesso di
dimora, di un permesso di lavoro come stagionale o frontaliere è pertanto
esclusa la possibilità di lavorare in nome proprio.
Con il nuovo diritto
matrimoniale, entrato in vigore il 1. gennaio 1988, possono esercitare una
professione o condurre un¹impresa di loro scelta.
Ciascun coniuge deve tuttavia
usare riguardo nei confronti dell¹altro e tenere conto del bene dell¹unione
coniugale. Salvo speciali disposizioni legali (fideiussioni, contratti di
vendita a rate e contratti di vendita a rate anticipate) ciascun coniuge può
concludere liberamente negozi giuridici con l¹altro coniuge e con terzi.
Parecchie novità sono state introdotte nel
sistema dei regimi dei beni fra coniugi e nel diritto successorio.
In quest¹ultimo caso, la
posizione del coniuge superstite è stata notevolmente rafforzata rispetto al
passato. È opportuno quindi verificare questi aspetti, soprattutto quando nella
famiglia esistono delle aziende. Infatti, il Codice civile dà determinate
possibilità di attribuire a un coniuge i beni, rispettivamente i relativi
redditi, destinati all¹esercizio di una professione o di un¹impresa. Ciò per
evitare, ad esempio che l¹incremento di valore di questi beni aziendali aumenti
automaticamente anche la quota parte dell¹altro coniuge, che magari del
I¹azienda non si interessa in nessun modo.
Sono aspetti estremamente
importanti e delicati che giustificano un esame preliminare per porsi al riparo
da spiacevoli situazioni in caso di separazione, divorzio o successione. Essi
potrebbero persino mettere in gravi difficoltà la situazione finanziaria
dell¹azienda qualora il coniuge che la gestisce si vedesse costretto a pagare
all¹altro coniuge una parte dell¹incremento di valore dell¹azienda medesima, di
regola investito e immobilizzato nei beni aziendali.
Un giovane può mettersi in proprio quando ha
l¹esercizio dei diritti civili, ossia è capace di discernimento, e se ha
compiuto 20 anni. Da notare che il matrimonio rende maggiorenni. In taluni casi
può essere ottenuta dall¹autorità di vigilanza sulle tutele l¹emancipazione, a
condizione che l¹interessato abbia compiuto 18 anni e che inoltre egli, i suoi
genitori e, se del caso, il tutore siano d¹accordo.
Colui che esercita un¹attività
individuale deve adoperare il suo cognome, con o senza nome. La donna sposata
deve aggiungere al cognome la menzione ³signora² o almeno un nome per esteso
(art. 945
Codice delle obbligazioni). È
preferibile aggiungere il tipo di attività.
Alcuni esempi di ragione
sociale:
- Rossi, Impresa di pittura, Via
delle Scuole, Lugano;
- Bernardo Rossi, Impresa di
pittura, Via delle Scuole, Lugano;
- Signora Rossi, Articoli per
bambini, Lungolago 58, Lugano;
- Giovanna Rossi, Articoli per
bambini, Lungolago 58, Lugano.
Per una ditta individuale
l¹iscrizione al Registro di commercio è facoltativa. Essa diventa però
obbligatoria quando l¹introito annuo lordo supera i 100¹000.- franchi. Sulle
particolarità e conseguenze dell¹iscrizione al Registro di commercio rinviamo
il lettore al punto III.
7.2 Norme per le professioni sanitarie
Vengono trattati i seguenti
argomenti:
7.2.2 Altre attività
legate alle professioni sanitarie
Il testo
sottostante spiega le ordinazioni secondo il dott. Cavadini. Visto che la
vendita di rimedi può essere una parte integrante del lavoro naturopatico
(secondo la scelta dell¹imprenditore) è da notare:
- La
nuova legge sanitaria ticinese prevede la liberazione di certi medicamenti e
rimedi per la vendita anche da parte di naturopati. Le disposizioni previste in
dettaglio non mi sono ancora note.
- Sarà
difficile da proibire la vendita di camomilla e salvia per le tisane.
- Sarà
ancora più difficile di proibire la vendita di ³aggiunte alimentari².
- È in
corso una liberalizzazione del commercio di rimedi anche a livello federale.
i) Il
commercio di medicinali
Con il
commercio di medicinali si intendono la preparazione, la manipolazione, il
tenere in deposito, l¹importazione, l¹esportazione, la confezione, la consegna
e la vendita di medicamenti in dose e in forma di medicamento nonché delle
specialità farmaceutiche e la pubblicità. La vendita e il commercio di
medicamenti e delle specialità farmaceutiche sono riservate ai soli farmacisti
nelle loro rispettive farmacie, salvo alcune eccezioni previste all¹art. 76
della legge sanitaria1).
Il commercio
di medicinali all¹ingrosso soggiace
pure alla vigilanza del Dipartimento delle opere sociali e richiede una
speciale autorizzazione (art. 86 e 87 della legge sanitaria)1).
1) Cfr. Raccolta delle leggi
vigenti del Cantone Ticino, volume 5, 185.
7.2.2 Altre attività legate alle professioni
sanitarie
La nuova
legge sanitaria Ticinese prevede per la nostra categoria:
- Di
mantenere l¹attuale stato di ³guaritore².
- Di
aggiungere la professione di ³naturopata² con un esame cantonale e relativi
obblighi e diritti di esercizio.
È da
aspettarsi che chi intende collaborare con le casse malati tenterà di farsi
³naturopata² (senza obbligo di retribuzione da parte delle casse malati), con
la speranza di aumentare la sua clientela. Chi non intende a collaborare con
loro, preferirà rimanere ³de iure guaritore² senza gli obblighi legali e
amministrativi dei naturopati.
Il testo
del dott. Cavadini (1990):
25.
Altre attività legate alle professioni sanitarie
(Levatrici,
infermieri, logopedisti, rieducatori della psicomotricità, dietisti,
odontotecnici, pedicure, estetisti).
Tutte
queste professioni sono considerate dalla legge sanitaria e possono perciò
essere esercitate solo se la persona ha ottenuto l¹autorizzazione del
Dipartimento cantonale competente, che viene rilasciata unicamente a chi è in
possesso di determinati requisiti.
Le norme
sono contenute segnatamente dagli art. 53 a 61. Vi è poi anche una disposizione
che si riferisce ai ³guaritori² (art. 63).
Ricordiamo
che vi sono un regolamento per l¹esercizio delle pedicure3), della
professione d¹igienista dentaria4).
Nel
Cantone Ticino esistono alcune scuole per imparare diverse professioni
sanitarie. Il lettore interessato troverà tutta questa documentazione nel
volume 5 della Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino.
3) Cfr. Raccolta delle leggi
vigenti del Cantone Ticino, volume 5, 206.
4)
Cfr. Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino, volume 5, 206,a.
Vengono trattati i seguenti
argomenti:
7.3.1 Assicurazioni
delle persone nell¹azienda
7.3.2 Assicurazioni
patrimoniali e delle cose dell¹azienda
7.3.1 Assicurazioni delle persone nell¹azienda
Nel seguente riassunto il dott.
Cavadini elenca la protezione contro rischi personali
per l¹indipendente e per i
dipendenti (assicurazioni obbligatorie e facoltative). Una
bella parte di questi oneri in
caso di dipendenti è pagata dal datore di lavoro. Nel caso
dell¹indipendente, paga, di
propria tasca, tutto quest¹ultimo e questo è da prevedere
nei costi d¹esercizio.
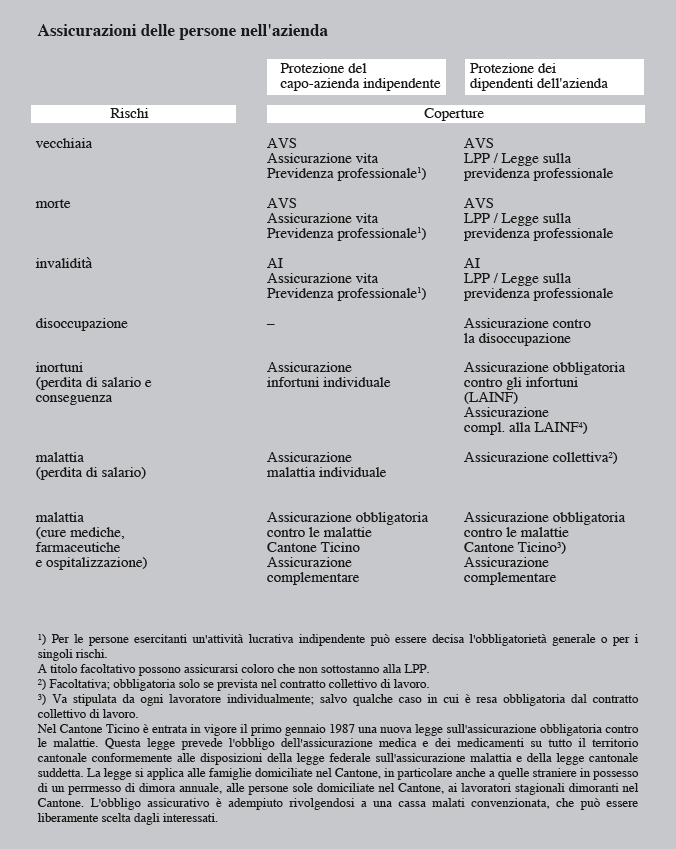
7.3.2 Assicurazioni patrimoniali e delle
cose dell¹azienda
Fa parte
di ragionamenti e decisioni imprenditoriali di stabilire l¹assicurazione o meno
di rischi e coperture del patrimonio, del capo-azienda e delle cose
dell¹azienda. Il dott. Cavadini li elenca come segue:
Per la
valutazione serve ragionare sul rischio, sulla copertura dei costi assicurativi
e sulla possibilità propria di rispondere al rischio (cosa capita, se ...). I
relativi costi fanno evidentemente parte dei costi di esercizio.
Il laico e principiante in
materia fa spesso l¹errore di paragonare il reddito lordo di un indipendente
con quello di un dipendente. È un errore fatale che porta al fallimento di
innumerevoli imprese artigianali create da ex-dipendenti e rilasciano drammi
personali e familiari di solito con mucchi di debiti mai più compensabili.
Per fare un esempio: un lordo
indipendente di coniugato di 75¹000 fr. annui (corrispondente a virtualmente
75¹000 / 12 = 6¹300.- fr. mensili) comporta:
- ca. 7¹300.- fr di AVS, AI, IPG
(non pagati da un datore di lavoro)
- ca. 21¹000.- fr. di altre
previdenze non pagate da un datore di lavoro)
cioè corrisponde a un lordo di
un dipendente di ca. 46¹700.- fr. diviso 13 (perché riceve di solito una
tredicesima) virtualmente a ca. 3¹600.- di salario mensile di un dipendente.
Facendo la relazione risulta
paragonabile come disponibilità di acquisto il lordo di 3¹600.- fr.
³dipendenti² con uno di 6¹300.- fr. ³indipendenti². Vuol dire che:
- un lordo da indipendente
bisogna diminuirlo di ca. il 43% per paragonarlo con un lordo da dipendente,
- o, al contrario, al lordo di
un dipendente bisogna aggiungere ca. il 75% per arrivare all¹equivalente di un
indipendente (i calcoli percentuali ingannano).
In allegato la tabella del dott.
Cavadini con dati più completi (da notare, per il paragone, che le imposte
devono essere pagate da dipendenti e indipendenti):
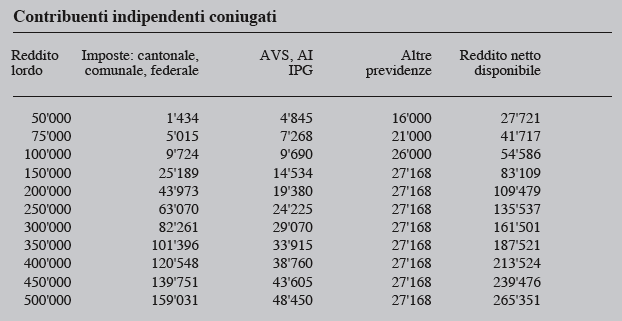
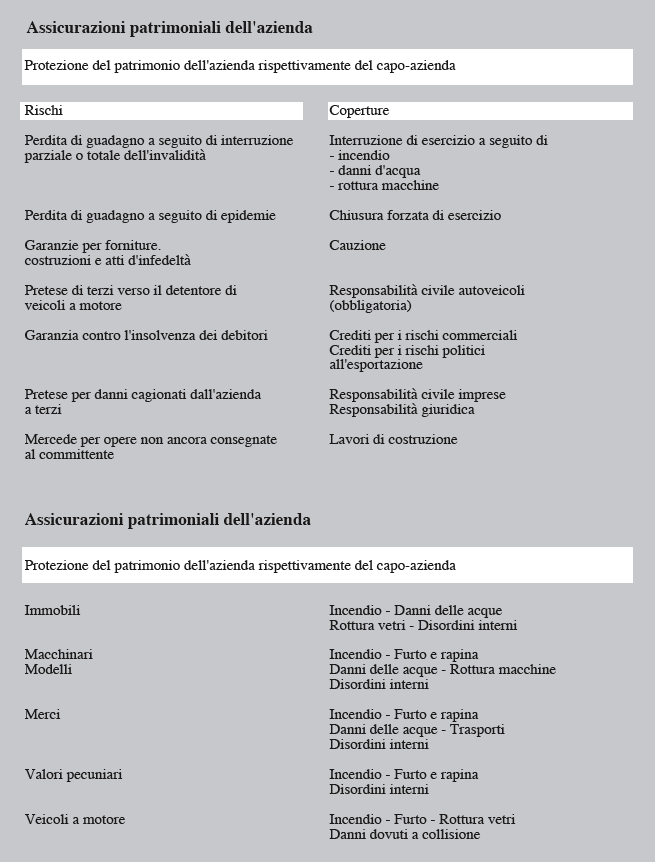
7.5 Progettazione di uno studio naturopatico
La progettazione è
un¹anticipazione mentale sistematica e ordinata di un¹idea ritenuta
realizzabile e formulata come concetto. Fornisce i dati che permettono:
- Di valutare la fattibilità e
la convenienza.
- Gli elementi base per
un¹eventuale realizzazione.
Si tratta proprio di
anticipazione mentale di tutti gli elementi importanti necessari per il
funzionamento di un presunto studio naturopatico che richiede anzitutto la combinazione
di fantasia e creativa con la capacità di consuntivamente quantificare tutti
gli indicatori del sistema. I ragionamenti dei precedenti capitoli possono
servire a questo lavoro, ma in ultimo ogni futuro naturopata ha da farsi questo
lungo e faticoso lavoro a tavolino da solo.
È venuta a mancare questa
capacità imprenditoriale nella nostra società di impiegati. Ogni contadino
mediovale analfabeta, per necessità esistenziali, lo faceva meglio di noi. È
ora di ripristinare questa dote.
Per non dover fare un corso
accelerato di ³systems engineering² e di contabilità aziendale propongo la
seguente procedura:
- Analisi della domanda e
dell¹offerta sul mercato regionale naturopatico allo scopo di scoprire delle
³nicchie di mercato² che sono esigenze di un gruppo di popolazione,
qualitativamente e/o quantitativamente insoddisfatte (e probabilmente ben
pagate).
- Ricordo che si tratta di
esigenze di clienti (p.es. far passare dolori cervicali e mal di testa
tensionale a persone attive lavorando al computer) e non di offerte di tecniche
(come p.es. ³offro shiatzu, medicina cinese e kinesiologia²).
- Il principiante imprenditore
fa spesso l¹errore di voler offrire un sacco di cose che secondo il suo parere
interessano a tutti con la speranza di aver accesso ad un gran numero di
persone. È sbagliato perché ³diluisce² le forze.
Vengono trattati i seguenti
argomenti:
7.5.1 Rappresentazione
di idee
7.5.2 Analisi di
idee (per realizzazione e esercizio)
7.5.5 Esempio
Budget di ³fondazione²
7.5.6 Esempio
ragionamenti economici di ³fondazione²
7.5.1
Rappresentazione di idee
Un¹idea
nasce come un soffio e sparisce come tale, se non va formulata in modo di
essere comunicata e analizzata. Sin dai tempi dei retori greci e romani si è
conservato il seguente metodo (e sequenza di rappresentazioni):
- Tema,
situazione attuale.
-
Problemi esistenti, compiti da risolvere.
-
Traguardi, scopi da raggiungere
-
Condizioni, limiti da rispettare.
- Idea
da valutare.
Per la
fase creativa (di sviluppo) di idee si è dimostrato utile non trattarla come
sequenza ma come sistema che rende visibile le interferenze dei criteri:
7.5.2 Analisi di idee (per realizzazione e
esercizio)
Chiariti
una volta i criteri dell¹idea, se questa è ritenuta ³non tanto balorda², si prosegue
alla sua analisi che consiste essenzialmente nei seguenti ragionamenti:
Volendo
concretizzare l¹idea:
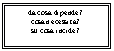
la
realizzazione l¹esercizio
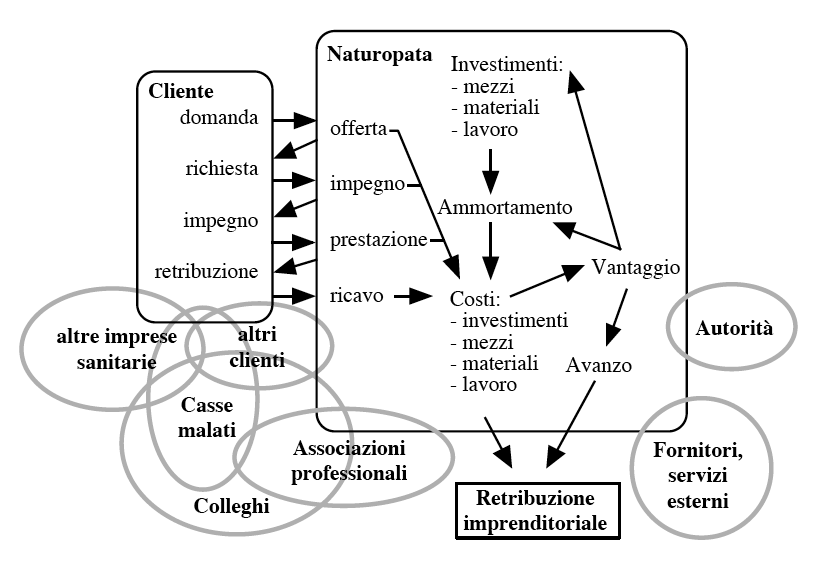
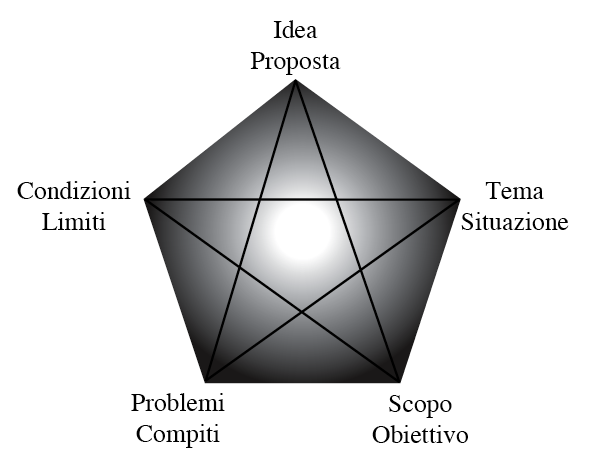
Anche la fase creativa (di
sviluppo) è utile trattarla non in modo sequenziale, ma come sistema, per
rendere visibile le interdipendenze. In questa fase si tratta di ragionare
qualitativamente su influssi, condizioni e effetti di un sistema ancora
ipotetico. Non vengono ancora fatte delle valutazioni quantitative, questo è
riservato al prossimo passo.
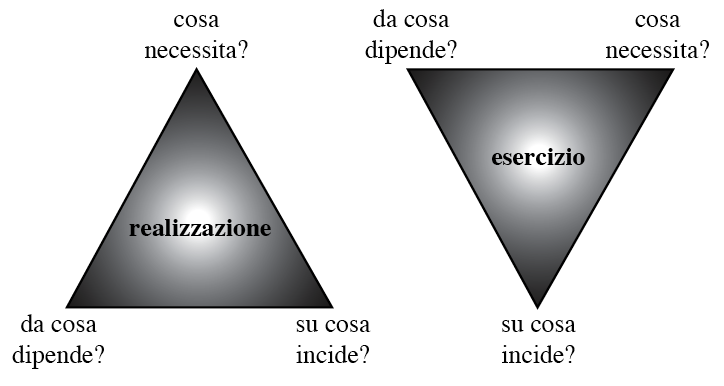
Chiarite
una volta qualitativamente le condizioni di realizzazione e di esercizio, e
ritenuta l¹idea ancora valida, si prosegue alla valutazione quantitativa. In un
primo tempo si fanno delle stime molto grossolane per non perdere tempo con
dettagli di una ipotesi che forse si dimostrerà irrealizzabile e/o
impraticabile.
Il
seguente modulo permette di raggruppare delle stime di impegni, costi e
investimenti per la realizzazione e l¹esercizio di un progetto tipo ³creazione
di un¹attività indipendente². Un¹idea non è quantitativamente valutabile, se
non si riesce a stimare almeno approssimativamente i costi di investimento e di
esercizio. Per le relative stime conviene trattare voce per voce separatamente
e più in dettaglio (ma sempre a livello di stime grossolane) su un foglio e
riportare il risultato nella scheda. A conclusione dell¹opera si dispone di una
visione economica dell¹idea abbastanza affidabile, pronta per fare dei
ragionamenti conclusivi come descritto in seguito.
È buon
uso imprenditoriale partire con gli investimenti ³duri² (da pagare)
inizialmente in modo molto cauto e limitarsi all¹indispensabile, mentre sul
proprio lavoro di realizzazione, non si risparmia e lo si fornisce nel tempo
libero ³a rischio².
Per le
stime dell¹esercizio si calcolano le proprie ore ³a minimo fabbisogno
esistenziale² (se rende, torna comunque come avanzo imprenditoriale, altrimenti
è comunque perso).
Si usa
anche contrassegnare tutti i costi fissi (quelli che non dipendono della mole
di lavoro come p.es. l¹affitto), con un asterisco a destra della voce nella
colonna ³Esercizio², e si tenta di tenerli inizialmente minimi per diminuire il
rischio.
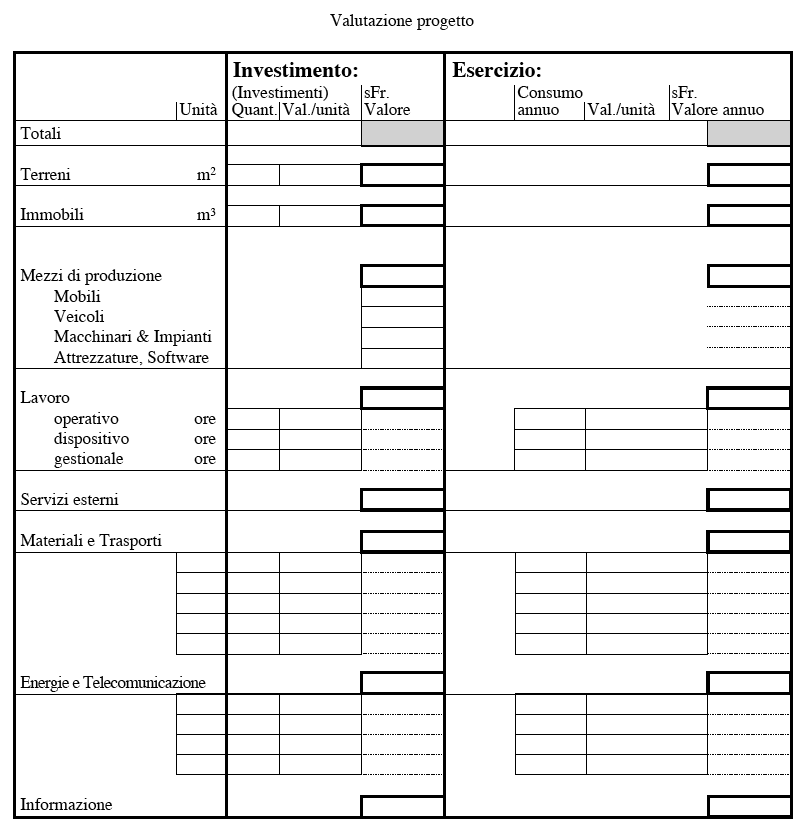
Per
semplificare inizialmente le cose mi sono concentrato sul fattore lavoro/ore.
Per chi intende anche fare commercio di prodotti, avrà da introdurre sotto la
voce ³Investimenti: materiali e trasporto² la cifra che corrisponde allo stock
di prodotti che intende tenere, e sotto la voce ³Esercizio: materiali e
trasporti² il prezzo franco che ha pagato lui per la fornitura della merce che
intende vendere per anno. Nei seguenti ragionamenti deve aggiungere alle
relative voci di ³ricavi² (orari) quelli netti previsti per la merce intesa da
vendere. Un altro metodo è di farsi delle schede separate per ³il commercio²
che rendono più trasparenti e distinte la redditività di lavoro e quella di
commercio. Le voci della seguente scheda sono discusse nei sottocapitoli e poi
illustrate con un esempio.
Vengono
trattati i seguenti argomenti:
7.5.4.1 Ore
incassabili, costi e tariffe orarie
7.5.4.3 Ritorno
sull¹investimento
7.5.4.4 Retribuzione
imprenditoriale
7.5.4.5 Paragoni con
salari di dipendenti
7.5.4.1 Ore incassabili, costi e tariffe orarie
Inizialmente è difficile
prevedere la mole di lavoro ³fatturabile² o meglio incassabile in un anno. Si
tratta a livello d¹incasso, non delle ore realmente prestate, quindi
normalmente solo di una buona parte di ore ³operative². È buon uso
imprenditoriale di calcolare solo l¹80% delle stimate ore operative come
incassabili, se sono di più, aumentano l¹avanzo imprenditoriale, se sono di
meno, l¹impresa va presto in malora.
Il costo orario si calcola
dividendo il costo d¹esercizio per le ore incassabili in un anno. Si chiede
anche, subito a questo livello, la ripartizione di costi fissi (somma di quelli
contrassegnati con asterisco) e costi variabili sul costo d¹esercizio. Costi
fissi oltre al 30% dei costi d¹esercizio sono da ritenere imprenditorialmente
azzardati, perché sono rischiosissimi in caso che si abbassi la mole di lavoro.
Si tenta di tenerli intorno ai 20%.
La tariffa oraria evidentemente
deve essere più alta del costo orario (già introdotto a minimo di esistenza) se
no si fallisce in fretta. D¹altronde è la clientela a determinare le tariffe:
se, a loro avviso, la prestazione non vale il prezzo o se la stessa prestazione
possono averla a minor prezzo, non saranno più i tuoi clienti e la tua mole di
lavoro si abbassa e aumentano i costi orari.
Tra prezzo e costo (nel nostro
caso tariffa oraria e costo orario di esercizio) esiste un classico circuito di
regolazione (tramite clientela e mole di lavoro) che influisce sul vantaggio
imprenditoriale. Il sistema è naturalmente aperto in quanto sia le condizioni
di mercato sia le condizioni (e misure) imprenditoriali influiscono
notevolmente.
Se la mole di lavoro supera le
capacità lavorative, si può aumentare il prezzo, mentre se diminuisce,
l¹impegno lavorativo li dovrebbe abbassare (e prendere altre misure per
diminuire proporzionalmente i costi o si intraprende un¹attività più
redditizia) fino al punto in cui i prezzi non coprono più i costi e si chiude
l¹impresa per liquidazione o fallimento.
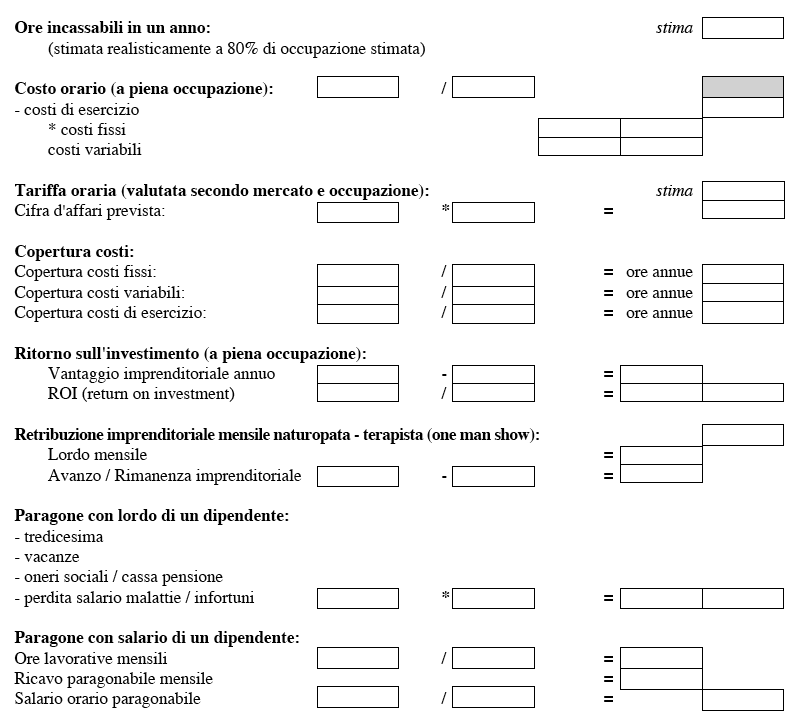
Tenendo conto di tutti questi
fattori si decide per una tariffa oraria che presumibilmente:
- è accettata dalla clientela,
- garantisce una mole di lavoro sufficiente
per coprire i costi d¹esercizio,
- promette un vantaggio
imprenditoriale per ammortizzare gli investimenti iniziali, permettere nuovi
investimenti e un avanzo imprenditoriale.
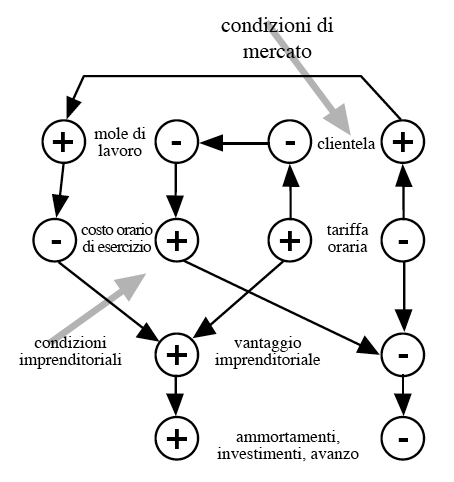
Vale la pena di farsi anche un¹idea circa la copertura dei costi. Già precedentemente abbiamo notato che tenere bassi i costi fissi diminuisce il rischio imprenditoriale. Una volta stabilita una tariffa oraria, si fa il calcolo alla rovescia chiedendosi:
-
Con quante ore incassabili sono coperti i costi fissi (costi fissi diviso
tariffa).
-
Con quante ore sono coperti anche i costi variabili e di esercizio completo.
Per
il controllo dell¹esercizio è altamente istruttivo rendersi conto di quando si
ha lavorato per l¹affitto, il telefono e il riscaldamento, quando si ha
raggiunto il minimo esistenziale e a partire da quando si lavora per il proprio
vantaggio imprenditoriale.
7.5.4.3 Ritorno sull¹investimento
Presumendo
che i ricavi aziendali superino i costi d¹esercizio, la loro differenza è il
vantaggio imprenditoriale (ricavi - costi d¹esercizio).
I
l
ritorno sull¹investimento (ROI => return on investment) è il lasso di tempo
entro il quale il vantaggio imprenditoriale copre l¹investimento, calcolato
come: investimento diviso vantaggio imprenditoriale. I manager industriali per
investimenti di produzione ritengono ottimi dei ROI tra 2 ... 3 anni (che
corrisponde a un ammortamento di 30 ... 50% annuo. Certi beni di capitale si
consumano (come i computer) e devono essere sostituiti o curati con costi
rilevanti, mentre altri (come i terreni) tendono ad aumentare di valore.
Per
il nostro scopo mi sembra importante rilevare che almeno il capitale investito
inizialmente in contanti sia ricavabile. Prima di fare nuovi investimenti o di
tirare fuori soldi come avanzo, è buon uso imprenditoriale ammortizzare gli
investimenti iniziali.
7.5.4.4
Retribuzione imprenditoriale
Nei
primi anni normalmente la preoccupazione è di ammortizzare il capitale
investito (meglio se è capitale proprio) e la retribuzione imprenditoriale
corrisponde al costo di lavoro orario operativo ³minimo esistenziale² che è
stato fissato in precedenza, moltiplicato per le ore effettive di incasso. Per
questo periodo è meglio avere un po¹ di riserve private per poter affrontare
eventuali imprevisti. Specialmente all¹inizio è spesso sbagliata la stima del
minimo esistenziale in quanto gli oneri come imprenditore sono massicciamente
superiori di quelli di un dipendente, come visto precedentemente.
7.5.4.5 Paragoni con salari di dipendenti
Il
paragone a livello di mensile si aggira intorno alla mensilità imprenditoriale
diminuita di 20 ... 40%. Per una cifra d¹affari intorno ai 75¹000.- fr. si
moltiplica il mensile imprenditoriale per 0.62 per arrivare ad un mensile
paragonabile a quello di un dipendente. Questo perché non c¹è più un datore di
lavoro che versa dei contributi rilevanti per assicurazioni sociali,
malattie/infortuni, cassa pensione e paga vacanze, giorni feriali e spesso una
tredicesima.
A
livello di paragone di salario orario, peggiora ancora il confronto, in quanto
l¹indipendente lavora normalmente più ore per il suo mensile che il dipendente,
d¹altronde ha la possibilità di farlo e nessuno gli rompe le scatole.
7.5.5 Esempio di un Budget di ³fondazione²
Come
esempio, ho scelto un budget per la creazione di uno studio terapeutico di una
persona che ha già una certa clientela perché prevalentemente lavorava
parecchio nel suo tempo libero come terapista e si è fatta una buona
reputazione con tante richieste per lavoro sul corpo contro disturbi
dell¹apparato motorio. Si trova nella situazione che deve dedicare pochissimo
tempo alla famiglia e lavora ca. 80 ore al mese per una tariffa di 40.- fr.
all¹ora, e questo le ha permesso di mettere da parte ca. 30¹000.-fr negli
ultimi anni. Ha ca. 80 clienti che tratta ogni mese per ca. 1 ora. Non è più
tanto soddisfatto del lavoro che esegue attualmente: gli pesa anche di lavorare
40 ore per settimana in industria, e altre 20 a casa nel tempo libero. Sua
moglie lo sostiene nell¹iniziativa di farsi indipendente. D¹altronde si rende
conto che si tratta di un passo rischioso, assentarsi dalla sua attuale professione
alla sua età porta seri rischi di non poter più trovare lavoro se la faccenda
va storta e come indipendente non può più godere le prestazioni della cassa
disoccupazione. Malgrado questo, ha ragionato bene la situazione e arriva alle
seguenti conclusioni:
- Vista
la richiesta, vuol aumentare il trattamento del singolo cliente da mediamente 1
ora al mese a mediamente 1.5 ore al mese.
- Questo
significa per mese, con la clientela esistente, 120 ore operative.
-
Intende arrivare a 2000 ore operative all¹anno che farebbe ca. 170 ore mensili.
- Per
questo avrebbe bisogno nuovi clienti (170/120 = 1.24 * 80 =114 -80 = 34): 34
nuovi.
- Pensa
di poterseli fare con la propaganda orale di clienti esistenti soddisfatti ed
amici.
- In
più, dopo sondaggi dai suoi clienti abituali, pensa di poter aumentare la
tariffa a 45.- fr. orari.
Basandosi
su queste stime, le esperienze già fatte e un po¹ di informazioni su affitti,
arredamenti e attrezzature per uno studio, stila il seguente budget.
7.5.6 Esempio
di ragionamenti economi di ³fondazione²
Facendo
i ragionamenti economici nota che il suo buon salario da impiegato raggiunge il
doppio di quello imprenditoriale ³paragonato². Migliorerà la situazione dopo
l¹ammortamento dell¹investimento ma dovrebbe praticamente raddoppiare la
tariffa oraria a 90.- fr. per trovarsi pari al mensile paragonato. Non pensa
che la sua attuale clientela sia disposta a pagarlo queste tariffe di propria
tasca (lui non lavora con le casse malati).
È un
grattacapo per diversi mesi finché insieme alla moglie decidono di:
-
Ridurre le loro esigenze materiali.
-
Lavorare per qualcosa di più soddisfacente.
-
Accettare la sfida di una minore sicurezza materiale.
-
Sperando di sentirsi meno stressati e più sciolti anche nella loro relazione.
Notano
però subito l¹imbuto: la realizzazione del progetto costerebbe ca. 350 ore.
Essendo
già sopraffatto dagli 80 clienti, che non conviene perdere, non gli rimane il
tempo di farlo, chiede alla sua brava moglie di partecipare con le sue forze e
prevedono di dedicare le prossime grandi vacanze al ³progetto².
Così
l¹hanno fatto e il mio amico è diventato terapista/naturopata, lavora
tantissimo ed è meno stressato che mai nella sua vita, e sua moglie lo sostiene
con entusiasmo.
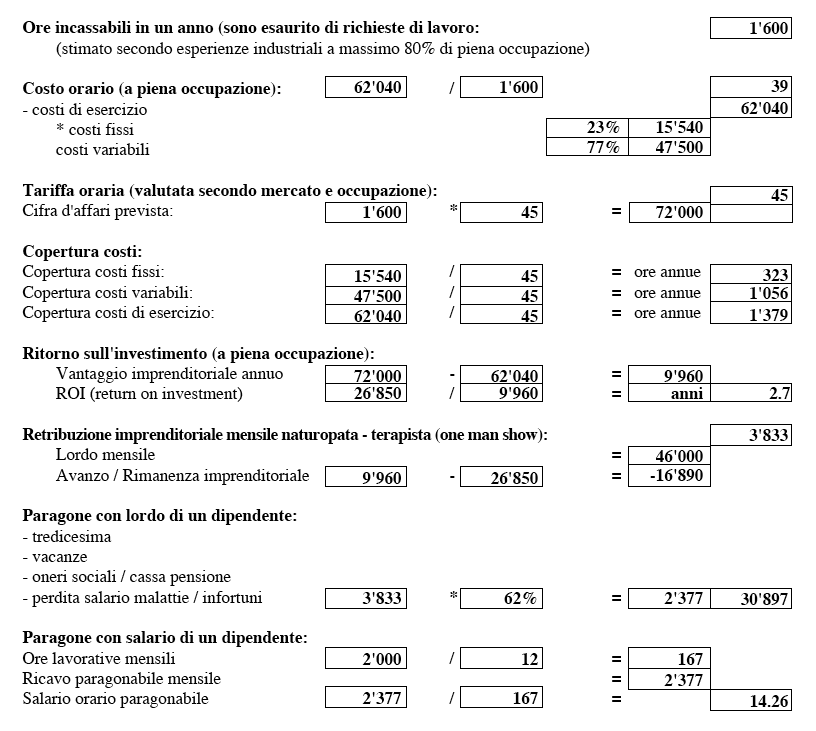
8.0 Esercizio di uno studio naturopatico
Il seguente esempio d¹esercizio
è proprio il mio di due anni fa, non per esibizionismo ma mi difendo meglio sul
discorso delle mie proprie cose.
Le cifre corrispondono
abbastanza con la mia realtà, anche se l¹ispettore del fisco non mi crede e mi
tassa maggiormente.
Vengono trattati i seguenti
temi:
8.1 Esempio budget di esercizio
8.2 Esempio di ragionamenti economici
sull¹esercizio
8.1 Esempio Budget d¹esercizio
Il seguente esempio dimostra un
budget (previsione) per l¹anno 1998. Le attività sono:
- Lavoro operativo nel proprio
studio di Locarno, a Biasca 5 giorni al mese presso Stelio e a Lugaggia in
collaborazione con Bianca 9 giorni al mese. A Lugano tengo due sere al mese un
corso di naturopatia. Per il lavoro all¹esterno devo calcolare le spese della
macchina.
- Il lavoro operativo è dedicato
maggiormente al lavoro sul corpo, poi consultazioni come medico naturalista e
consulente per rimedi naturopatici. Come lavoro ³dispositivo² tengo in considerazione
i viaggi in macchina. Amministrazione e gestione ho pochissimo; visto che non
collaboro con le casse malati rimangono i lavori per le imposte e rare ricevute
per clienti che lo desiderano nonché il budget e scarsi controlli economici
dell¹operato.
L¹agenda me la tengono mia
moglie, Rosmarie, Stelio e Bianca.
- Ho tante ore operative in un
anno, visto che le liste d¹attesa dei clienti sono di parecchi mesi.
- Le ore di preparazione e per
tenere le relazioni naturopatiche sono incluse (non la stesura delle dispense
che faccio di domenica come passatempo).
- Come compensa imprenditoriale
introduco il mio minimo esistenziale per le ore operative (le ore dispositive e
gestionali non ne le conto imprenditorialmente), non avendo particolari
obblighi e una brava moglie che guadagna anche qualcosina.
- Non ho particolari
assicurazioni e il poco che c¹è è incluso nel privato.
- Visto che lavoro da parecchi
anni nel mio proprio studio e il mio lavoro non comporta rilevanti
investimenti, quest¹ultimi sono modici (quest¹anno con ca. 2000.- fr.)
8.2 Esempio di ragionamenti economici
sull¹esercizio
- Prevedo per quest¹anno 2¹540
ore ³incassabili² lavorando però un totale di quasi 3¹000 ore.
- Risulta così un costo orario
di 33.- fr. e una cifra d¹affari di 84¹000 fr. I costi fissi sono accettabili
con ca. 14¹000.- fr. (17% corrispondente a 400 ore annue per coprirli).
- Non volendo lavorare né con le
casse malati né con i ricchi annoiati nevrotici (che oltre a condizionarmi mi
caricano anche di lavori amministrativi che detesto) stabilisco una tariffa
oraria modica di 35.- fr. in media, un po¹ diversa nei diversi posti di lavoro.
Questo permette anche ai miei clienti non benestanti, di farsi curare (certi
dicono che il mio trattamento costa loro meno della franchigia della cassa
malati per il dottore e i suoi medicamenti).
- Questo mi da un ³vantaggio
imprenditoriale² di ca. 4¹600.- fr., con il quale riesco ad ammortizzare gli
investimenti di ca. 2¹000.- fr. e mi rimangono come avanzo imprenditoriale ca.
2¹600.- fr.
- Come ³lordo indipendente²
prevedo quindi ca. 53¹000.- fr. corrispondente a un mensile di ca. 4¹500.- fr.
- Paragonato con un ³lordo dipendente² corrisponde però a soli ca. 36¹000.- fr.
annui o 2¹800.- fr. mensili, visto che ferie, vacanze, assicurazioni sociali,
rischi di malattia e infortuni e altre previdenze sono tutti esclusivamente a
mio carico.
- Se calcolo anche le ore che
devo lavorare per questi soldi (212 al mese), arrivo a un orario paragonato di
13.- fr. (forse perché sono nato il giorno tredici).
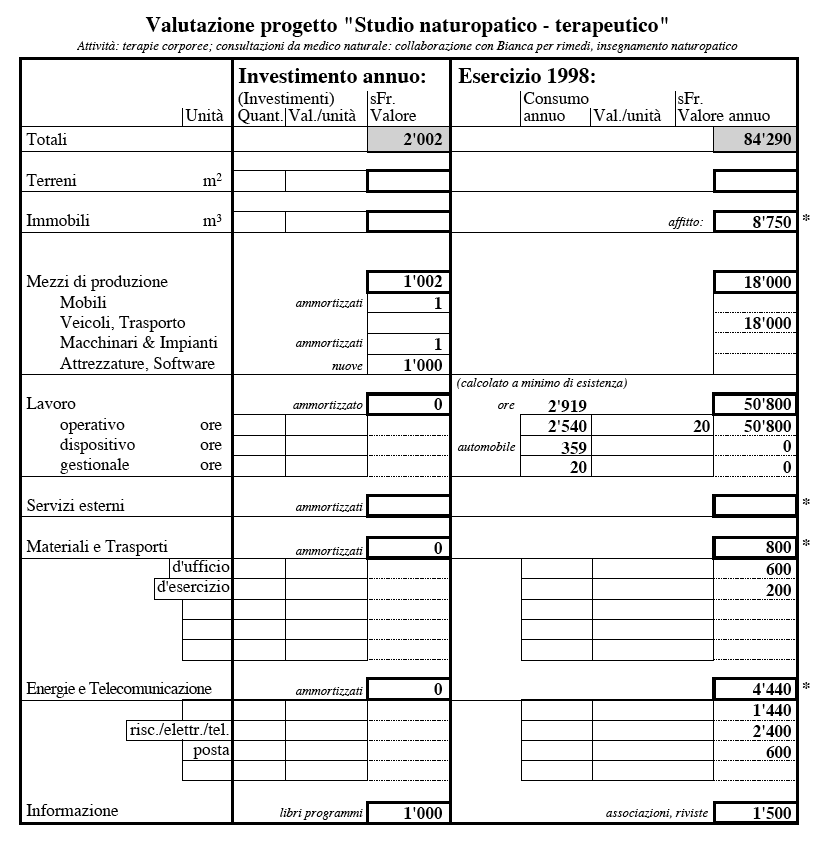
³E per questa miseria lavori
tanto?² mi chiederete. Sì, e non desidero altro, perché a parte la mia tendenza
a ideali francescani:
- Mezzo milione di abitanti
Svizzeri sono costretti a lavorare per meno di 3¹000 fr. mensili e mi sento in
buona compagnia con quasi il 20% della popolazione attiva, a differenza di
loro, io non sono costretto a farlo ma me lo sono scelto e non cambierei.
- La soddisfazione, il benessere
e la voglia, il successo, l¹autonomia e l¹equilibrio interno che mi da il mio
mestiere e le relazioni umane con i miei clienti, sono molto più forti delle
mie esigenze per una vaga sicurezza economica; non ho proprio meglio da fare che
lavorare.
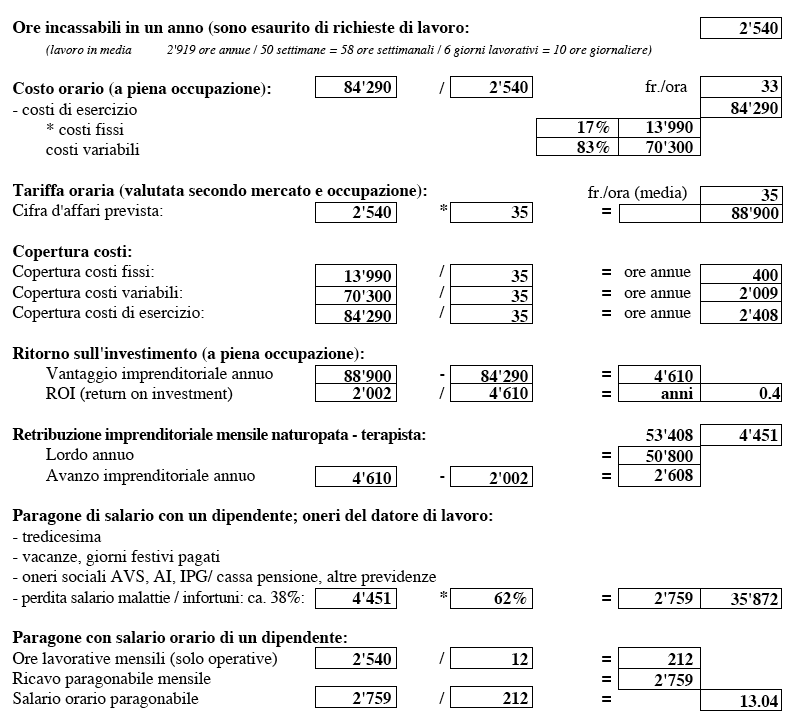
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |