|
|
Medicina popolareper autodidatti
luglio 27, 2005 |
|
Indice della pagina 1.4 Fonti e riferimenti generali 1.5 Valutazione etica e morale 1.6 Comportamenti, sanzioni e gratificazioni 2.0 Il giuramento di Ippocrate 2.2 Gratitudine e obblighi verso l¹insegnante 2.3 Tramandamento e obblighi d¹istruzione 2.4 Obblighi verso gli ammalati 2.6 Conduzione di vita e professione 2.7 Rispetto verso le altre professioni sanitarie 2.8 Comportamento verso gli ammalati 3.2 Sintomi psichici del cliente 3.7 Le indicazioni del terapista |
MN 2.3 Morale ed etica
professionale
© Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: MmP 4.3 Sito utile: Etica & Politica
Chiese di S. Francesco, Locarno |
Per il seguente referto
oltre agli autori classici¾ noti mi sono servito specialmente di due testi:
* Freud, S.: Il disagio della civiltà,
* Müller, Dr.
Peter: Zur Aesthetik des Scheiterns in der komplementären Medizin (Estetica
del fallimento nella medicina complementare): Referto al congresso "Krebs in der
Naturheilkunde", Berlino 5.99, note personali.
1.4 Fonti e riferimenti generali
1.5 Valutazione etica e morale
1.6 Comportamenti, sanzioni e gratificazioni
Etica
(greco ethos => usanza, costume): ramo della filosofia pratica che tratta:
- Usanze,
costumi e comportamenti umani
-
Intenzionali, di fatto, di obiettivo o di conseguenza
- In un
determinato contesto.
Morale
(lat. mores => costumi): tratta più i costumi comportamentali e i criteri
del loro giudizio nel contesto situativo.
Secondo un
criterio delle corti militari elvetiche i ³motivi etici² sono (o erano)
considerati come ³intenzioni assolute incondizionate² (p.e. ³mai ammazzare una
persona²) mentre ³i motivi morali² relativizzano ³principi etici assoluti²
(p.e. ³mai ammazzare una persona se non in condizioni di legittima difesa²),
usando dei criteri di ³minor male². Questo fatto mi è noto perchè come
obiettore di coscienza venni giudicato e condannato in base a questo criterio.
Nell¹uso
comune si definiscono ³etiche² delle dichiarazioni intenzionali riguardanti
fatti esistenziali dell¹uomo, mentre i comportamenti relazionali e sociali si
giudicano con criteri di ³morale² (costumi e usanze ideali).
Si vede da
queste poche righe che i termini di etica e di morale non sono ben delimitati
ma che si tratta di convenzioni di giudizio sociale di usanze e di costumi. È
quindi evidente che ³etica² e ³morale² sono dei fatti culturali che si fondano
idealmente su valori e loro gerachie caratteristiche per diverse culture ed
epoche.
Gli
amministratori di queste convenzioni e valori (e dei loro difficili contrasti
intrinsici) erano da tempi remoti i sovrani, i sacerdoti e i giudici, spesso in
alleanze variabili, viste le loro differenziazioni di funzioni amministrative e
i loro divergenti interessi personali e di corporazione in interazione con le
esigenze del pubblico ideologicamente amministrato (che in ultimo nutre i
gestori).
Lo studio
della storia fornisce già all¹interno di una cultura e lungo il percorso del
tempo i più sorprendenti esempi di usanze e costumi (morale ed etica).
Dal punto
di vista ³funzionale², etica e morale determinano le regole di convivenza di
individui, in una società con ruoli e interessi contrastanti per i singoli
membri di questa società e con valutazioni divergenti di compiti, diritti e
responsabilità per i singoli verso il loro prossimo e verso ³la comunità²,
sempre in base alla valutazione ³generale² circa l¹importanza del singolo e
della ³comunitಠ(famiglia, corporazione, comunità, religione, partito, paese,
cultura, razza, nazione, stato, ).
È però
limitativo affrontare l¹argomento solo da questo lato. Sembra un¹esigenza umana
(salvo forse per gli individui più cinici) quella di giustificare le proprie
opere, mosse e intenzioni davanti a loro stessi, alle persone amate/ammirate
e/o rispettate/temute e davanti alle autorità terrestri e/o celesti. E questo richiede
dei riferimenti, dei ³codici² orali oppure scritti.
Sono
partito dal seguente modello dell¹essere umano:
- Interessi
e dinamica di gruppo (costumi, usanze, abitudini, comportamenti, atteggiamenti,
convenzioni).
- Verso
desideri, speranze, sogni, aneliti, ansie, paure, disagi, serenità, euforie,
depressioni, incertezze, creatività, instabilità, rassegnazione, disperazione
del singolo.
- Mediato
da legami umani bilaterali come amicizie, collegialità, compagnie,
innamoramenti
- Sul fondo
della struttura e del funzionamento ³biologico² dell¹essere umano.
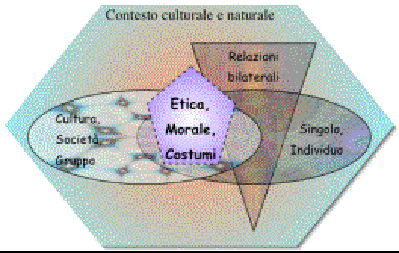
1.3 Riferimenti personali
Oltre a
costumi, usanze, abitudini, comportamenti, atteggiamenti, convenzioni del
mestiere terapeutico impostate tacitamente da esigenze e aspettative dei
clienti, sono codificate delle norme etiche e morali relative alla professione:
- Codice
penale e civile.
- Leggi
sanitarie federali e cantonali.
- Norme,
regolamenti e codici di associazioni professionali.
Al di là di
tutto questo per me valgono dei principi etici e morali appresi da:
- Antichi
filosofi greci (per me più le scuole della Stoa e degli Epicurei che Aristotele
e Platone) fino ai recenti, come Jeanne Hersch.
- Le radici
di una società cristiana nella quale sono stato educato.
- Le
convenzioni di una società laica democratica Svizzera e Ticinese.
- Le
massime etiche del giuramento di Ippocrate interpretate per la mia realtà
sociale (per cui mi permetto di commentarlo in seguito).
- Le
massime morali tramandate dai miei insegnanti venerati (meno di lettera che di
intento, per cui li presenterò di seguito in forma dialettica ed
epigrammatica).
Per il mio lavoro pratico e relative valutazioni tento di
rispettare il mio cliente nelle sue dimensioni
sociali, individuali psichiche e biologiche in una specie di
³socio-psico-biologismo².

1.4 Fonti e riferimenti generali
Chissà per
quale motivo gli amministratori di turno di etica e morale e i loro seguaci,
difensori e alleati, si riferiscono volentieri a principi immutabili, sacri, non
toccabili per vendere l¹ultima novella sociale al pubblico (dalla moda
stilistica di vita fino alla religione). I loro riferimenti preferiti sono:
- Testi
sacri (illuminati, profetici, ispirati, ) tramandati da millenni e spesso di
dubbie fonti;
incontrollabili
da parte del profano a causa delle difficoltà linguistiche e culturali. Non
parliamo poi del mito di persone come Profeti, Signori o Dei legati a questi
testi. Esempio: ³I dieci comandamenti² del catechismo che malgrado il mio
penoso studio dell¹ebraico non ho mai trovato in forma paragonabile nella
Thorah.
- Leggi
naturali come se la natura potesse essere una scusa per la cultura e come se
chi la cita fosse in grado di capirla con la sua povera mente e di dedurre
delle ³regole o leggi o misteri² applicabili per una struttura sociale recente.
Lo strano è che sia tecnocrati che ecologisti difendono le loro ideologie
facendo riferimento alle scienze naturali, gli uni più con la fisica, gli altri
più con la biologia.
logica
della ragione:
- culturale/istituzionale
-
generalizzata
-
"socio-logica"
logica
del sentimento:
-
individuale/relazionale
-
particolarizzato
-
"psico-logico"
logica
di vita e morte:
-
naturale/simbiotica
- evolutiva
-
"bio-logica"
"socialdarwinismo"
"egocentrismo"
"anthropocentrismo"
"sociopsicobiologismo"
contesto
culturale
contesto
naturale
-
³Intenzioni mistiche² da divine a evolutive, come se qualcuno potesse saperle o
dedurle premesso che un essere divino o una forma di evoluzione si esprimano
con intenzioni, nel senso che diamo noi al termine, premesso che qualcosa come
una divinità o un¹evoluzione esista e premesso che si possa dedurre una spece
di ³socialdarwinismo² o di punizione/ gratificazione divina da tutto ciò.
- Processi
evolutivi di culture passate, ignorando che a lungo sono falliti e le culture
stesse sono sparite tutte, salvo le recenti. E proprio i razzisti, megalomani e
arroganti di tutti gli stampi si servono di argomenti di questo tipo.
- Teorie,
ipotesi e speculazioni su processi sociali (prevalentemente economici) dal
socialismo fino al liberalismo e la ³globalizzazione², dimenticando che le
regole etiche-morali stesse condizionano i processi sociali che prendono come
argomento per le loro deduzioni.
-
Tradizioni culturali, come se l¹anzianità di una stupidaggine la rendesse più
nobile e come se il cambiamento di condizioni sociali non mutasse le regole di
convivenza.
-
Dichiarazioni sociopolitiche come il ³codice dei diritti umani², che tenta di
stabilire un minimo indispensabile di compiti, competenze e responsabilità
individuali verso ³la societಠe i suoi gestori e amministratori. Questo
documento ha almeno il buon gusto di non riferirsi all¹eterno e all¹immutabile
e rimane così adattabile perchè passibile di discussione, anche se bisogna
obiettare che le norme in esso contenute hanno un forte tocco di società
³individualistico- democratico-cristiana² e si astengono completamente da
condizionamenti biologici.
- Leggi e
norme, da statali fino a corporative, con relative sanzioni e ogni tanto
privilegi per il caso di efrazioni che in organizzazioni democratiche si
riferiscono al consenso della maggioranza degli aventi diritto di voto, in
altre organizzazioni sulla volontà legifera del relativo sovraneo.
- Usanze
sociali, dalla moda fino ai buoni costumi, che si riferiscono ai principi
spirituali fino al buono o cattivo gusto ed hanno in comune che sono facilmente
mutabili e seguono dei processi generativi casuali, confusi e contraddittori;
spesso sono un miscuglio argomentativo qualunquistico di riferimenti
sovrastanti, dall¹eterno fino all¹opportunistico della moda vigente.
1.5 Valutazione
etica e morale
Ricordo una
frase del vangelo: ³chi è privo di colpa lanci il primo sasso².
Nel
rapporto terapeutico, una valutazione etica e morale del terapista verso i
clienti ogni tanto è inevitabile per motivi curativi. Se capita, il cliente ha
il diritto di sapere i motivi, le conclusioni, le conseguenze della tua
riflessione e eventualmente i consigli che hai da dare. Tutto il resto è sleale
verso il cliente e antiterapeutico.
A chi del
resto come terapista si sente di giudicare il suo cliente, consiglio di
scegliersi un¹altra professione come p.es.:
-
Procuratore pubblico
- Giudice
- Sacerdote
- Politico
- Capo del
personale di un¹impresa
-
Poliziotto
- Guru di
una comunità spirituale
-
Presidente di una congregazione di giusti.
Il
giudizio, all¹infuori di necessità funzionali, ha degli effetti collaterali:
-
Abbrutisce il viso
- Rende
arrogante e/o bigotto
- Impedisce
la simpatia (che nasce sul terreno della comune debolezza)
-
Interrompe la riflessione e ti rende tonto
- Alimenta
il rancore verso di te
- Ti fa
sentire superiore, ma alla lunga non è divertente
- Porta un
alto rischio di assuefazione poco soddisfacente.
In seguito
sono presentati brevemente i quattro campi più conosciuti della filosofia
etica:
1.5.1 Etica intenzionale o dei valori: bene e male
1.5.2 Etica comportamentale (deontologica): giusto e sbagliato
1.5.3 Etica obiettivistica (teleologica): utile e futile
1.5.4 Etica delle conseguenze (responsabilità)
Una
valutazione o un giudizio serio (non a vanvera, a buon mercato o al posto di
una riflessione) coinvolge elementi intenzionali, comportamentistici, di
obiettivi e di conseguenze. Il semplice fatto di essersi messo in discussione
su tutti e quattro questi piani evita una mancante differenziazione e permette
una sintesi adatta alla funzione della valutazione stessa.
1.5.1 Etica intenzionale o dei valori:
bene e male
Quando sbagliavo da bambino e mia nonna mi faceva la predica (o sanzioni peggiori) e mi difendevo piagnucolando con l¹argomento: ³non l¹ho fatto apposta² lei si arrabbiava molto e mi rispondeva: ³ci mancherebbe anche che l¹avessi fatto apposta².
Relativizza
abbastanza il valore dell¹intenzione a scapito di un punto di vista della responsabilità,
per il fatto e non per l¹intento. In psicoterapia si nota spesso che una gran
parte dei sensi di colpa e dei rancori verso il prossimo si basano su ³giudizi
intenzionali² ipotizzati come negativi per il prossimo o per se stessi.
Quando
si indaga su possibili intenzioni alternative, spesso si scopre che sarebbero
altrettante fonti di sensi di colpa o rancori secondo criteri differenti.
In
pratica, di fronte alla scelta di una o l¹altra possibilità, entrambe
condurrebbero allo stesso effetto sulla persona.
Si
nota anche che coloro ai quali servirebbe veramente avere sensi di colpa, non
li hanno mai.
La
base di un¹intenzione sono dei valori e la loro gerarchia. In giurisprudenza si
chiamano beni giuridici e hanno una gerarchia di solito ben definita (p.es.: la
proprietà è inferiore alla vita umana, ).
A
livello giuridico, il giudizio dell¹intenzione diventa criminale ed è un grosso
strumento del potere per diffamare o sradicare gli avversari. Nelle
legislazioni democratiche normalmente è illecito un ³giudizio sull¹intenzione².
D¹altronde il grado di intento serve per adeguare la punizione (omicidio
premeditato o preterintenzionale).
Ci
sono degli individui che tentano ogni tanto di usare quest¹arma per scopi
pubblici (dall¹economia alla politica). Possono diventare un pericolo per la
società e sono da bloccare in tempo, ma purtroppo esistono pochi strumenti
giuridici a questo scopo.
Sottoporre
delle intenzioni all¹avversario è umanamente capibile da parte del più debole
(anche se ha un tocco di paranoia), è invece altamento sospettoso come arma del
vantaggiato verso lo svantaggiato.
1.5.2 Etica comportamentale (deontologica):
giusto e sbagliato
³Sono
i vestiti che fanno l¹uomo² come tipica valutazione di usanze e costumi.
È
un dato di fatto che colui che si comporta bene, gode di facilitazioni sociali
e davanti alle istituzioni, anche se dietro le quinte avesse oscure intenzioni
e obiettivi asociali e mancasse di qualsiasi responsabilità.
Preso
come criterio prevalente di valutazione, questo tipo di giudizio diventa
socialmente la madre di tutti i bigottismi e gli opportunismi. Anche ³farisei²,
legalistici e ³cosa dicono i vicini² si trovano in questo ambito di giudizio
moralistico. Lo strano è che una comunità non gratifica misuratamente
l¹opportunismo, ritenendo noioso e mediocre un tale comportamento individuale.
In psicoterapia si trovano qui le persone con complessi di inferiorità cronici
e quelle che creano ³occultamente² disastri e godono del plauso pubblico per le
loro proposte di rimediarle.
A
livello individuale si incontrano qui le persone ³che conducono una vita sana,
fanno tutto giusto e malgrado gli sforzi stanno male e si ammalano². E¹ la
storia degli amici di Giobbe che non vollero capire che il suo destino non era
una punizione divina, ma il frutto di una scommessa tra il Signore e un suo
figlio maldestro (malauguratamente a scapito dell¹unico Giusto reperibile non
conformista).
1.5.3 Etica
obiettivistica (teleologica): utile e futile
-
³L¹obiettivo consacra i mezzi² e
- ³non
perfezionare la tua personalità, ma concludere le singole tue opere² (G. Benn).
L¹accento
di questo criterio di valutazione etica-morale è posto sull¹obiettivo,
sull¹utilità di una mossa o di un evento legato allo scopo e sulle conseguenze
di questi ultimi per ³l¹opera². I punti deboli di questo approccio sono:
- La
valutazione e la scelta dell¹obiettivo (forse non è gradito).
- Restano
impliciti i fattori imponderabili di realizzazione, visto che ogni obiettivo
non solo è una scelta (aleatoria) ma anche una ipotesi.
In
psicoterapia si trovano qui spesso le figure di imprenditori (raramente di
manager) stupiti del fatto che gli altri non solo non sembrano interessati alle
loro opere, ma osano criticare i modi della loro realizzazione e chiedono
responsabilità per gli effetti collaterali dei processi e meccanismi messi in
moto. La terapia di queste persone può essere abbastanza difficile, perchè
l¹abitudine di aver successo rovina parecchio la comprensione anche di altri
valori.
Certo è
limitativo e riducente basare valutazioni e giudizi prevalentemente su scopo,
utilità e relative implicazioni loro connesse, ma bisogna anche ammettere che
³intenzionisti, comportamentisti e responsabilisti² messi assieme non sarebbero
in grado di produrre un solo sacco di patate:
- Per
sfamare l¹ 80% della popolazione mondiale affamata degli ³intenzionisti².
- In
condizioni igieniche che non disturbino nessuno tranne i ³comportamentisti².
-
Assumendosi la responsabilità per la ³distruzione della natura² perchè fanno
una ³coltivazione di patate² impedendo così la crescita di boschi selvaggi.
Devo
ammettere che ho una piccola simpatia per gli ³obiettivisti² anche se parecchi
di loro detesto di cuore. Sarà perchè mi sentivo da sempre più vicino alla
figura di Isaù che a quella di Giacobbe.
1.5.4 Etica
delle conseguenze (responsabilità)
- O come
Sisifos venne ³responsabilizzato².
- O come
Gesù porta in spalla i peccati dell¹umanità.
- E per
compenso i cristiani troppo peccatori sono bruciati all¹inferno.
Si trova
qui la fonte della colpa della quale gli ³intenzionalisti² soffrono tanto e
senza motivo concreto. E non ho mai incontrato persone che temessero più la
responsabilità quanto i responsabili.
Nelle
nostre società l¹etica della responsabilità prende fortunatamente piede fino
alle sfortunate perversioni legislative statunitensi che tentano con
ultraformalismi di scaricare sempre più responsabilità dall¹individuo verso le
istituzioni.
Fortunatamente
la teoria dell¹organizzazione moderna ci fornisce dei criteri di valutazione
applicabili e sufficientemente plausibili tramite i seguenti ³dogmi², che
sarebbero una condizione per far funzionare bene un¹organizzazione:
-
All¹interno di un¹organizzazione uno svolge un compito con obiettivi definiti
secondo la sua indole, la sua capacità e la sua istruzione in reciproco accordo
con l¹istanza superiore e con il consenso dei diretti coinvolti.
- Può
disporre autonomamente di mezzi e strumenti necessari per svolgere questo
compito e raggiungere lo scopo.
- Ha la
responsabilità con sanzioni definite per l¹impiego razionale di mezzi e
strumenti e per lo svolgimento definito dei compiti.
- Esistono
delle istanze indipendenti per il controllo di esito e obiettivi.
Questi
dogmi hanno i loro limiti in quanto l¹istanza ³creativa² e ³controllore² di
obiettivi e compiti rimane oscura. Ma almeno tentano di delimitare il
dispotismo quotidiano all¹interno di grandi organizzazioni anonime.
In
psicoterapia incontriamo spesso qui tutti i quadri, dai più bassi ai
manageriali, che:
- da una
parte soffrono di organizzazioni dispotiche,
- e
dall¹altra di accuse da parte dei ³fondamentalisti² di ogni tipo ideologico,
con ottime intenzioni e scarsi compiti, competenze e responsabilità concrete.
Per noi
terapisti, che siamo di solito dei piccoli imprenditori, la questione della
responsabilità e delle relative ³sanzioni² è forse la più cruciale e secondo me
non è formulabile in modo generalizzato. In modo pragmatico per ogni singolo
cliente devo:
- Porre un
obiettivo terapeutico (in funzione a una valutazione razionale del disturbo).
- Chiedermi
di quali mezzi e strumenti dispongo per poter svolgere questo compito e cosa
devo delegare a terapisti/ medici più adatti di me.
- Chiarire
dove sono i dubbi, incertezze, carenze, possibilità di valutazione errata mia
ed eventuali loro conseguenze, se sbaglio indicazione o tralascio consigli per
analisi/ cure.
-
Continuamente controllare l¹effetto curativo delle misure proposte e
paragonarlo cogli obiettivi fissati; correggere il tiro, o proporre altre
misure.
- Mai
caricare questi miei problemi sul povero cliente il quale dovrebbe invece poter
scaricare di un po' dei suoi problemi su di me.
1.6 Comportamenti,
sanzioni e gratificazioni
Comportamenti
e atteggiamenti del singolo in un determinato contesto sociale sono scontati se
rientrano in certe convenzioni; sanzionati se deviano in modo rilevante dai
valori sociali e gratificati (p.es. in forma di reputazione) se adempiono più
del dovuto a questi valori.
Il sistema
di sanzioni è parecchio elaborato e differenziato, come dimostra il seguente
grafico, mentre le gratificazioni e motivazioni sembrano meno evolute.
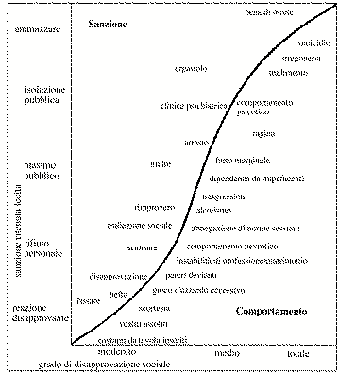
2.0 Il
giuramento di Ippocrate
Ippocrate,
medico greco sull¹isola di Kos, ca. 460370 a.C., fondatore della medicina
³scientifica², fortemente influenzato della medicina ayurvedica. Testo in
italiano della Biblioteca Cantonale, Lugano.
IL GIURAMENTO
"Giuro
su Apollo medico e su Asclepio e su Igea e su Panacea e sugli dèi tutti e le
dee, chiamandoli a testimoni, di tener fede secondo le mie forze e il mio
giudizio a questo giuramento e a questo patto scritto. Riterrò chi mi ha
insegnato quest¹arte pari ai miei stessi genitori, e metterò i miei beni in
comune con lui, e quando ne abbia bisogno lo ripagherò del mio debito e i suoi
discendenti considererò alla stregua di miei fratelli, e insegnerò loro
quest¹arte, se desiderano apprenderla, senza compensi né impegni scritti;
trasmetterò gli insegnamenti scritti o verbali e ogni altra parte del sapere ai
miei figli così come ai figli del mio maestro e agli allievi che hanno
sottoscritto il patto e giurato secondo l¹uso medicale, ma a nessun altro.
Mi varrò
del regime per aiutare i malati secondo le miei forze e il mio giudizio, ma mi
asterrò dal recar danno e ingiustizia.
Non darò a
nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale
consiglio: ugualmente non darò alle donne pessari per provocare l¹aborto.
Preserverò pura e santa la mia vita e la mia arte. Non opererò neppure chi
soffre di mal della pietra, ma lascerò il posto ad uomini esperti di questa
pratica.
In quante
case entrerò, andrò per aiutare i malati, astenendomi dal recar volontariamente
ingiustizia e danno, e specialmente da ogni atto di libidine sui corpi di donne
e uomini, liberi o schiavi. E quanto vedrò e udirò esercitando la mia
professione, e anche al di fuori di essa nei miei rapporti con gli uomini, se
mai non debba essere divulgato attorno, lo tacerò ritenendolo alla stregua di
un sacro segreto.
Se dunque
terrò fede a questo giuramento e non vi verrò meno, mi sia dato godere il
meglio della vita e dell¹arte, tenuto da tutti e per sempre in onore. Se invece
sarò trasgressore e spergiuro, mi incolga il contrario di ciò. ³
2.2 Gratitudine e obblighi verso l¹insegnante
2.3 Tramandamento e obblighi d¹istruzione
2.4 Obblighi verso gli ammalati
2.6 Conduzione di vita e professione
2.7 Rispetto verso le altre professioni sanitarie
2.8 Comportamento verso gli ammalati
- Giura
chiamando:
- Apollo:
1)
- Asclepio:
2)
- Hygieia:
3)
- Panacaia:
4)
- Tutti gli
altri dei e dee come testimoni.
- Secondo
migliore capacità e giudizio.
- Di
rispettare il giuramento e i relativi obblighi.
Commento:
- Apollo:
Figlio di Zeus e Leto. Gemello di artemide. Padre di Asclepio. Signore della
manzia e delle arti. Può lanciare col suo arco d¹argento disgrazia, malattia e
sofferenza, ma anche guarirli. Più tardi anche padrone di poesia, armonia e
ordine.
- Asclepio:
Figlio di Apollo e Coronis. Padre di Hygieia. Signore dell¹arte guaritrice
(scettro di Asclepio).
- Hygieia:
figlia di Asclepio. Signora della salute.
- Panacaia:
Signora della fertilità universale.
Cita i
Signori e le Signore dell¹arte come testimoni, stabilendo così un programma
medico simboleggiato con le figure mitiche dell¹epoca.
2.2 Gratitudine
e obblighi verso l¹insegnante
- Di
rispettare l¹insegnante dell¹arte come i genitori.
- Di
dividere con lui i viveri.
- Se si
trova in miseria, di approvvigionarlo.
- Di
trattare i suoi discendenti come fratelli e se lo desiderano.
- Insegnare
loro l¹arte senza contratto e compenso.
Commento:
rispetto verso l¹insegnante dell¹arte, riconosciuto come istanza di giudizio e
potere decisivo; partecipazione e solidarietà economica e fratellanza con i
discendenti del maestro.
Rispecchia
nel contesto delle condizioni sociali di allora la forte prevalenza del
principio di ³sovranità domestica². Nella nostra cultura la ³sovranità
domestica² si è trasformata in ³sovranità di istituzioni politiche e sociali² e
la fratellanza è stata sostituita dalle assicurazioni sociali.
2.3 Tramandamento
e obblighi d¹istruzione
Consiglio,
relazione e istruzione:
- Ai miei
figli e ai figli del mio insegnante senza compenso.
- Ai
discepoli legati per contratto e giuramento secondo l¹usanza medica.
- A
nessun¹altro.
Commento:
rispecchia l¹organizzazione professionale medica dell¹epoca ³ereditaria e
corporativa² (come quasi tutte le professioni) con forti obblighi e
responsabilità a quei tempi reciproci tra maestro e discepolo. Nella nostra
cultura del sistema corporativo è rimasta solo la parte pressoché monopolizzata
di licenze e prezzi.
2.4 Obblighi
verso gli ammalati
Indicazioni
per gli ammalati:
- per il
profitto e il benessere;
- secondo
le mie migliori capacità e il mio giudizio;
-
proteggerli dai danni
- e dalle
ingiustizie.
Commento:
strana e rara massima nell¹antichità: era quella di agire nell¹interesse del
più debole, di proteggerlo e di astenersi di sfruttare il proprio potere.
Atteggiamento che era un ideale esclusivo del capo della stirpe verso i suoi
familiari.
- Non dare
a nessuno un veleno letale.
- Anche se
me lo chiede.
- Nemmeno
consigliarlo.
- Non
consegnare a nessuna donna un abortivo.
Commento:
forse serviva per mantenere alta la reputazione dei medici contro la diffidenza
sociale verso chi disponeva di strumenti letali ³ermetici².
2.6 Conduzione
di vita e professione
Mantenere
sacra e pulita la propria vita e la professione.
Commento:
evidentemente serviva per mantenere una buona reputazione dei medici e forse
era espressione di una profonda religiosità e di gratitudine verso gli dei che
permettevano di curare.
2.7 Rispetto
verso le altre professioni sanitarie
Non operare
i calcoli della vescica urinaria, ma lasciarlo a chi è artigiano del mestiere.
Commento:
rispetto verso ³il chirurgo² come professionista con propria corporazione e
obbligo di non invadere il suo campo.
2.8 Comportamento
verso gli ammalati
Entrerò
nelle case:
- per il
profitto e benestare degli ammalati;
-
astenendomi da ingiustizia, vendetta e altri danni
- e dalle
opere voluttuose sui corpi di donne e uomini, liberi e schiavi.
Commento:
rispetto per il ³regno domestico² con il capo della stirpe come unico sovrano.
- Ciò che
vedo e sento durante il trattamento e anche all¹infuori nella vita delle
persone, non deve essere oggetto di pettegolezzo.
- Sono
silenzioso
- e
rispetto il segreto.
Commento:
pare che anche nell¹antichità si spettegolava volentieri e si riteneva questo
comportamento un danno per l¹arte.
Se compio
questo giuramento e non lo tradisco mi sarà concesso:
- successo
nella vita e nella professione;
- ottima
reputazione dalle persone in eterno.
Se lo rompo
e non lo rispetto otterrò il contrario.
Commento:
pio desiderio (non solo) antico che i padroni dell¹arte gratificavano e
punivano secondo il merito.
Il metodo
terapeutico come tale fornisce pochi elementi per valutare se è appropriato. È
più importante la capacità del terapista. Con il buon senso si riflette meglio
³per eliminazione² che ³positivamente². Un terapista è un bravo artigiano se:
- sa usare
bene i suoi strumenti;
- se ne
intende dei servizi che offre;
- se riesce
a reggere una relazione terapeutica con il suo cliente.
Tutti i
terapisti (e forse tutti gli operatori sanitari) sono confrontati con i
seguenti temi relazionali.
Io valuto
un operatore sanitario, fra l¹altro, anche in base alla sua posizione riguardante
le sue relazioni terapeutiche.
Sono
trattati i seguenti temi:
3.2 Sintomi psichici del cliente
3.7 Le indicazioni del terapista
3.8 La disponibilità del terapista
3.9 Autonomia di
cliente e terapista
Il cliente
(o: soggetto, paziente, utente) è normalmente una persona in stato di ansia,
paura, incertezza, preoccupazione, emozionalità per la sua malattia, il suo
disagio o il suo difetto: ambienti, comportamenti o discorsi del terapista che
accentuano questi stati d¹animo non solo sono non professionali, ma anche
antiterapeutici. Come disse mia nonna: il cliente deve uscire un po¹ più
eretto, lo sguardo un po¹ più chiaro e un po¹ più sorridente di quando è
entrato.
3.2 Sintomi
psichici del cliente
Il cliente
reagisce spesso ai suoi stati d¹animo manifestando sintomi (più o meno acuti)
narcisisti, schizoidi, maniaci, depressivi, fobici, isterici: questi sintomi
possono dare indicazioni sul modo in cui il cliente affronta delle difficoltà.
È tuttavia poco rispettoso giudicare il cliente secondo tali criteri ed è
antiterapeutico interferire con essi, in quanto scompaiono da soli una volta
superata la difficoltà e nel frattempo servono da difesa (anche se scomoda).
Il cliente
ha delle ³idee strane²: il che vuol dire che sono diverse dalle mie. Se voglio
interferire in questo campo non devo fare il terapista, ma l¹insegnante o il
missionario. Citerò in proposito una massima di mia nonna zingara: ³Mai
rispondere alle domande non poste, ma sempre a quelle poste².
Il cliente
ha dei comportamenti ³non idonei²: per correggerli dovrei fare il poliziotto.
Il cliente
è bugiardo: quando io mi comporto da giudice.
Il cliente
non vuol farsi aiutare: con giusta ragione. Perché non sono il suo angelo
custode (anche se talvolta mi piacerebbe assumere quel ruolo arrogante) ma
rendo modestamente un servizio, come un cameriere, e il cliente, direttamente o
indirettamente, mi paga.
3.7 Le
indicazioni del terapista
Il cliente
non segue i miei consigli/indicazioni: se non sono riuscito a trovare quei
consigli/indicazioni che il cliente possa applicare, devo dichiarare fallito il
mio tentativo e consigliare un terapista più idoneo.
3.8 La
disponibilità del terapista
Il cliente
mi disturba per qualsiasi sciocchezza: sto diventando il suo guru. Sono però
terapista. L¹obiettivo è che il più presto possibile il cliente non abbia più
bisogno di me, o perché è guarito o perché gli ho mostrato come arrangiarsi da
solo.
3.9 Autonomia
di cliente e terapista
Il cliente
dipende da me, quindi deve attenersi alle mie regole: non è da gentiluomo
approfittare della miseria del prossimo.
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |


