|
|
Medicina popolareper autodidatti
agosto 1, 2005 |
|
Indice della pagina 1.0 Generalitā
sulle funzioni digestive 2.0 Digestione 2.1 Digestione meccanica 2.2 Digestione chimica 3.0 Controllo
della secrezione delle ghiandole 4.0
Assorbimento 5.0
Eliminazione 6.0 La
digestione e il corpo nellšinsieme 7.0 Meccanismi
di malattia |
AF 5.25 Fisiologia del
sistema digerente
Š Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 11
|
INDICE:
1.0 Generalitā
sulle funzioni digestive
1.1 Funzione
primaria del sistema digerente
1.2 Meccanismi
impiegati
2.0 Digestione
2.1 Digestione
meccanica
2.1.1 Riduzione
2.1.2 Agitazione
2.1.3 Propulsione
2.1.4 Masticazione
2.1.5 Deglutizione
2.1.6 Peristalsi
e segmentazione
2.1.7 Regolazione
della motilitā gastrica e intestinale
2.2 Digestione
chimica
2.2.1 Enzimi
- ŗcatalizzatori organici˛
2.2.1.1 Classificazione
e denominazione degli enzimi
2.2.1.2 Proprietā
e comportamento degli enzimi
2.2.2 Digestione
dei carboidrati
2.2.3 Digestione
delle proteine
2.2.4 Digestione
dei grassi
2.2.5 Residui
della digestione
2.2.6 Trasformazioni
enzimatiche
2.2.7 Ruolo
della flora intestinale
3.0 Controllo
della secrezione delle ghiandole del sistema digerente
3.1 Secrezione
salivare
3.2 Secrezione
gastrica
3.3 Secrezione
pancreatica
3.4 Secrezione
della bile
3.5 Secreti
dellšintestino
4.0 Assorbimento
4.1 Processo
di assorbimento
4.2 Meccanismi
di assorbimento
5.0 Eliminazione
6.0 La
digestione e il corpo nellšinsieme
6.1 Omeostasi
nutritiva
6.2 Ruoli
secondari del sistema digerente
6.3 Collaborazione
con altri sistemi
7.0 Meccanismi
di malattia
7.1 Disordini
del tratto gastrointestinale
7.2 Disordini
del fegato e del pancreas
Come pro memoria uno schizzo dellšapparato digerente:
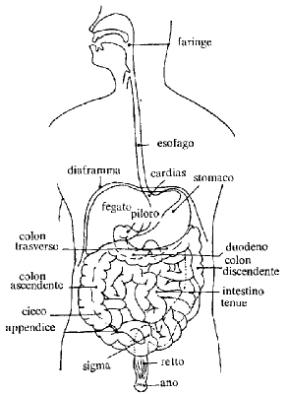
1.0 Generalitā
sulle funzioni digestive
Sono trattati i seguenti argomenti:
- Funzioni
primarie.
- Meccanismi
impiegati.
1.1 Funzione
primaria del sistema digerente
Assumere i nutrienti essenziali allšambiente interno
del corpo in modo che questi siano poi a disposizione di tutte le cellule
dellšorganismo.
Il seguente schema illustra il funzionamento e il
coinvolgimento di altri organi e sistemi:
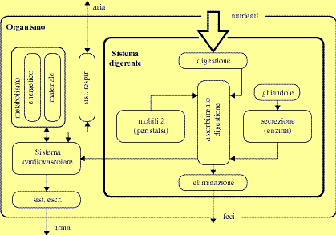
1.2 Meccanismi
impiegati
I meccanismi impiegati in tutto il sistema per
adempiere alle funzioni primarie sono:
- Ingestione:
assunzione dei cibi.
- Digestione:
scomposizione di nutrienti complessi in elementi semplici.
- Movimento
delle pareti: concorre alla riduzione di grandi pezzi di alimenti in frammenti
pių piccoli, a mescolarli con le sostanze secrete e provvede a fare avanzare il
materiale alimentare lungo il tratto gastrointestinale.
- La
secrezione di enzimi, acidi e basi consente la digestione chimica.
- Lšassorbimento:
passaggio dei nutrienti attraverso la mucosa gastrointestinale per entrare
nellšambiente interno.
- Lšeliminazione:
escrezione del materiale non assorbito.
2.0 Digestione
Sono trattati i seguenti temi:
- Digestione
meccanica.
- Digestione
chimica.
2.1 Digestione
meccanica
(Movimenti del tratto gastrointestinale)
Sono trattati i seguenti argomenti:
- Riduzione.
- Agitazione.
- Propulsione.
- Masticazione.
- Deglutizione.
- Peristalsi
e segmentazione.
- Regolazione
della motilitā gastrica e intestinale.
Il seguente schizzo mostra il nesso delle varie
funzioni di digestione meccanica:
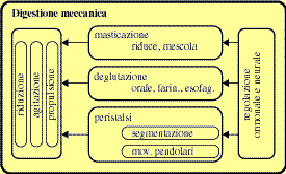
2.1.1 Riduzione
di grandi parti di cibo in particelle pių piccole per
facilitare la digestione chimica.
2.1.2 Agitazione
del contenuto nel lume gastrointestinale per
mescolarlo coi succhi digestivi e farlo pervenire in contatto con la superficie
della mucosa, favorendo lšassorbimento.
2.1.3 Propulsione
del materiale alimentare lungo il tratto
gastrointestinale per lšeliminazione delle scorie.
2.1.4 Masticazione
- Riduce
le dimensioni dei cibi.
- Mescola
i cibi con la saliva e li prepara per la deglutizione.
2.1.5 Deglutizione
(fig. 25-1)
Processo che richiede movimenti complessi, rapidi e
coordinati.
- Fase
orale (dalla bocca allšorofaringe): volontaria; formazione del bolo; la lingua
comprime il bolo contro il palato e lo spinge verso lšorofaringe.
- Fase
faringea: (dallšorofaringe allšesofago) involontaria; spinge il bolo
nellšesofago mentre ne viene impedito il passaggio alla bocca, rinofaringe,
trachea.
- Fase
esofagea (dallšesofago allo stomaco) involontaria.
2.1.6 Peristalsi
e segmentazione
(figg. 25-2 e 25-3)
- Movimenti
dovuti alla muscolatura liscia gastrointestinale cui si aggiunge il movimento
pendolare.
- Peristalsi:
motilitā progressiva che spinge distalmente il materiale gastrointestinale.
- Segmentazione:
movimento che blocca per breve tempo il chimo in un tratto dellšintestino,
mentre il movimento pendolare rimescola avanti e indietro il contenuto; ne
risulta una ulteriore riduzione dimensionale del contenuto, migliore mescolanza
coi succhi digestivi, contatto con la parete della mucosa per favorire
lšassorbimento.
2.1.7 Regolazione
della motilitā gastrica e intestinale
Motilitā gastrica: svuotamento dello stomaco in circa
2-6 ore; mescolamento col succo gastrico e formazione del chimo; ogni 20
secondi il fiotto di chimo viene spruzzato nel duodeno; svuotamento gastrico
controllato da meccanismi ormonali e neurali:
- Meccanismo
ormonale: nel duodeno i grassi stimolano il rilascio del peptide inibitore
gastrico che interviene deprimendo la peristalsi gastrica e rallentando il
passaggio del chimo nel duodeno.
- Meccanismo
nervoso: riflesso entero-gastrico. I recettori della mucosa duodenale sensibili
allšaciditā del chimo e alla distensione inviano impulsi sensitivi al nucleo
del nervo vago che, per mezzo delle sue fibre motrici, inibisce la peristalsi
gastrica.
La motilitā intestinale comprende la peristalsi, la
segmentazione e i movimenti pendolari.
- Segmentazione
per duodeno e digiuno.
- Velocitā
della peristalsi: una volta uscito dallo stomaco il chimo impiega circa 5 ore
per attraversare tutto il tenue e passare nel crasso.
- La
peristalsi č regolata in parte da riflessi intrinseci di tensione; stimolata
dalla colecistochinina pancreozimina (CCK).
2.2 Digestione
chimica
Le modificazioni della composizione chimica degli
alimenti, mentre procedono lungo il tratto gastrointestinale, sono il risultato
di idrolisi (decomposizione di lunghe molecole tramite enzimi e assorbimento di
acqua; anche dissociazione idrolitica).
Sono trattati i seguenti argomenti:
- Enzimi -
ŗcatalizzatori organici˛.
- Digestione
dei carboidrati.
- Digestione
delle proteine.
- Digestione
dei grassi.
- Residui
della digestione.
- Trasformazioni
enzimatiche.
- Ruolo
della flora intestinale.
Il
seguente schema da unšidea dei meccanismi svolti:
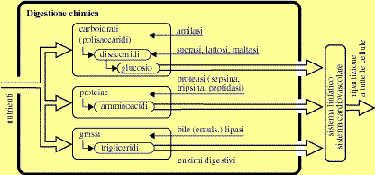
2.2.1 Enzimi
- ŗcatalizzatori organici˛
Struttura chimica degli enzimi: sono proteine;
possono contenere un gruppo prostetico.
In seguito una breve caratterizzazione degli enzimi
non solo digestivi ma altrettanto importanti per il metabolismo e altre
funzioni organiche.
Sono trattati i seguenti argomenti:
- Classificazione
e denominazione degli enzimi.
- Proprietā
e comportamento degli enzimi.
2.2.1.1 Classificazione
e denominazione degli enzimi
Secondo lšazione chimica si distinguono:
- Enzimi
ossido-riduttivi - ossidasi, idrogenasi, deidrogenasi. Il rilascio di energia
dipende da questi enzimi; coinvolti maggiormente nel metabolismo energetico.
- Enzimi
idrolizzanti - idrolasi; gli enzimi digestivi appartengono a questo gruppo.
- Enzimi
fosforilanti - fosforilasi o fosfatasi; aggiungono o rimuovono gruppi fosfato;
coinvolti maggiormente nel ŗtrasporto energetico˛ ATP<=>ADP.
- Enzimi
che raggiungono o rimuovono carbonio diossido - carbossilasi o decarbossilasi;
coinvolti maggiormente nello scambio di gas respiratori.
- Enzimi
che riordinano gli atomi in una molecola - mutasi o isomerasi.
- Idrasi
- aggiungono acqua a una molecola senza rompere il substrato.
2.2.1.2 Proprietā
e comportamento degli enzimi
(fig. 25-4)
Perché si tratta di proteine, le loro proprietā sono
quelle delle proteine; altre importanti proprietā degli enzimi sono:
- Hanno
azione specifica a determinati tipi di molecole.
- Funzionamento
ottimale a uno specifico pH (aciditā del substrato).
- Una
varietā di agenti fisici e chimici inattiva o inibisce gli enzimi cambiando la
forma della molecola enzimatica (regolazione e disturbo).
- Molti
enzimi catalizzano una reazione chimica in entrambe le direzioni (composizione-decomposizione
di determinati tipi di molecole).
- Gli
enzimi vengono continuamente distrutti nel corpo e continuamente sintetizzati
nelle cellule secondo programmi genetici.
- Diversi
enzimi vengono sintetizzati in forma inattiva di proenzimi attivati poi solo da
processi regolativi.
2.2.2 Digestione
dei carboidrati
- I
carboidrati sono saccaridi composti (polisaccaridi). Gli amidi sono un tipo
frequentemente usato come alimentari p.es. in cereali, leguminose, patate, ...
- I
polisaccaridi vengono idrolizzati da amilasi in disaccaridi (saliva, tratti
digestivi superiori).
- Le
fasi finali della digestione dei carboidrati sono catalizzate da sucrasi,
lattasi, maltasi che sono presenti nella membrana cellulare dei villi degli
enterociti nel lume intestinale.
- Per
essere assorbiti infine i carboidrati devono trovarsi solitamente in forma di
glucosio.
2.2.3 Digestione
delle proteine
(fig. 25-7)
- I
composti proteici constano di catene spiralizzate di aminoacidi.
- Le
proteasi catalizzano lšidrolisi delle proteine in composti intermedi (peptidi)
e infine in aminoacidi.
- Principali
proteasi sono pepsina nel succo gastrico; tripsina nel succo pancreatico;
peptidasi nellšorletto a spazzola dellšintestino.
- Da
ultimo sono assorbibili come uno dei 22 aminoacidi, o come peptidi.
2.2.4 Digestione
dei grassi
(fig. 25-8)
- I
grassi vengono emulsionati dalla bile nellšintestino tenue prima di essere
digeriti.
- Il
principale enzima per la digestione dei grassi č la lipasi pancreatica.
- Sono
assimilabili dallšintestino in forma di glicerina, trigliceridi e acidi grassi
e prendono la strada dei vasi linfatici intestinali per finire ad essere
distribuiti in forma di trigliceridi e acidi grassi nel circuito ematico
(spesso legati a proteine di trasporto).
2.2.5 Residui
della digestione
Alcune sostanze contenute negli alimenti resistono
alla digestione e vengono eliminate come feci (p.es. cellulose). I residui
hanno unšimportanza spesso trascurata in quanto:
- Possono
essere nutriente per la flora intestinale e il loro indispensabile lavoro.
- Diluiscono
e legano e tamponano sostanze tossiche e irritanti degli alimentari.
- Aumentano
il volume di chimo e feci.
- Stimolano
la peristalsi.
Le pių note sono le fibre vegetali, ma tante altre
specie ŗgelatinose˛ creano effetti simili.
2.2.6 Trasformazioni
enzimatiche
I pių importanti processi enzimatici lungo il tratto
digestivo sono:
- Digestione
neutrale in bocca di amidi (carboidrati) cotti.
- Digestione
acida nello stomaco di proteine e grassi emulsionati.
- Digestione
basica (alcalinica) di proteine e peptoni, grassi non emulsionati, amidi e
maltosio nellšintestino tenue.
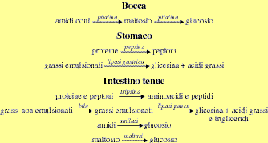
2.2.7 Ruolo
della flora intestinale
La flora intestinale partecipa in modo simbiotico
alla digestione:
- Consuma
sostanze assimilabili e no dallšorganismo per il proprio metabolismo.
- Fornisce
scorie e sostanze sintetizzate dal loro metabolismo assimilabili o no
dallšorganismo.
- Colonie
patogene di flora (e fauna) intestinale creano molteplici malattie intestinali.
Raggiungono lšintestino in concentrazioni patogene con alimenti infetti (crudi)
quando i meccanismi immunitari preliminari (come lšaciditā gastrica e altri)
non riescono pių a tenerli sotto controllo.
- Il
tipo di nutrizione influisce notevolmente sulla composizione della flora
intestinale favorendo il proliferare di microorganismi di diversissimo tipo che
creano un ecosistema specifico.
- La somministrazione di sostanze
tossiche (come antibiotici, citotossici, sostanze difensori di vegetali ) lede
naturalmente la flora intestinale.
3.0 Controllo
della secrezione delle ghiandole del sistema digerente
Sono trattati il controllo di secrezione di saliva,
succhi gastrici, pancreatici, biliari e intestinali. Č evidente che si tratta
di circuiti di regolazione molto complessi che devono funzionare alla
perfezione, in quanto devono essere in grado di regolare la secrezione dei vari
succhi in funzione non solo della quantitā ma anche della composizione
biochimica degli alimenti ingeriti e del loro stato di decomposizione e
assimilazione lungo i ca. dieci metri del tratto digestivo, il che richiede
anche complicati meccanismi di previsione. Temo che la maggior parte di questi
processi sia ignota.
Sono trattati i seguenti argomenti:
- Secrezione
salivare.
- Secrezione
gastrica.
- Secrezione
pancreatica.
- Secrezione
della bile.
- Secreti
dellšintestino.
Il seguente schema tenta di rappresentare i pių
elementari nessi tra ormoni coinvolti, relativi organi e sostanze secrete.
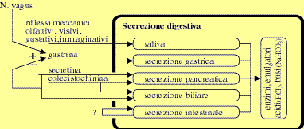
3.1 Secrezione
salivare
La secrezione della saliva č controllata da riflessi
meccanici e da stimoli olfattivi, gustativi e visivi.
- Gli
stimoli meccanici dipendono dalla presenza del cibo nella bocca.
- Stimoli
olfattivi, gustativi e visivi dipendono dallšodore, dal gusto e dalla vista del
cibo.
- Stimoli
ŗimmaginativi˛.
- Lšassenza
di saliva (bocca asciutta) si chiama sete.
3.2 Secrezione
gastrica
Si distingue in tre fasi:
- Fase
cefalica: ŗfase psichica˛ poiché sono fattori mentali quelli che attivano il
meccanismo; gli stimoli efferenti alle ghiandole pervengono lungo le fibre del
nervo vago; stimolano la produzione della gastrina.
- Fase
gastrica: quando i prodotti della digestione proteica raggiungono la parte
pilorica dello stomaco, stimolano il rilascio di gastrina. Questa accelera la
secrezione del succo gastrico apportando nuovo enzima per la digestione del
cibo.
- Fase
intestinale: diversi meccanismi sembra possano aggiustare la secrezione
gastrica quando il chimo passa e attraversa il tenue; riflessi endocrini
coinvolgenti il peptide inibitore gastrico, la secretina e CCK
(colecistochinina) inibiscono le secrezioni gastriche.
3.3 Secrezione
pancreatica
Č stimolata da diversi ormoni rilasciati nella
circolazione dalla mucosa intestinale:
- La
secretina evoca secrezione di succo pancreatico a basso contenuto di enzimi, ma
a elevato contenuto di bicarbonato (neutralizzazione acido cloridrico).
- La
colecistochinina-pancreozimina (CCK) ha diverse funzioni:
- Aumenta
la secrezione esocrina del pancreas.
- Si
oppone alla gastrina inibendo la secrezione gastrica di acido cloridrico.
- Stimola
la contrazione della colecisti e la bile (concentrata) viene scaricata nel
duodeno.
- La
secrezione endocrina di insulina e glucagone č regolata soprattutto tramite la
glicemia (tasso di glucosio nel sangue) ma competono anche fattori di stato
nervoso-ormonale (simpatotonia, vagotonia, epinefrina, ) e disponibilitā di
oligoelementi come cromo, manganese e zinco.
3.4 Secrezione
della bile
La bile č secreta con continuitā dal fegato, ma si
raccoglie e viene concentrato nella colecisti: secretina e CCK
(colecistochinina) stimolano la fuoriuscita della bile dalla colecisti per
contrazione di questšultima.
3.5 Secreti
dellšintestino
Si sa poco sulle modalitā di regolazione della
secrezione intestinale; si suppone che la produzione del succo intestinale sia
stimolata dal rilascio di ormoni propri della mucosa intestinale stessa.
4.0 Assorbimento
Sono trattati i processi e meccanismi di
assorbimento.
4.1 Processo
di assorbimento
Passaggio di sostanze nel sangue e nella linfa
attraverso la mucosa intestinale.
La parte prevalente dellšassorbimento avviene
nellšintestino tenue:
- Per il
metabolismo energetico: carboidrati e zuccheri in forma di glucosio, grassi e
oli maggiormente in forma di glicerina e acidi grassi.
- Per il
metabolismo ŗcostruttivo˛ proteine animali e vegetali in particolare sotto
forma di diversi peptidi e aminoacidi assimilabili dallšorganismo.
La parte riassorbente e assorbente di acqua,
elettroliti e sostanze molecolarmente semplici come elettroliti e oligoelementi
avviene per lo pių nellšintestino crasso se non hanno fatto prima dei legami
con molecole assorbibili nellšintestino tenue.
4.2 Meccanismi
di assorbimento
(fig. 25-11)
Per alcune sostanze come lšacqua, lšassorbimento
avviene per diffusione semplice od osmosi lungo tutto il tratto
gastrointestinale.
Altre sostanze vengono assorbite mediante meccanismi
pių complessi.
- Trasporto
attivo secondario come il sodio.
- Cotrasporto
(trasporto accoppiato) come per sodio - glucosio.
- Acidi
grassi, monogliceridi e colesterolo sono trasportati con lšausilio dei sali
biliari alle cellule assorbenti dei villi intestinali del tenue.
Dopo lšassorbimento le sostanze nutritizie (ad
eccezione dei grassi) vengono trasportate al fegato per mezzo del sistema
portale (vena porta al fegato).
5.0 Eliminazione
- Espulsione
delle feci dal tratto digerente tramite la defecazione; un atto riflesso
dipendente dalla stimolazione dei recettori di tensione della mucosa rettale
quando le feci giungono nel retto (impulso di defecazione) č volontario in
quanto il ŗsecondo sfintere˛ č controllabile.
- Costipazione:
il contenuto colo-rettale si muove pių lentamente per torpiditā dei riflessi
rettali. Le feci si disidratano di pių e divengono pių dure.
- Diarrea:
accelerata motilitā del tenue. Provoca diminuzione dellšassorbimento dšacqua,
di elettroliti ed emissione di feci acquose.
6.0 La
digestione e il corpo nellšinsieme
Sono trattati lšomeostasi nutritiva, i ruoli
secondari del sistema digerente e la collaborazione con altri sistemi.
6.1 Omeostasi
nutritiva
(fig. 25-13)
Il contributo primario del sistema digerente al
mantenimento dellšomeostasi consiste nel fornire una costante concentrazione di
nutrienti nellšambiente interno.
6.2 Ruoli
secondari del sistema digerente
Oltre allšassorbimento dei nutrienti, denti, lingua,
con la compartecipazione del sistema respiratorio sono importanti nella
produzione della voce e del linguaggio.
Lšaciditā gastrica collabora col sistema immunitario
nella distruzione di germi potenzialmente pericolosi.
Lšecosistema della flora intestinale simbiontica
concorre con microorganismi parassitari o patogeni.
6.3 Collaborazione
con altri sistemi
Per svolgere le sue funzioni il sistema digestivo
necessita del concorso dšaltri sistemi:
- La
regolazione della motilitā e della secrezione necessita del concorso dal
sistema nervoso ed endocrino.
- Lšossigeno
per le attivitā digestive č fornito dal sistema respiratorio e circolatorio.
- Protezione
e supporto per il sistema digestivo sono procurati dal sistema scheletrico e
tegumentario.
- La
logistica e la difesa sono compito dei sistemi di trasporto e difesa.
- Per
lšingestione dei cibi, per la masticazione, deglutizione, defecazione, č
necessario il contributo della muscolatura striata.
7.0 Meccanismi
di malattia
Sono trattati disordini del tratto gastrointestinale,
di fegato e pancreas.
7.1 Disordini
del tratto gastrointestinale
Disordini specifici:
- Gastroenterite
- infiammazione dello stomaco e dellšintestino.
- Anoressia
- perdita cronica dellšappetito.
- Nausea -
sensazione spiacevole, spesso associata a vomito.
- Emesi -
vomito (fig. 25-14).
- Diarrea
- eliminazione di feci liquide.
- Costipazione
- diminuzione della motilitā del colon.
Malattie sono:
- Ulcera
peptica - perdita di sostanza di unšarea della mucosa, con tendenza
allšapprofondimento negli strati sottostanti, dovuta allšazione del succo
gastrico acido: due sono i tipi comuni, lšulcera gastrica e quella duodenale.
- Cancro
dello stomaco - legato a eccesso di consumo di alcolici, allšuso di tabacco da
masticare, allšuso frequente di cibi essiccati e conservati; di solito dā
metastasi prima di essere diagnosticato.
- Sindrome
da malassorbimento - termine generico che indica un gruppo di sintomi
dipendenti da incapacitā del tenue di assorbire appropriatamente i nutrienti; i
sintomi comprendono anorressia, senso di gonfiore addominale, crampi, anemia e
astenia.
- Diverticolite
- infiammazione degli eventuali diverticoli presenti nellšintestino -
caratterizzata da costipazione.
- Colite -
condizione infiammatoria dellšintestino crasso; puō essere responsabile di
emorragie e ulcere intestinali.
- Cancro
colo-rettale - neoplasia maligna del colon-retto; segni precoci sono:
modificazioni delle abitudini funzionali dellšintestino, sangue nelle feci,
emorragie rettali, dolore addominale, anemia inspiegabile per altra causa,
perdita di peso, astenia.
7.2 Disordini
del fegato e del pancreas
- Epatite
- termine generico per infiammazione del fegato; caratterizzata da ittero,
epatomegalia, anoressia, disturbi intestinali, feci scolorate, urine scure.
- Cirrosi
- condizione degenerativa del fegato; il danno al tessuto epatico viene
rimpiazzato dal tessuto connettivo o adiposo.
- Pancreatite
- infiammazione del pancreas.
- Cancro del pancreas - solitamente
adenocarcinoma; fatale entro 5 anni dallšinsorgenza.
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
Š 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito puō essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |


