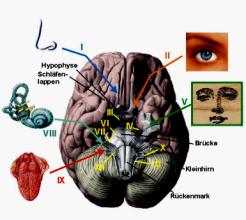|
|
Medicina popolareper autodidatti
agosto 6, 2005 |
|
Indice della pagina 1.0
Introduzione 1.1
Elaborazione di stimoli 2.0
Recettori sensoriali 2.1
Funzioni 2.2
Risposta dei recettori 2.3
Classificazione dei recettori 2.4
Distribuzione dei recettori 3.0
Recettori e sensibilità non specifica 3.1
Sensibilità somatica 3.2
Sensibilità dolorifica 3.3
Sensibilità tattile e di pressione 3.4
Recettori di stiramento 4.0
Organi di senso speciali 4.1
Senso dell'olfatto 4.2
Sensibilità gustativa 4.3
Senso dell'udito e dell'equilibrio: l'orecchio 4.4
L'occhio 5.0
Modificazioni: Organi di senso 5.1
Aquisizione di informazioni sensitive 5.2
Sviluppo 5.3
Età 5.4
Modificazioni 6.0
Alterazioni degli organi del senso 6.1
Alterazioni dell'orecchio 6.2
Alterazioni degli occhi |
AF 3.14 Organi dei sensi
© Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 17
|
INDICE: Organi dei sensi AF 3.14
1.0Introduzione
1.1Elaborazione di
stimoli
2.0Recettori sensoriali
2.1Funzioni
2.2Risposta dei recettori
2.2.1Funzione generale
2.2.2Stimoli e
recettori
2.2.3Potenziale di
recettore
2.2.4Adattamento
2.3Classificazione dei
recettori
2.3.1Meccanorecettori
2.3.2Chemorecettori
2.3.3Termorecettori
2.3.4Nocicettori
(Algocettori)
2.3.5Fotorecettori
2.4Distribuzione dei
recettori
2.4.1Recettori per
sensibilità speciali
2.4.2Organi generali di
senso
3.0Recettori e sensibilità non specifica
3.1Sensibilità somatica
3.1.1Esterocettori
3.1.2Propriocettori
3.1.3Recettori dei
visceri
3.2Sensibilità
dolorifica
3.3Sensibilità tattile
e di pressione
3.3.1Corpuscoli del
Meissner e clave terminali del Krause
3.3.2Corpuscoli del
Ruffini
3.3.3Corpuscoli di
Pacini
3.4Recettori di
stiramento
3.4.1Fusi
neuromuscolari
3.4.2Organi
muscolo-tendinei del Golgi
4.0Organi di senso speciali
4.1Senso
dellʼolfatto
4.1.1Recettori
olfattivi
4.1.2Vie olfattive
4.2Sensibilità
gustativa
4.2.1Calici gustativi
4.2.2Vie della
sensibilità gustativa
4.3Senso
dellʼudito e dellʼequilibrio: lʼorecchio
4.3.1Orecchio esterno
4.3.2Orecchio medio
4.3.2.1 Mucosa
4.3.2.2 Ossicini
dellʼudito
4.3.2.3 Aperture
dellʼorecchio medio
4.3.3Orecchio interno
4.3.3.1 Labirinto osseo
4.3.3.2 Labirinto
membranoso
4.3.3.3 Vestibolo e
canali semicircolari
4.3.3.4Coclea
4.3.3.5 Coclea e dotto
cocleare
4.3.3.5.1 Coclea
4.3.3.5.2 Modiolo
4.3.3.5.3 Dotto cocleare
4.3.3.5.4 Organo del Corti
4.3.3.5.5 Nervo cocleare
4.3.4Senso
dellʼudito
4.3.4.1 Condizioni
fisiche
4.3.4.2 Membrana
basilare e percezione dellʼ²acutezza²
4.3.4.3 Percezione dell
intensità
4.3.4.4 Udito
4.3.4.5 Percorso delle
onde sonore
4.3.4.6 Vie neurali
dellʼudito
4.3.5Vestibolo e canali
semicircolari
4.3.6Senso
dellʼequilibrio
4.3.6.1 Equilibrio
statico
4.3.6.1.1 Ciglia, macule e sacculo
4.3.6.1.2 Matrice gelatinosa e otoliti
4.3.6.1.3 Meccanismo
dellʼequilibrio statico
4.3.6.1.4 Trasmissione di segnali di
equilibrio statico
4.3.6.1.5 Riflessi posturali
4.3.6.2 Equilibrio
dinamico
4.3.6.2.1 Creste ampollari, ampolle,
canali semicircolari
4.3.6.2.2 Cupola
4.3.6.2.3 Meccanismo di percezione di
equilibrio dinamico
4.3.6.2.4 Funzionamento
dellʼequilibrio dinamico
4.4Lʼocchio
4.4.1Struttura
dellʼocchio
4.4.1.1 Sclera
4.4.1.1.1 Tessuto connettivo
4.4.1.1.2 Cornea
4.4.1.1.3 Canale di Schlemm
4.4.1.2 Corioide
4.4.1.2.1 Struttura
4.4.1.2.2 Corpo ciliare
4.4.1.2.3 Apparato sospensore
4.4.1.2.4 Iride
4.4.1.3 Retina
4.4.1.3.1 Fotorecettori
4.4.1.3.2 Bastoncelli
4.4.1.3.3 Coni
4.4.1.4 Cavità
4.4.1.5 Umori
4.4.1.6 Muscoli
4.4.1.7 Strutture
accessorie
4.4.1.8 Apparato
lacrimale
4.4.2La vista
4.4.2.1 Formazione
dellʼimmagine retinica
4.4.2.1.1 Rifrazione della luce
4.4.2.1.2 Accomodazione
4.4.2.1.3 Contrazione della pupilla
(miosi)
4.4.2.1.4 Convergenza dei globi oculari
4.4.2.2 Ruolo dei
fotopigmenti
4.4.2.3 Vie ottiche
5.0Modificazioni nel corso della vita: organi di senso
5.1Aquisizione di
informazioni sensitive
5.2Sviluppo
5.3Età
5.4Modificazioni
6.0Meccanismi di malattia: alterazioni degli organi del senso
6.1Alterazioni
dellʼorecchio
6.1.1Sordità di
conduzione
6.1.2Sordità
neurosensoriale
6.2Alterazioni degli
occhi
6.2.1Difetti di
rifrazione
6.2.2Alterazioni della
retina
6.2.3Alterazioni delle
vie ottiche
1.0Introduzione
- Recettori e sensibilità di estero-
e interocettori.
- Organi specifici: olfatto, gusto,
udito, equlibrio e vista.
Gli stimoli esterni o interni dellʼorganismo sono
rilevati, in certe condizioni, da recettori (sensori): quelli esterni da
esterocettori, quelli interni da interocettori.
Tramite il sistema nervoso periferico sensitivo
vengono preelaborati e condotti al diencefalo che li interpreta, li integra e
smista allʼipofisi (ad uso del sistema endocrino), al sistema nervoso
vegetativo (ad uso della reazione organica viscerale e ghiandolare) e alla
corteccia cerebrale (per la reazione motoria e mimica e per la percezione
cosciente).
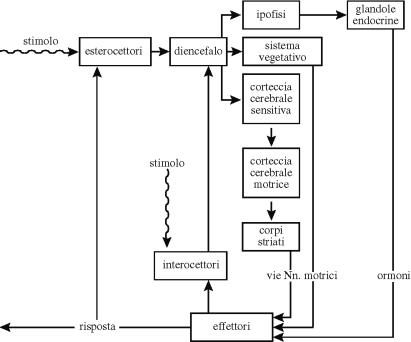
1.1Elaborazione di stimoli
Lo schema seguente mostra i livelli di traduzione, ed
elaborazione di uno stimolo fino al livello di sensazione e memorizzazione.
![]()
2.0Recettori sensoriali
I recettori sensoriali possono trovarsi in organi specifici,
nel derma o in tessuti più profondi dellʼorganismo. Sono in grado di
rilevare stimoli fisici o chimici dallʼesterno o nellʼinterno del
corpo.

2.1Funzioni
I recettori sensoriali consentono al corpo di
rispondere a stimoli dipendenti da modificazioni del nostro ambiente esterno e
interno
2.2Risposta dei recettori
2.2.1 Funzione generale
Rispondono agli stimoli convertendo questi in impulsi
bioelettrici.
2.2.2 Stimoli e recettori
Differenti tipi di recettori rispondono a stimoli
differenti.
2.2.3 Potenziale di recettore
-Il potenziale che si sviluppa quando
su un recettore agisce uno stimolo adeguato: è una risposta graduata (frequenza
di impulsi nervosi).
-Quando è raggiunta la soglia scatta
un potenziale dʼazione nellʼassone del neurone sensitivo (condizione
per provocare un unico impulso nervoso).
-Gli impulsi viaggiano sulle vie
sensitive del nevrasse e, quindi, vengono interpretati come una particolare
sensazione o danno inizio a unʼazione riflessa (la maggior parte
³inconscia², automatica, condizionata).
-Proiezione sensitiva - funzione del
cervello è anche quella di localizzare il punto del corpo in cui ha avuto
inizio il potenziale di recettore (una minima parte che potenzialmente è
percepibile coscientemente).
2.2.4 Adattamento
Caratteristica funzionale dei recettori; il potenziale di
recettore decresce in un certo periodo di tempo in risposta a uno stimolo
continuo e ciò porta a un decremento della velocità di conduzione
dellʼimpulso e a un decremento dellʼintensità di risposta o della
sensazione (in caso di percezione cosciente).
2.3Classificazione dei recettori
Ve ne sono cinque categorie basate sul tipo di stimoli
che li attivano.
2.3.1 Meccanorecettori
Attivati da stimoli meccanici che cambiano la posizione del
recettore e provocano la generazione di un potenziale di recettore (p.es.
propriocettori muscolari striati e lisci e di tessuti connettivali).
2.3.2 Chemiorecettori
Attivati da modificazioni quantitative o qualitative della
concentrazione di determinate sostanze chimiche (p.es. gusto e odorato ma anche
di acidità, ossidoriduzione, ).
2.3.3 Termorecettori
Attivati da modificazioni della temperatura. Specifici per
³caldo² (sopra temperatura corporea) e ³freddo² (sotto temperatura corporea).
Una buona parte di questi si trova nel derma, altri si trovano in organi vasali
e cerebrali.
2.3.4 Nocicettori (Algocettori)
Attivati da stimoli intensi che determinano un danno ai tessuti;
la sensazione è causa di dolore. La maggior parte si trova nei tessuti
connettivi lassi e fibrosi di quasi tutti gli organi.
2.3.5 Fotorecettori
Sono presenti solo nellʼocchio; rispondono a stimoli
luminosi se lʼintensità è grande abbastanza per generare un potenziale di
recettore.
2.4Distribuzione dei recettori
2.4.1 Recettori per sensibilità
speciali
Olfatto, gusto, vista, udito, equilibrio sono raggruppati in
aree localizzate o in organi complessi.
2.4.2 Organi generali di senso
Per la sensibilità somatica ci sono recettori microscopici
ampiamente distribuiti nel corpo e situati nella pelle, nelle mucose, nel
tessuto muscolare, nel connettivo, nei tendini, nelle articolazioni e nelle
viscere. La metà di loro circa è del tipo algo- (noci-) cettore.
3.0Recettori e sensibilità non
specifica
3.1Sensibilità somatica
La sensibilità somatica rileva sensazioni come dolore,
temperatura, tatto, pressione, posizione del corpo, tensione dei muscoli, fame,
sete, ecc.; tre tipi di recettori della sensibilità somatica sono:
3.1.1 Esterocettori
Recettori della sensibilità somatica localizzati alla
superficie del corpo (derma) p.es. recettori termici:
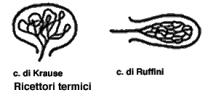
3.1.2 Propriocettori
Recettori della sensibilità somatica localizzati nei muscoli e nelle articolazioni.
Un gruppo individua la ³linghezza², lʼaltro la ³forza²
attuale da e sul muscolo striato.
3.1.3 Recettori dei visceri
Recettori della sensibilità somatica localizzati nei
visceri. Come i propriocettori individuano le caratteristiche movimentali
attuali di apparato digerente, cardiovascolare, escretivo, procreativo, .
3.2Sensibilità dolorifica
Recettori del dolore (o nocicettori o algocettori).
-Sono esterocettori e recettori
viscerali ampiamente distribuiti.
-Sono terminazioni nervose libere che
rispondono a differenti tipi di stimoli, se molto intensi; vi sono due tipi di
fibre nervose che conducono sensibilità dolorifica al cervello.
-Fibre per il dolore acuto (A) -
mediano il dolore puntorio acuto localizzato.
-Fibre per il dolore cronico (C) -
mediano il dolore profondo, urente, diffuso.
Solo a soglie relativamente alte passano nelle aree
coscienti e provocano sensazioni non solo di dolori ma anche di prurito,
solletico, parestesia,
3.3Sensibilità tattile e di
pressione
Esterocettori che rispondono a stimoli che ne cambiano
la forma e la sede tra recettore e ambiente. (fig. 14-1)
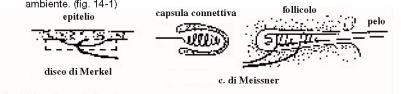
3.3.1 Corpuscoli del Meissner e
clave terminali del Krause
Coinvolti nelle sensazioni tattili, di vibrazione a bassa
frequenza, nella discriminazione tra due punti; presenti in aree prive di peli.
3.3.2 Corpuscoli del Ruffini
sensibilità di pressione profonda e tattile continua; hanno
sede nel derma della pelle e sono numerosi nelle dita.
3.3.3 Corpuscoli di Pacini
Risposta rapida alle sensazioni di pressione profonda, alle
vibrazioni di alta frequenza, allo stiramento; situati profondamente nel derma
di mani e piedi e nelle capsule articolari.
3.4Recettori di stiramento
Propriocettori. I due più importanti recettori di
stiramento sono associati a muscoli e tendini; sono propriocettori.
3.4.1 Fusi neuromuscolari
Forniscono informazioni relative alla lunghezza dei muscoli;
stimolati quando un muscolo rilasciato viene disteso oltre un certo limite;
causano il riflesso da stiramento (miotattico) che fa contrarre il muscolo.
3.4.2 Organi muscolo-tendine del
Golgi
Danno informazioni sulla tensione del muscolo durante la
contrazione; vengono stimolati da contrazioni eccessive; situati nei punti di
attacco dei tendini allʼosso, la loro stimolazione causa rilasciamento del
muscolo.
4.0Organi di senso speciali
Caratterizzati da recettori raggruppati insieme o
raggruppati in organi specializzati; senso dellʼolfatto, del gusto,
dellʼudito e dellʼequilibrio, senso della vista.
4.1Senso dellʼolfatto
I recettori dellʼolfatto distinguono la forma molecolare
di sostanze secondo il criterio chiave-serratura.
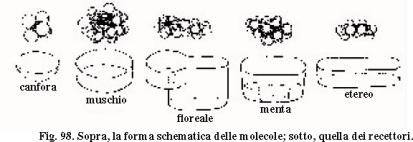
Si noti che poco importa la composizione chimica, ma
quasi esclusivamente la forma geometrica della molecola. Questo è sfruttato
ampiamente nellʼindustria alimentare e cosmetica per produrre profumi e
gusti truccati (come un gioiello in ottone e vetro invece di oro e zaffiro) con
ignoti effetti sul metabolismo (chimico).
4.1.1 Recettori olfattivi
Gli organi del senso dellʼolfatto sono costituiti da
neuroni olfattivi specializzati e da cellule epiteliali di sostegno. (fig.
14-2)
-Ciglia delle cellule olfattive -
situate sulla superficie distale dei neuroni olfattivi, sporgono alla
superficie libera delle fosse nasali.
-Neuroni olfattivi - chemiorecettori
- molecole di gas o di sostanze chimiche disciolte nel muco che ricopre la
mucosa nasale; stimolano i recettori olfattivi.
-Neuroni olfattivi - hanno sede nella
parte superiore delle fosse nasali.
-Neuroni olfattivi - estremamente
sensibili, ad adattamento abbastanza rapido (dopo un poʼ non si sente più
lʼodore del proprio ³deodorante² ma fortemente quello dellʼuomo che
passa).
4.1.2 Vie olfattive
Quando gli stimoli olfattivi superano il livello di soglia
accade che:
-Si generano il potenziale di
recettore e poi il potenziale dʼazione che, seguendo i nervi olfattivi,
raggiunge il bulbo olfattivo.
-Gli impulsi passano poi lungo i
tratti olfattivi fino ai centri olfattivi del cervello e al talamo per lʼinterpretazione,
lʼintegrazione e la memorizzazione.
-La maggior parte di informazioni
olfattive non raggiunge mai le parti corticali coscienti, ma viene elaborato e
usato nelle grandi masse ³inconscie² cervicali, influenzando fortemente
emozioni, stati dʼanimo e umori.
4.2Sensibilità gustativa
Rilevata da calici gustativi sulla superficie della
lingua, raggruppati in modo che diversi tipi di gusto vengano riconosciuti in
determinate zone della lingua.
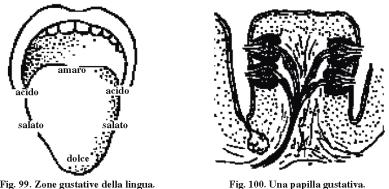
4.2.1 Calici gustativi
Organi di senso che rispondono alle sensazioni gustative;
presenti nelle papille linguali.
-Chemiorecettori stimolati da
sostanze sapide disciolte nella saliva.
-Nei calici gustativi vi sono cellule
sensitive tra cellule di supporto; sono dotate di ciglia gustative che si
estendono fino al poro gustativo.
-Il senso del gusto dipende
anchʼesso dalla produzione di un potenziale di recettore dovuto alle
sostanze disciolte nella saliva.
-I calici gustativi sono
strutturalmente simili tra loro; ciascuno risponde più efficacemente a una
delle sensazioni gustative primarie: amaro, dolce, acido, salato. (fig. 14-3)
-Le fisiologie orientali distinguono
una quinta qualità gustativa ³aspro-astringente². Personalmente la percepisco
tanto mangiando ricotta magra, dolci o ulive.
-Le sensazioni gustative primarie
alle quali rispondono i calici gustativi sono in rapporto alla loro sede sulla
lingua.
-La punta della lingua risponde al
dolce e al salato.
-I lati della lingua rispondono al
sapore acido.
-Il dorso della lingua risponde
allʼamaro.
-Lʼadattamento e la soglia di
eccitabilità sono differenti per ciascuna delle sensazioni primarie.
-Una qualità gustativa è raramente
³unidimensionale² ma di solito ³pentadimensionale² con caratteristica composizione
per un alimento.
-In più le caratteristiche
olfatto-gustative si integrano di solito in un complesso amalgama culinario
anche con i sensi di calore, consistenza, P.es.: mela e cipolla a occhi
bendati e naso chiuso sono gustativamente quasi indistinguibili.
4.2.2 Vie della sensibilità
gustativa
La sensazione gustativa generata nei recettori viene
trasmessa al cevello.
-Gli impulsi gustativi dei 2/3
anteriori della lingua viaggiano nel nervo facciale; quelli di 1/3 posteriore
viaggiano nel glossofaringeo; il vago ha minore importanza per la funzione
gustativa. Secondo ultime ricerche, pare che un rano del N. vagus (X paio
cranico) porta un numero notevole di fibre sensitive olfattive le cui
sensazioni non raggiungono mai un livello cosciente e fanno parte di archi di
riflesso.
-Gli impulsi nervosi raggiungono il
bulbo (il nucleo del tratto solitario), poi il talamo e lʼarea gustativa
della corteccia cerebrale nel lobo parietale.
Pare che solo delle porzioni rudimentali gustative
raggiungano il cosciente, mentre delle parti differenziate e integrate determinino
complessissime funzioni di scelta alimentare secondo i fabbisogni attuali. Ogni
donna gravida p.es. ha da raccontare di relative esperienze. Solo gli apostoli
dellʼalimentazione sana, obiettando, ci fanno notare che unʼaltra
volta lʼinventore ha sbagliato tutto.
4.3Senso dellʼudito e
dellʼequilibrio: lʼorecchio
Sono trattati insieme perché i relativi apparati
sensoriali si trovano allʼinterno dellʼorecchio.
4.3.1 Orecchio esterno
(fig. 14-4)
-Auricola o pinna - parte visibile
dellʼorecchio.
-Meato uditivo esterno - condotto che
porta nellʼosso temporale e termina con la membrana timpanica.
4.3.2 Orecchio medio
(fig. 14-4)
4.3.2.1Mucosa
Una mucosa rivestita da epitelio semplice ricopre le
pareti della cavità.
4.3.2.2Ossicini dellʼudito
Lʼorecchio medio contiene tre ossicini
dellʼudito.
-Martello - incluso col manico nella
membrana timpanica.
-Incudine - articolata col martello e
con la staffa.
-Staffa - articolata con
lʼincudine, comunica con la finestra ovale.
4.3.2.3Aperture dellʼorecchio medio
Aperture della cavità dellʼorecchio medio.
-Apertura del condotto uditivo
esterno, chiusa dalla membrana timpanica.
-Finestra ovale - apertura di
comunicazione con la scala vestibolare dellʼorecchio interno; vi si
articola la base (o platina) della staffa.
-Finestra rotonda - apertura di
comunicazione con la scala timpanica dellʼorecchio interno; chiusa dalla
membrana timpanica secondaria.
-Apertura della tuba di Eustachio -
fa comunicare il timpano con la rinofaringe.
4.3.3 Orecchio interno
(fig. 14-5, A)
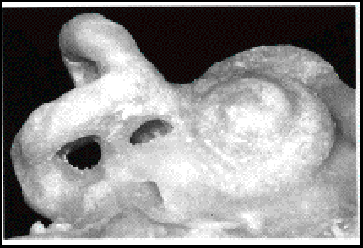
4.3.3.1Labirinto osseo
Vestibolo, coclea e canali semicircolari.
4.3.3.2Labirinto membranoso
-Utricolo e sacculo contenuti nel
vestibolo osseo;
-Dotto cocleare membranoso
allʼinterno del dotto osseo;
-Canali semicircolari membranosi
allʼinterno di quelli ossei.
4.3.3.3Vestibolo e canali semicircolari
Coinvolti nella funzione dellʼequilibrio.
4.3.3.4Coclea
Contiene i recettori dellʼudito e la linfa.
-Endolinfa - liquido chiaro e ricco
di potassio che riempie il labirinto membranoso.
-Perilinfa - liquido simile al
liquido cerebrospinale; circonda il labirinto membranoso riempiendo lo spazio
tra questo e i canali ossei che lo contengono.
4.3.3.5Coclea e dotto cocleare
(fig. 14-5, B)
4.3.3.5.1Coclea
Struttura ossea a forma di guscio di lumacha allʼinterno
delle ossa craniali del labirinto osseo.
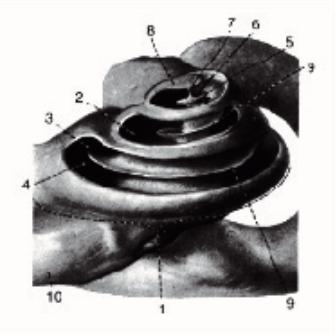
1)Cochlea
2)Canalis spiralis
3)Scala vestibuli
4)Scala timpani
5)Hamulus laminae spiralis
6)Helicotrema
7)Modiolo
8)Cupola cochlea
9)Lamina spir.ossea
10)Can. semicirc.post.
4.3.3.5.2Modiolo
Parte centrale ossea di forma conica; contiene il ganglio
spirale costituito da neuroni bipolari che sono il protoneurone del
collegamento uditivo.
4.3.3.5.3Dotto cocleare
- Trovasi allʼinterno della coclea; contiene la parte
dellʼorecchio interno
che ha funzioni uditive; contiene endolinfa.
- Ha forma triangolare sulla sezione
trasversale.
- Divide la coclea nella scala
vestibolare (parte superiore) e nella scala timpanica (sezione inferiore); entrambe le sezioni
conten- gono perilinfa.
- La membrana vestibolare è la volta
del dotto cocleare.
- La membrana basilare è il pavimento
del dotto cocleare.
4.3.3.5.4Organo del Corti
Situato sulla membrana basilare, contiene cellule ciliate e
cellule di sostegno.
4.3.3.5.5Nervo cocleare
I neuroni del ganglio spirale contraggono rapporto con le
cellule ciliate dellʼorgano del Corti e il loro assone forma il nervo
cocleare che si porta ai nuclei cocleari del ponte.
4.3.4 Senso dellʼudito
4.3.4.1Condizioni fisiche
-I suoni sono il prodotto di
vibrazioni aeree.
-La capacità di udire le onde sonore
dipende dal volume, dallʼaltezza e da altre caratteristiche acustiche.
-Le onde sonore devono possedere
sufficiente ampiezza per far vibrare la membrana timpanica.
-Hanno una frequenza capace di
stimolare le cellule acustiche dellʼorgano del Corti.
4.3.4.2Membrana basilare e percezione
dellʼ²acutezza²
-La membrana basilare ha larghezza e
spessore differenti tra la base e lʼapice della coclea;
-Le onde sonore di alta frequenza
fanno vibrare la porzione più stretta e più sottile che si trova nelle
adiacenze della finestra ovale, mentre le altre frequenze fanno vibrare,
nellʼordine, zone della membrana basilare sempre più vicine allʼapice
della coclea, che è la zona influenzata dalle onde di bassa frequenza;
-Questo fatto consente alle
differenti cellule acustiche di essere stimolate e, a differenti picchi di
suono, di essere percepiti.
4.3.4.3Percezione dellʼintensità
La percezione dellʼintensità dipende
dallʼampiezza del movimento della membrana basilare; più grande è lo
spostamento, maggiore è lʼintensità di suono percepita.
4.3.4.4Udito
È il risultato della stimolazione dellʼarea
uditiva della corteccia cerebrale.
4.3.4.5Percorso delle onde sonore
(fig. 14-6)
-Condotto uditivo esterno.
-Percussione della membrana timpanica
che entra in vibrazione.
-Le vibrazioni della membrana
timpanica determinano i movimenti della catena degli ossicini dellʼudito.
-La staffa si muove a livello della
finestra ovale trasmettendo le vibrazioni sonore ai liquidi endoauricolari.
-La perilinfa della scala del
vestibolo della coclea viene sollecitata in piccole onde che trasmette,
attraverso la membrana basilare, coinvolgendo lʼorgano del Corti.
-Dalla membrana basilare lʼonda
è trasmessa alla perilinfa della scala timpanica fino alla finestra rotonda,
ove lʼonda si smorza contro la membrana timpanica secondaria.
4.3.4.6Vie neurali dellʼudito
-Il movimento delle ciglia delle
cellule acustiche contro la membrana tectoria stimola i dendriti delle cellule
del ganglio spirale, che fanno sinapsi sulla base delle cellule acustiche
stesse; qui ha inizio lʼimpulso che il nervo cocleare conduce ai nuclei
cocleari del ponte.
-Attraverso diverse stazioni di
collegamento (relais) nei nuclei del ponte, del mesencefalo e del talamo, gli
impulsi raggiungono lʼarea uditiva della corteccia cerebrale nel lobo
temporale.
4.3.5 Vestibolo e canali
semicircolari
(fig. 14-5, A)
-Vestibolo - settore centrale del
labirinto osseo; lʼutricolo e il sacculo sono le strutture membranose
contenute al suo interno.
-Canali semicircolari - tre in ogni
osso temporale; ciascuno circa ad angolo retto rispetto agli altri; entro ogni
canale semicircolare osseo cʼè il canale membranoso che contiene endolinfa
ed è collegato allʼutricolo; allʼestremità anteriore, ciascun canale
si allarga ad ampolla.
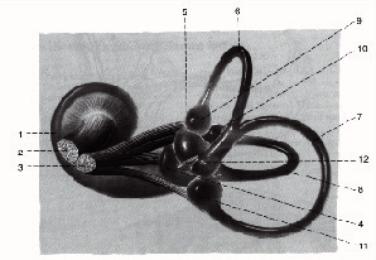
|
1)Cochlea |
5)Utricolo |
9)Ampulla
membr.ant. |
|
2)N.cochleare |
6)Dotto
semicirc.ant. |
10)Ampulla
membr.lat. |
|
3)N.vestibolare |
7)Dotto
semicirc.lat. |
11)Ampulla
membr.post. |
|
4)Sacculo |
8)Dotto
semicirc.post. |
12)Dotto
endolinfatico |
4.3.6 Senso dellʼequilibrio
Equilibrio statico e dinamico.
4.3.6.1Equilibrio statico
Capacità di avvertire la posizione della testa
rispetto alla forza di gravità o allʼaccelerazione lineare:
4.3.6.1.1Ciglia, macule e sacculo
Il movimento delle ciglia, delle macule dellʼutricolo e
del sacculo, vicendevolmente situati ad angolo retto, è il fattore necessario
per ottenere le predette informazioni sensitive
4.3.6.1.2Matrice gelatinosa e otoliti
Nella matrice gelatinosa che ricopre le macule si trovano gli
otoliti.
4.3.6.1.3Meccanismo dellʼequilibrio statico
Col cambiamento di posizione della testa si modifica la
direzione in cui agisce la pressione degli otoliti sulle macule e quindi sulle
cellule sensoriali di queste strutture che, a loro volta, stimolano il nervo
vestibolare.
4.3.6.1.4Trasmissione di segnali di equilibrio statico
Il nervo vestibolare conduce gli impulsi ai nuclei
vestibolari del bulbo e al cervelletto; dalle stazioni di relais gli stimoli
raggiungono la corteccia cerebrale producendo la sensazione della posizione
della testa e del corpo e anche la sensazione della direzione in cui il corpo è
sollecitato dalla forza di gravità.
4.3.6.1.5Riflessi posturali
Gli impulsi dei nuclei vestibolari sui neuroni del midollo
spinale consentono di restaurare la posizione del corpo e delle sue parti,
riportandole nella posizione dalla quale sono state spostate; oltre agli stimoli
dalle macule, concorrono gli impulsi dei propricettori muscolari motori e
quelli visivi.
4.3.6.2Equilibrio dinamico
Necessario per mantenere lʼequilibrio quando il
corpo è soggetto allʼaccelerazione angolare (p.es. ruota su se stesso) -
(fig. 14-8):
4.3.6.2.1Creste ampollari, ampolle, canali
semicircolari
Dipende dal funzionamento delle creste ampollari situate
nelle ampolle di ogni canale semicircolare.
4.3.6.2.2Cupola
Cappa gelatinosa in cui sono incluse le ciglia delle cellule
sensoriali delle creste ampollari; sono recettori che non rispondono alla
gravità, ma sono sensibili al flusso dellʼendolinfa allʼinterno del
canale semicircolare membranoso.
4.3.6.2.3Meccanismo di percezione di equilibrio
dinamico
La reciproca posizione ad angolo retto dei canali
semicircolari consente di rilevare movimenti angolari in ogni direzione.
4.3.6.2.4Funzionamento dellʼequilibrio dinamico
Quando si muove la cupola si flettono le ciglia delle cellule
sensoriali producendo un potenziale di recettore seguito da un potenziale
dʼazione; il potenziale dʼazione percorre il nervo vestibolare per
raggiungere i nuclei vestibolari del bulbo, dai quali lʼimpulso viene
smistato alla corteccia cerebrale per lʼintegrazione e
lʼinterpretazione, al cervelletto e al midollo spinale per la risposta
posturale.
4.4Lʼocchio
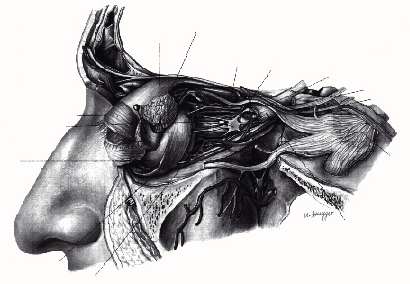
|
1)Ghiandole
lacrimali |
6)Ganglion
ciliare |
11)N.trochlearis
(IV) |
|
2)Bulbo
oculare |
7)M.rectus
sup. |
12)N.trigeminus
(V) |
|
3)M.obliquo
inf. |
8)A.
oftalmica |
13)M.rectus
lat. |
|
4)N.ottico
(II) |
9)V.oftalmica
sup. |
14)M.levator
palp.sup. |
|
5)M.orbicularis |
10)N.oculomotoris
(III) |
|
4.4.1 Struttura dellʼocchio
(Fig. 14-9)
4.4.1.1Sclera
o strato esterno:
4.4.1.1.1Tessuto connettivo
Fibroso denso; di colore biancastro.
4.4.1.1.2Cornea
parte anteriore della sclera, trasparente, che ricopre
lʼiride; nella cornea e nella lente mancano i vasi sanguigni.
4.4.1.1.3Canale di Schlemm
Seno venoso anulare incluso nella parte anteriore della
sclera ai limiti con la cornea.
4.4.1.2Corioide
O strato medio.
4.4.1.2.1Struttura
- Corioide propriamente detta -
costituita da molti vasi sanguigni,
contiene grandi quantità di melanina.
- Nella parte anteriore la corioide
si differenzia in tre strutture differenti.
(fig. 14-10)
4.4.1.2.2Corpo ciliare
Parte ispessita della corioide che forma un rilievo anulare
attorno alla lente; contiene il muscolo ciliare; dà attacco a filamenti
dellʼapparato sospensore della lente.
4.4.1.2.3Apparato sospensore
(Zonula ciliare dello Zinn); insieme dei filamenti che
collegano la capsula della lente al corpo ciliare e ai processi ciliari;
processi ciliari, rilievi della corioide disposti secondo i meridiani del globo
oculare: contengono i vasi sanguigni che secernono lʼumor acqueo.
4.4.1.2.4Iride
Parte colorata dellʼocchio visibile attraverso la
cornea; consta di una parte della corioide disposta come un diaframma dietro la
cornea e anteriormente alla lente; contiene fibre muscolari lisce radiali e circolari la cui funzione è
quella di modificare il diametro della pupilla, il forame che si trova verso il
suo centro e che serve per lʼingresso delle radiazioni luminose nella
cavità del globo oculare.
4.4.1.3Retina
O strato interno del globo oculare: Comprende due
parti: la parte nervosa e la parte cieca; la parte nervosa trovasi
posteriormente al corpo e ai processi ciliari; la parte cieca - così detta perché
priva di neuroni - ricopre dallʼinterno il corpo ciliare, i processi
ciliari e lʼiride. La parte nervosa è formata da tre strati di neuroni
allʼesterno dei quali trovasi lo strato dellʼepitelio pigmentato
della retina (fig. 14-11):
4.4.1.3.1Fotorecettori
Recettori visivi altamente specializzati - situati
profondamente allo strato dellʼepitelio pigmentato, rappresentano lo
strato neuronale più esterno della retina.
4.4.1.3.2Bastoncelli
Mancano nella fovea e nella macula lutea; aumentano
numericamente verso la periferia della parte nervosa della retina.
4.4.1.3.3Coni
Meno numerosi dei bastoncelli, sono concentrati nella fovea
centrale e nella macula lutea:
- Neuroni bipolari.
- Neuroni gangliari.
- Tutti gli assoni di questi neuroni
si portano al disco ottico ed
escono dal globo oculare attraversando la corioide e la parte cribrosa della sclera formando
poi il nervo ottico;
- Allʼinterno del globo oculare,
tutte le fibre nervose sono
amieliniche per garantire la trasparenza degli strati retinici e la possibilità di formazione delle
immagini sulle parti esterne dei
coni e dei bastoncelli: le fibre del nervo ottico acquisiscono la loro guaina mielinica (formata da
cellule di oligodendroglia!) in
corrispondenza del disco ottico, che è zona cieca della retina perché priva di neuroni.
- Nella parte cieca anteriore della
retina lo strato è formato solo
dallʼepitelio pigmentato della retina.
4.4.1.4Cavità
Cavità: lʼinterno del globo oculare è diviso in
due cavità dalla presenza della lente (o cristallino) e del suo legamento
sospensore:
-La cavità anteriore trovasi
anteriormente alla lente e comprende, a sua volta, due spazi.
-Camera anteriore - spazio
tra la cornea e lʼiride.
-Camera posteriore -
spazio tra la parte posteriore dellʼiride e la superficie anteriore della
lente.
-Cavità posteriore - tutto
lo spazio situato posteriormente alla lente e al legamento sospensore.
4.4.1.5Umori
-Umor acqueo - riempie la camera anteriore
e la
posteriore; liquido chiaro e trasparente formato dai vasi dei processi ciliari
e drenato dal canale di Schlemm e dalle vene oftalmiche (fig. 14-13).
-Umor vitreo - riempie la cavità posteriore; materiale della
consistenza dʼuna gelatina molle; concorre a mantenere la forma del globo
oculare e la pressione endoculare unitamente allʼumor acqueo.
4.4.1.6Muscoli
Nel globo oculare vi sono due tipi di tessuto
muscolare.
-Muscoli extraoculari (fig. 14-14) -
sono muscoli scheletrici che sʼinseriscono esternamente al globo oculare e
alle ossa dellʼorbita; il nome dipende dalla posizione rispetto
allʼocchio; i muscoli sono: i retti superiore, inferiore, mediale e
laterale e gli obliqui superiore e inferiore.
-Muscoli intrinseci - muscolatura
liscia situata allʼinterno dellʼocchio: nellʼiride regola il
diametro pupillare; nel corpo ciliare regola la forma della lente.
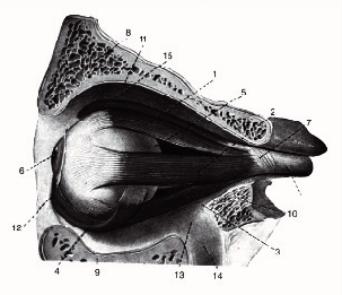
|
1)M.retto
sup. |
6)Cornea |
11)Periostio |
|
2)M.retto
lat. |
7)Anulus
tendin.com. |
12)Margine
infraorbitale |
|
3)M.retto
inf. |
8)Os
frontale |
13)Fissura
orbit.inf. |
|
4)M.obliquo
inf. |
9)Mascella |
14)Fossa
infratemporalis |
|
5)Bulbo
oculare |
10)Os
sfenoidale |
15)M.levator
palp.sup. |
4.4.1.7Strutture accessorie
(fig. 14-15)
-Sopracciglia e ciglia - danno
protezione contro eventuali materiali estranei che possono entrare
nellʼocchio; importanti dal punto di vista della cosmesi.
-Palpebre: pieghe cutanee - mucose
contenenti muscolatura striata e la lamina del tarso.
-La mucosa che riveste la loro
superficie interna è la congiuntiva che si continua poi sulla sclera
delimitando il sacco congiuntivale.
-Rima palpebrale è lo spazio tra i
margini palpebrali; accanto agli angoli dove si congiungono, medialmente e
lateralmente, le due palpebre.
4.4.1.8Apparato lacrimale
Strutture per la secrezione e il drenaggio delle
lacrime, il liquido che bagna la cornea
(fig. 14-17)
-Ghiandole lacrimali - dimensione e
forma dʼuna piccola mandorla; situate contro la volta delle orbite
supero-lateralmente; ciascuna formata da circa una dozzina di lobuletti che
scaricano il secreto nel sacco congiuntivale.
-Canali lacrimali - piccoli canalini
che drenano le lacrime nel sacco lacrimale.
-Sacco lacrimale - collocato in una
doccia dellʼosso lacrimale.
-Dotto nasolacrimale - piccolo canale
che si estende dal sacco lacrimale fino nel meato nasale inferiore.
4.4.2 La vista
Formazione dellʼimmagine, fotopigmenti, vie ottiche.
4.4.2.1Formazione dellʼimmagine retinica
4.4.2.1.1Rifrazione della luce
Deflessione della luce che si produce quando i raggi luminosi
passano obliquamente da uno dei mezzi diottrici in un altro di differente
densità ottica (fig. 14-18): cornea, umor acqueo, lente, umor vitreo sono i
mezzi diottrici del globo oculare.
4.4.2.1.2Accomodazione
Messa a fuoco sulla fovea delle immagini di oggetti vicini
per aumento della curvatura delle facce della lente e aumento del suo potere di
rifrazione (fig. 14-19).
4.4.2.1.3Contrazione della pupilla (miosi)
La muscolatura dellʼiride è importante per la formazione
di unʼimmagine nitida sulla retina; la miosi della pupilla previene la
divergenza della luce che, proveniente da un oggetto, penetra nel globo oculare
dalla periferia della cornea e della lente; il riflesso della miosi si
manifesta anche quando cʼè accomodazione della lente; riflesso pupillare
alla luce - miosi dovuta a illuminazione diretta dellʼocchio.
4.4.2.1.4Convergenza dei globi oculari
Movimento degli occhi per portarne gli assi visivi contemporaneamente
su di un oggetto vicino; più vicino è lʼoggetto, maggiore è il grado della
convergenza necessario per vedere, con i due occhi, unʼimmagine sola; per
mantenere la convergenza è necessario un buon equilibrio funzionale dei muscoli
estrinseci tra loro antagonisti.
4.4.2.2Ruolo dei fotopigmenti
I pigmenti sensibili alla luce subiscono, per azione
di essa, modificazioni strutturali che hanno per risultato la generazione di
impulsi nervosi che il cervello interpreta poi come luce.
-Bastoncelli - il loro fotopigmento è
la rodopsina; altamente sensibile alla luce; si degrada in opsina e retinale;
la separazione di queste due sostanze in presenza della luce fa scattare un
potenziale dʼazione nei bastoncelli; per ricostituire la rodopsina i
recettori consumano energia.
-Coni - vi sono tre tipi di coni,
ciascuno con un fotopigmento diverso che è meno sensibile della rodopsina;
perciò, per la loro degradazione è necessaria luce intensa.
-Uno dei pigmenti assorbe le
radiazioni nellʼambito del colore rosso dello spettro.
-Un secondo pigmento assorbe le
radiazioni nellʼambito del colore verde dello spettro.
-Un terzo pigmento assorbe le
radiazioni nellʼambito del colore blu dello spettro.
4.4.2.3Vie ottiche
(fig. 14-21)
-Catena di elementi neuronali che
conduce impulsi dai recettori alla corteccia visiva nei lobi occipitali del
cervello: nervi ottici, chiasma ottico, tratti ottici, radiazioni ottiche.
-Il nervo ottico contiene fibre
appartenenti a una sola retina, ma il chiasma contiene fibre della porzione
nasale di entrambe le retine; questi fatti anatomici spiegano le peculiari
anomalie della visione per lesioni eventuali delle vie ottiche.
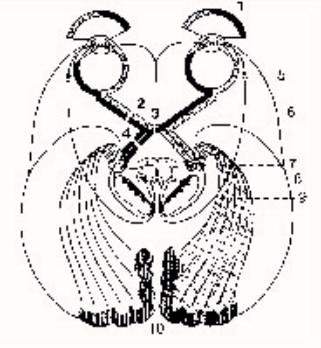
|
1)
Campo visivo |
4)Tratto
ottico |
7)Corp.genicul.lat. |
|
2)
N.ottico |
5)Ganglion
ciliare |
8)Nucleus
N.oculomot. |
|
3)
Chiasma ottico |
6)N.oculomotorio |
9)Substanzia
nigra |
|
10)
Lobo occipitale |
|
|
5.0Modificazioni nel corso della
vita: organi di senso
5.1Acquisizione di informazioni sensitive
-Le informazioni sensitive si acquisiscono
per stimolazioni di terminazioni nervose sensitive.
-Lʼetà, le malattie, le anomalie
strutturali o la mancata maturazione compromettono la capacità di identificare
i segnali e di rispondere.
5.2Sviluppo
La struttura e la funzione sono capacità dipendenti
dai fattori di sviluppo associati con lʼetà.
5.3Età
I sensi divengono più affinati con lʼetà.
5.4Modificazioni
-Età adulta avanzata - perdita
dellʼacutezza sensoriale.
-Si verificano modificazioni
strutturali nei recettori e nelle altre strutture degli organi di senso.
6.0Meccanismi di malattia:
alterazioni degli organi di senso
6.1Alterazioni dellʼorecchio
Due fondamentali categorie: sordità di conduzione,
sordità neurosensoriale.
6.1.1 Sordità di conduzione
Le onde sonore vengono bloccate quando passano attraverso le
vie che devono farle giungere allʼorecchio interno. Cause della sordità di
conduzione:
-Blocco del condotto uditivo esterno
per tappo di cerume, oggetti estranei, tumori e altro materiale.
-Otosclerosi - malattia su base
ereditaria dovuta a irregolarità strutturali della staffa e a sordità di
conduzione; primi segni: tinnito.
-Otite - infezioni dellʼorecchio
che causano sordità di conduzione temporanea.
-Lʼorecchio medio è esposto a
otiti medie batteriche o virali, causa di edema della mucosa e di pus.
6.1.2 Sordità neurosensoriale
Comune nella senilità:
-Presbiacusia - progressiva perdita
dellʼudito per degenerazione dei tessuti nervosi dellʼorecchio e del
nervo vestibolococleare.
-Esposizione cronica a suoni intensi
con danni allʼorgano del Corti; portano a compromissione dellʼudito
per i suoni di alta frequenza.
-Malattia di Menière - malattia
cronica dellʼorecchio interno; causa ignota; caratterizzata da tinnito,
sordità neurosensoriale progressiva e vertigini.
6.2Alterazioni degli occhi
Vista normale - dipende da tre processi: rifrazione,
stimolazione dei coni e bastoncelli, conduzione degli impulsi nervosi al
cervello.
6.2.1 Difetti di rifrazione
-Miopia - allungamento dellʼasse
visivo e messa a fuoco dellʼimmagine anteriormente alla retina per cui si
riceve unʼimmagine confusa.
-Ipermetropia - occhi con asse visivo
più corto e messa a fuoco dellʼimmagine dietro alla retina con formazione,
anche in questo caso, di unʼimmagine confusa.
-Presbiopia - perdita
dellʼelasticità della lente e impossibilità di mettere a fuoco gli oggetti
vicini (alterazione propria dellʼetà).
-Astigmatismo - irregolarità di
curvatura della cornea.
-Cataratta - comparsa di macchie
opache nella lente.
-Infezioni - molte infezioni hanno
inizio dalla congiuntiva causando congiuntivite, una risposta infiammatoria.
-Causa di congiuntivite possono
essere infezioni o allergie.
-Possono risultarne danni permanenti
o anche cecità se lʼinfezione si diffonde ad altri tessuti degli occhi.
6.2.2 Alterazioni della retina
Se i recettori non funzionano adeguatamente, non possono
ricevere le immagini.
-Distacco di retina - parte della
retina si distacca dallʼepitelio pigmentato che le fa da supporto; senza
trattamento il distacco può diventare completo, causando cecità.
-Diabete mellito - il diabete causa
emorragie dai vasi retinici e compromette lʼapporto di ossigeno ai
fotorecettori; si formano nuovi vasi che impediscono però la visione e sono
causa di distacco di retina (retinopatia diabetica); è una delle cause di
cecità.
-Glaucoma - aumento anomalo della pressione
intraoculare per eccessiva produzione
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |