|
|
Medicina popolareper autodidatti
agosto 8, 2005 |
|
Indice della pagina
SNC =>
³Sistema nervoso centrale² SNP =>
³Sistema nervoso periferico² 1.0 Nessi del SNC 2.0 Struttura del SNC 3.0 Involucri 3.1 Involucri
protettivi 3.2 Meningi 4.0 Liquido cerebrospinale 4.1 Funzioni 4.2 Spazi che lo
contengono 4.3 Formazione e
circolazione del liquido 5.0 Midollo spinale 5.1 Struttura del
midollo spinale 5.2 Funzione del
midollo spinale 6.0 Encefalo 6.1 Strutture del
tronco cerebrale 6.2 Funzioni del
tronco cerebrale 6.3 Struttura del
cervelletto 6.4 Funzioni del
cervelletto 6.5 Diencefalo 6.6 Struttura del
cervello (telencefalo) 6.7 Funzioni della
corteccia cerebrale 7.0 Vie sensitive somatiche 7.1 Aree sensitive 7.2 Pools
principali di neuroni 7.3 Incrocio di vie
sensitive 7.4 Vie di sensibilità
tattile e di pressione 8.0 Vie motrici somatiche 8.1 Aree motorie -
muscoli scheletrici 8.2 Vie motrici
complesse e semplici 8.3 Via finale
comune 8.4 Vie motrici
somatiche |
AF 3.12 Sistema nervoso centrale
Anatomia neurologica © Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine
correlate: MmP 19.1
9.0 Modificazioni nel corso della
vita 9.1 Sviluppo
e degenerazione 9.2 Sviluppo
del nevrasse 9.3 Mancanza
di sviluppo 9.4 Sviluppo
di funzioni complesse 9.5 Degenerazione 10.0 Sistema
nervoso centrale 10.1 Regolazione
delle funzioni del corpo 10.2 Integrazione
di informazioni 11.0 Alterazioni del sistema nervoso centrale 11.1 Lesioni e
malattie 11.2 Incidenti
cerebrovascolari (ictus) 11.3 Paralisi
cerebrale 11.4 Demenza 11.5 Disordini
convulsivi |
INDICE: Sistema nervoso
centrale AF 3.12
SNC => ³Sistema nervoso centrale²
SNP => ³Sistema nervoso periferico²
1.0 Nessi
del SNC
2.0 Struttura
del SNC
3.0 Involucri
dell¹encefalo e del midollo spinale
3.1 Involucri
protettivi
3.2 Meningi
3.2.1 Dura
mater
3.2.2 Aracnoide
3.2.3 Pia mater
3.2.4 Meningi
4.0 Liquido
cerebrospinale (liquor)
4.1 Funzioni
4.2 Spazi
che lo contengono
4.3 Formazione
e circolazione del liquido cerebrospinale
5.0 Midollo
spinale
5.1 Struttura
del midollo spinale
5.1.1 Radici
nervose
5.1.1.1 Fibre
delle radici dorsali
5.1.1.2 Fibre
della radice ventrale
5.1.2 Gli
interneuroni
5.1.3 Nervi
spinali
5.1.4 Materia
grigia
5.1.5 Materia
bianca
5.2 Funzione
del midollo spinale
5.2.1 Tratti
5.2.1.1 Importanti
tratti ascendenti (sensitivi)
5.2.1.2 Importanti
tratti discendenti (motori)
6.0 Encefalo
6.1 Strutture
del tronco cerebrale
6.1.1 Midollo
allungato (Bulbo)
6.1.2 Ponte
6.1.3 Mesencefalo
6.2 Funzioni
del tronco cerebrale
6.3 Struttura
del cervelletto
6.3.1 Materia
bianca
6.3.2 Nuclei
dentati
6.4 Funzioni
del cervelletto
6.5 Diencefalo
6.5.1 Talamo
6.5.2 Chiasma
ottico (acustico)
6.5.3 Ipotalamo
6.5.3.1 Strutture
preminenti
6.5.3.2 Infundibolo
6.5.3.3 Funzioni
dell¹ipotalamo
6.5.4 Corpo
pineale
6.6 Struttura
del cervello (telencefalo)
6.6.1 Corteccia
cerebrale
6.6.1.1 Lobi
6.6.1.2 Giri
o circonvoluzioni
6.6.1.3 Solchi
6.6.1.4 Scissure
6.6.2 Tratti
cerebrali e nuclei basali
6.6.2.1 Nuclei
(o gangli) basali
6.6.2.2 Tratti
cerebrali
6.6.2.3 Corpo
striato
6.7 Funzioni
della corteccia cerebrale
6.7.1 Aree
funzionali della corteccia
6.7.1.1 Giro
postcentrale
6.7.1.2 Giro
precentrale
6.7.1.3 Circonvoluzione
trasversa (di Herschl)
6.7.1.4 Lobo
occipitale
6.7.2 Funzioni
sensoriali della corteccia
6.7.3 Funzioni
della corteccia motoria
6.7.3.1 Giro
precentrale
6.7.3.2 Area
motoria secondaria
6.7.4 Funzioni
di integrazione della corteccia
6.7.4.1 Coscienza
6.7.4.2 Linguaggio
6.7.4.3 Emozioni
6.7.4.4 Memoria
6.7.5 Specializzazione
degli emisferi cerebrali
6.7.5.1 Emisfero
sinistro
6.7.5.2 Emisfero
destro
6.7.6 Elettroencefalogramma
(EEG)
6.7.7 Onde
e attività
7.0 Vie
sensitive somatiche
7.1 Aree
sensitive
7.2 Pools
principali di neuroni
7.2.1 Neurone
sensitivo
7.2.2 Neurone
della via sensitiva
7.2.3 Neuroni
sensitivi di III ordine
7.3 Incrocio
di vie sensitive
7.4 Vie
di sensibilità tattile e di pressione
8.0 Vie
motrici somatiche
8.1 Aree
motorie - muscoli scheletrici
8.2 Vie
motrici complesse e semplici
8.3 Via
finale comune
8.4 Classificazione
di vie motrici somatiche
8.4.1 Tratti
piramidali
Tratti extrapiramidali
9.0 Modificazioni
nel corso della vita
9.1 Sviluppo
e degenerazione
9.2 Sviluppo
del nevrasse
9.3 Mancanza
di sviluppo
9.4 Sviluppo
di funzioni complesse
9.5 Degenerazione
10.0 Sistema
nervoso centrale e il corpo nell¹insieme
10.1 Regolazione
delle funzioni del corpo
10.2 Integrazione
di informazioni
11.0 Alterazioni
del sistema nervoso centrale
11.1 Lesioni
e malattie
11.2 Incidenti
cerebrovascolari (ictus)
11.3 Paralisi
cerebrale
11.4 Demenza
11.5 Disordini
convulsivi
1.0 Nessi
del SNC
Il sistema nervoso centrale nell¹organismo: connesso
tramite gli organi dei sensi, il sistema endocrino e il sistema nervoso
periferico con gli altri sistemi dell¹organismo.
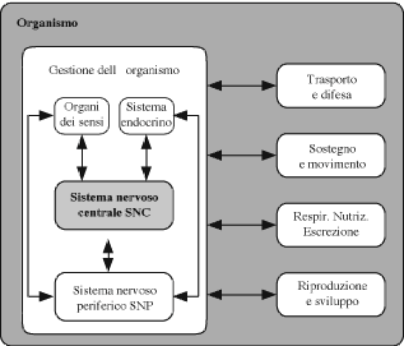
2.0 Struttura del SNC
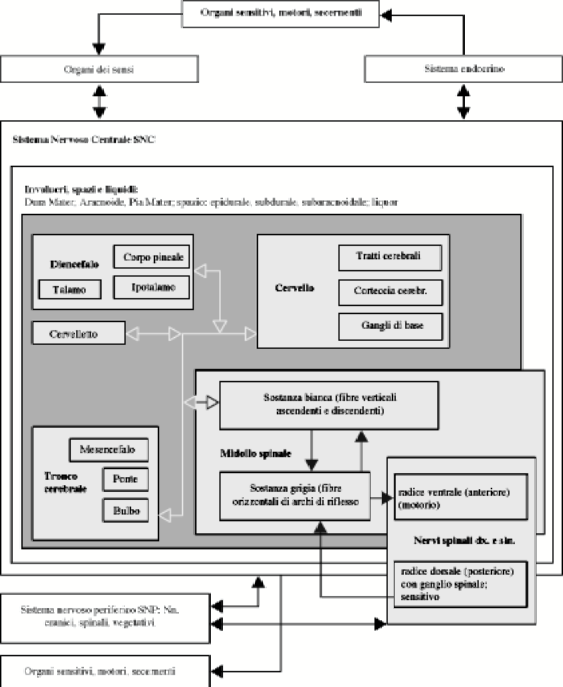
3.0 Involucri
dell¹encefalo e del midollo spinale
Involucri, meningi.
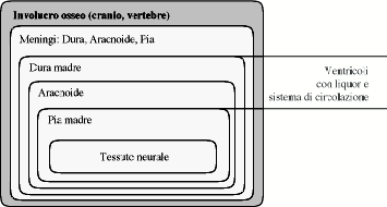
3.1 Involucri
protettivi
(fig. 12-2)
- Il
rivestimento esterno è l¹osso; le ossa del cranio racchiudono l¹encefalo e le
vertebre circondano il midollo spinale.
- Il
rivestimento interno è dato dalle meningi; le meningi spinali continuano
caudalmente, entro il canale vertebrale, al di là del termine del midollo
spinale.
3.2 Meningi
Tre strati membranosi: dura mater, aracnoidee, pia
mater.
(fig. 12-3)
3.2.5 Dura mater
Tessuto connettivo fibroso denso; nel cranio, lo
strato esterno ha funzione di endostio; ha tre importanti dipendenze:
- Falce
cerebrale: lamina che si protende tra i due emisferi cerebrali nella scissura
longitudinale.
- Seni
durali - vene e parete fibrosa pura che raccolgono il sangue rifluente
dell¹encefalo per riportalo al cuore: seno sagittale superiore - è uno dei seni
durali.
- Falce
cerebellare - si insinua per breve tratto fra i due emisferi del cervelletto.
Tentorio cerebellare - separa il cervelletto dal cervello.
3.2.2 Aracnoide
- Membrana
molto sottile e delicata, strato a tela di ragno tra pia e dura mater.
3.2.3 Pia
mater
Strato più interno, trasparente, che aderisce
perfettamente alla superficie dell¹encefalo:
- del
midollo spinale: è la membrana vascolare; caudalmente al midollo spinale
concorre a formare una corda fibrosa sottile - filum terminale - che
va a fissarsi sul coccige.
3.2.4 Meningi
Tra le meningi e attorno a esse esistono diversi
spazi:
- Spazio
epidurale tra la dura mater e la superficie interna delle ossa della volta
cranica
nell¹adulto
- e tra tutta la dura spinale e le vertebre; contiene cuscinetti adiposi e
vasi.
- Spazio
subdurale - tra la dura e l¹aracnoide; contiene un liquido sieroso lubrificante
- Spazio
subaracnoidale - tra l¹aracnoide e la pia mater; contiene una significativa
quantità di liquido cerebrospinale.
4.0 Liquido
cerebrospinale (liquor)
Funzioni, spazi, formazione e circolazione.
4.1 Funzioni
- Supporto
e protezione.
- Riserva
di liquido circolante, che è regolato per rilevare modificazioni dell¹ambiente
interno.
4.2 Spazi
che lo contengono
- Liquido
cerebrospinale - si trova nello spazio subaracnoidale attorno al cervello e al
midollo spinale, ma anche dentro le cavità ventricolari e il canale centrale
del midollo.
- Ventricoli
- spazi pieni di liquor contenuti nel cervello; quattro ventricoli cerebrali
(fig.
12-4).
- Primo e
secondo ventricolo (ventricoli laterali) - uno in ciascun emisfero cerebrale.
- Terzo
ventricolo - cavità ristretta e verticale tra le due masse del talamo.
- Quarto
ventricolo - sottile cavità a base romboidale tra cervelletto e superficie
dorsale del tronco.
4.3 Formazione
e circolazione del liquido cerebrospinale
(fig. 12-5)
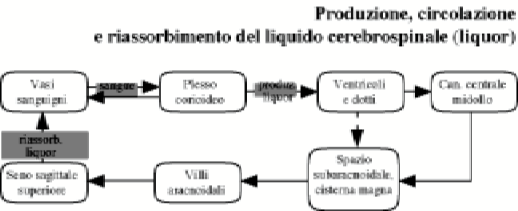
- Formatosi
per separazione di liquido dal plasma sanguigno a livello dei plessi corioidei.
- Il
liquido passa dai ventricoli laterali nel terzo ventricolo per mezzo dei fori
interventricolari di Monroe.
- Dal
terzo ventricolo passa nel quarto per mezzo dell¹acquedotto di Silvio.
- Dal
quarto ventricolo può passare in due diversi compartimenti:
- Parte
del liquido può entrare nel canale centrale del midollo spinale.
- Altro
liquido esce dal quarto ventricolo attraverso tre aperture della sua volta e
passa nella cisterna magna, uno spazio che è in continuità col rimanente spazio
subaracnoidale.
- Il
liquor circola nello spazio subaracnoidale e viene poi drenato nei seni venosi
della dura per mezzo dei vasi dei villi aracnoidali.
5.0 Midollo
spinale
Struttura e funzione.
5.1 Struttura
del midollo spinale
(fig. 12-6)
- Contenuto
nel canale vertebrale dal grande forame occipitale fino al margine inferiore
della prima vertebra lombare.
- Di forma
cilindrica-ovale che si restringe all¹estremità caudale.
- Ha due
rigonfiamenti, uno nella regione cervicale e uno nella regione lombare.
- La
fessura mediana anteriore e il solco mediano posteriore sono due docce di cui
l¹anteriore è la più profonda e ampia.
5.1.1 Radici
nervose
Fibre dorsali e ventrali.
5.1.1.1 Fibre
delle radici dorsali
- Portano
informazioni sensitive al midollo spinale.
- Gangli
delle radici dorsali - sede del protoneurone delle vie sensitive del midollo
(contengono neuroni unipolari destinati alla sostanza grigia del midollo
spinale o del bulbo).
5.1.1.2 Fibre
della radice ventrale
- Portano
informazioni fuori del midollo spinale.
- I
neuroni di origine sono multipolari e si trovano nella sostanza grigia del
midollo spinale.
5.1.2 Interneuroni
Sono situati nella parte centrale della sostanza
grigia del midollo spinale.
5.1.3 Nervi
spinali
33 o 34 paia di nervi misti si formano per l¹unione
delle radici ventrali e dorsali.
5.1.4 Materia
grigia
- Estesa
per tutta la lunghezza del midollo.
- È
prevalentemente formata dal pericarione dagli interneuroni e dai neuroni
motori.
- In
sezioni trasversali presenta la forma della lettera H con due braccia o corna
anteriori e due posteriori e una coppia di corni laterali.
5.1.5 Materia
bianca
- Circonda
la sostanza grigia ed è divisa, in ciascuna metà del midollo, in tre funicoli:
anteriore, laterale e posteriore.
- Ciascun
funicolo consta di vari fasci di assoni suddivisi in tratti.
- Il nome
dei tratti spinali indica la sede del tratto, la struttura in cui gli assoni
hanno origine e la struttura nella quale terminano.
5.2 Funzione
del midollo spinale
- Centri
di tutti i riflessi spinali; i
centri per i riflessi sono localizzati nella sostanza grigia del midollo.
- Fornisce
due vie di conduzione da e per il cervello:
- Tratti
ascendenti - conducono impulsi dal midollo al cervello.
- Tratti
discendenti - conducono impulsi dal cervello al midollo spinale.
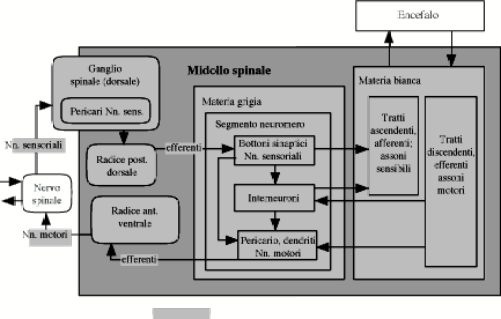
5.2.1 Tratti
I tratti sono formati da fasci di assoni.
Essi sono organizzazioni strutturali e funzionali di
fibre nervose:
- Strutturale
- tutti gli assoni di un tratto hanno origine nella stessa struttura e
terminano in una struttura comune.
- Funzionale
- tutti gli assoni di un tratto sono al servizio della medesima funzione
generale.
5.2.1.1 Importanti
tratti ascendenti (sensitivi) (fig. 12-7)
- Tratti
spinotalamici laterali - sensibilità tattile protopatica (cruda), sensibilità
termica e dolorifica.
- Tratti
spinotalamici anteriori - sensibilità tattile protopatica e di pressione.
- Fascicoli
gracile e cuneato - sensibilità tattile discriminata e propriocettiva
cosciente.
- Tratti
spinocerebellari - propriocettiva incosciente.
5.2.1.2 Importanti
tratti discendenti (motori) (fig. 12-7)
- Tratti
corticospinali laterali - movimenti volontari della metà controlaterale del
corpo.
- Tratti
corticospinali anteriori - movimenti volontari della metà omolaterale del
corpo.
- Tratti
reticolospinali laterali - trasmettono impulsi facilitatori ai neuroni motori
inferiori.
- Tratti reticolospinali mediali - impulsi inibitori
ai neuroni motori inferiori.
- Tratti rubrospinali - impulsi che coordinano i
movimenti del corpo e il mantenimento della postura.
6.0 Encefalo
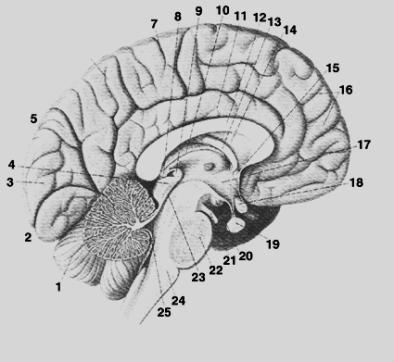
1) Cervelletto 9) Scissura posteriore 17) Terzo ventricolo
2) Solco
calcarino 10) Plesso 3o ventricolo 18) Chiasma ottico
3) Lobo
occipitale 11) Ghiro cingolato 19) Ipofisi
4) Lamina
tettale 12) Corpo calloso 20) Corpo mamillare
5) Solco
parieto-occipitale 13) Fornice 21) N. oculomotorio
6) Lobo
parietale 14) Setto pellucido 22) Conte
7) Solco
centrale 15) Scissura anteriore 23) Acquedotto
8) Ghiand.
pineale (epifisi) 16) Lobo frontale 24) Medulla oblongata
25) Quarto ventricolo
6.1 Strutture
del tronco cerebrale
(fig. 12-9)
6.1.1 Midollo
allungato (Bulbo)
- È la
parte più caudale del tronco.
- È lungo
pochi centimetri ed è separato dal ponte per mezzo di un solco trasversale.
- Formato
da sostanza bianca e da un reticolo di sostanza grigia e bianca denominato
³formazione reticolare².
- Piramidi:
due colonne sporgenti di sostanza bianca sulla superficie ventrale del bulbo;
sono formate dalle fibre dei tratti corticospinali (piramidali).
- Olive:
sporgenza situate ai lati delle piramidi.
- Nuclei:
gruppi di neuroni situati entro la formazione reticolare.
6.1.2 Ponte
- Situato
cranialmente al bulbo e caudalmente al mesencefalo.
- Composto
da sostanza bianca e dalla formazione reticolare.
6.1.3 Mesencefalo
- Localizzato
tra ponte e diencefalo; detto anche cervello medio.
- Composto
da materia bianca e dalla formazione reticolare.
- Comprende
i peduncoli cerebrali che conducono impulsi tra mesencefalo e cervello.
Corpi quadrigemini - Lamina dorsale del mesencefalo:
- Presentano
due coppie di collicoli, i superiori e gli inferiori.
- Sono
situati davanti al cervelletto.
- I
collicoli inferiori contengono centri delle vie acustiche.
- I
collicoli superiori contengono centri visivi.
- Il
nucleo rosso è detto ³substantia nigra²: gruppi di neuroni coinvolti nel
controllo muscolare.
6.2 Funzioni
del tronco cerebrale
- Presiede
a funzioni sensitive, motorie e ai riflessi.
- Tratti
spinotalamici - attraversano il tronco cerebrale.
- Fascicoli
(gracile e cuneato) e tratti spinoreticolari: tratti sensitivi i cui assoni
terminano nella sostanza grigia del tronco cerebrale.
- Tratti
corticospinali e reticolospinali: due dei principali tratti presenti nella
sostanza bianca del tronco cerebrale.
Nuclei del Bulbo - contengono centri dei riflessi:
- Di
primaria importanza: centri cardiaci, vasomotori, respiratori.
- D¹importanza
non vitale: vomito, tosse, starnuto.
- Ponte:
contiene centri per riflessi mediali al V, VI, VII, VIII paio di nervi cranici
e dai centri pneumotassici che concorrono alla regolazione del respiro.
- Mesencefalo
- contiene centri per riflessi controllati da alcuni nervi cranici (III e IV
paio).
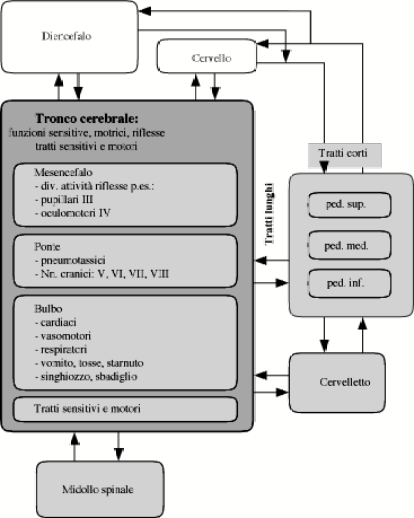
6.3 Struttura
del cervelletto
(fig. 12-10)
- Per le
dimensioni è la seconda parte dell¹encefalo.
- Localizzato
nella fossa cranica posteriore; la scissura trasversa lo separa dal cervello.
- La
sostanza grigia forma la corteccia: la sostanza bianca prevale internamente.
- Arbor
vitae - nome con cui ci si riferisce alla sostanza bianca cerebrale; ha morfologia
che ricorda quella delle venature d¹una foglia.
- Il
cervelletto ha numerosi solchi e lamine disposte trasversalmente all¹asse
sagittale.
- Macroscopicamente
presenta il verme in posizione mediana e due emisferi ai suoi lati.
6.3.1 La
sostanza bianca
Si trova internamente e consta di tratti corti o
lunghi.
- Tratti
corti: conducono impulsi dai neuroni situati nella corteccia cerebrale ai
neuroni che formano i nuclei immersi nella sostanza bianca del cervelletto.
- Tratti
lunghi - conducono impulsi da e per il cervelletto; le fibre entrano o escono
percorrendo una delle tre coppie di peduncoli cerebrali:
- Peduncoli
cerebrali inferiori - composti principalmente di tratti che entrano nel
cervelletto dal bulbo e dal midollo spinale.
- Peduncoli
cerebrali medi - composti quasi interamente da tratti che entrano nel
cervelletto dal ponte.
- Peduncoli
cerebrali superiori - composti principalmente da tratti dei nuclei dentati del
cervelletto che, attraverso il nucleo rosso del mesencefalo, sono destinati a raggiungere
il talamo.
6.3.2 Nuclei
dentati
- Importante
coppia di nuclei cerebrali localizzati ciascuno in un emisfero.
- Nuclei
connessi col talamo e con le aree motorie della corteccia cerebrale da tratti
nervosi.
- Per
mezzo di tratti il cervelletto influenza coi suoi impulsi la corteccia motoria
e questa, a sua volta, influenza il cervelletto.
6.4 Funzioni
del cervelletto
Tre funzioni generali, ognuna delle quali è impegnata
nel controllo dei muscoli scheletrici:
- Collabora
con la corteccia cerebrale nell¹esecuzione di movimenti di agilità, coordinando
le attività dei gruppi muscolari.
- Controlla
i muscoli scheletrici per il mantenimento dell¹equilibrio.
- Controlla la postura; opera a livello di subconscio
affinché si ottengano movimenti muscolari lisci (senza scosse o tremori) che
rendono i movimenti efficaci e coordinati.
- Il
cervelletto confronta i comandi motori del cervello con le informazioni inviate
dai propriocettori dell¹apparato locomotore; gli impulsi viaggiano dal
cervelletto sia verso la corteccia cerebrale, sia verso i muscoli per produrre
i movimenti intenzionali (fig. 12-11).
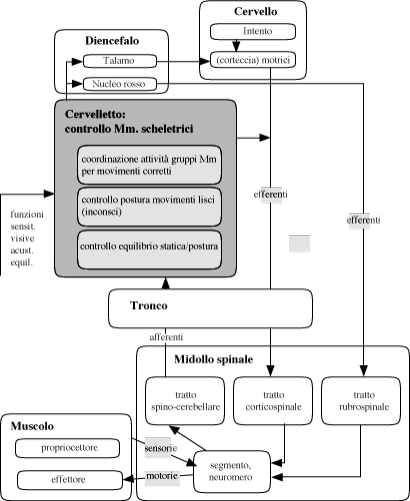
6.5 Diencefalo
(fig.12-12)
- Situato
tra emisferi cerebrali e mesencefalo.
- Consta
di diverse strutture collocate attorno al terzo ventricolo: talamo, ipotalamo,
chiasma ottico, corpo pineale, e altre.
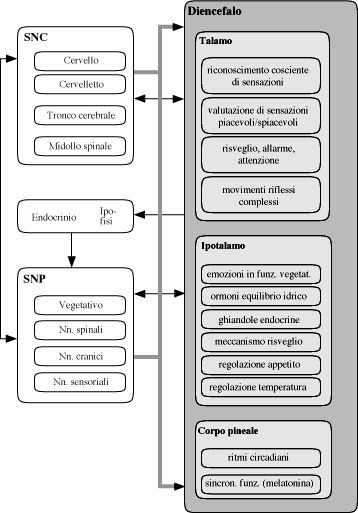
6.5.1 Talamo
- Massa
doppia, ovoidale e liscia; consta di diversi nuclei.
- Ciascuna
massa laterale forma una delle pareti laterali del terzo ventricolo.
- Corpi
genicolati: due dei più importanti nuclei compresi nel talamo; localizzati
nella parte posteriore di ciascuna massa laterale; in rapporto con le vie
ottiche e acustiche.
6.5.2 Chiasma
ottico (acustico)
- Importanti
stazioni di relais per le vie ottiche (i genicolati laterali) e per le vie
acustiche (i genicolati mediali) delle vie che conducono questi impulsi alle
rispettive aree sensoriali specifiche della corteccia cerebrale.
Presiede alle seguenti funzioni primarie:
- Gioca
due ruoli nel meccanismo responsabile delle sensazioni.
- Gli
impulsi consentono il riconoscimento cosciente di sensazioni crude, grossolane,
non discriminate del dolore, della temperatura e del tatto.
- Sui
neuroni talamici si collegano tutti i tipi di impulsi sensoriali prima di
essere ritrasmessi alla corteccia cerebrale; fanno eccezione gli impulsi
olfattivi che raggiungono prima la corteccia e poi il talamo.
- Gioca
una parte nel meccanismo responsabile delle emozioni, associando gli impulsi
afferenti in sensazioni piacevoli o sgradevoli.
- Ha
parte importante nel meccanismo del risveglio.
- Prende
parte a meccanismi che producono movimenti riflessi complessi.
6.5.3 Ipotalamo
Consta di diverse strutture posizionate
ventralmente al talamo.
Forma il pavimento del terzo ventricolo e la
parte inferiore delle pareti laterali.
6.5.3.1 Strutture
preminenti
Situati nell¹ipotalamo sono:
- Nuclei
sopraottici - gruppi pari di neuroni situati al di sopra e ai lati del chiasma
ottico.
- Nuclei
paraventricolari - localizzati nello spessore delle pareti del terzo
ventricolo.
- Corpi
mammillari - parte posteriore dell¹ipotalamo coinvolta nel circuito che collega
l¹ippocampo col talamo e la corteccia cerebrale (vedi pag. 321).
6.5.3.2 Infundibolo
Il peduncolo che collega l¹ipotalamo col lobo
posteriore dell¹ipofisi:
- Piccola,
ma funzionalmente importante area del cervello, presiede a diverse funzioni
importanti per la sopravvivenza e il benessere.
- È
il legame tra mente e soma.
- È
il legame tra sistema nervoso e sistema endocrino.
6.5.3.3 Funzioni
dell¹ipotalamo
- Regolatore
e coordinatore delle attività del sisterma vegetativo.
- Principale
stazione di relais tra la corteccia cerebrale e i centri vegetativi inferiori;
parte essenziale della via per mezzo della quale le emozioni possono esprimere
sé stesse nel cambiamento delle funzioni del corpo.
- Sintetizza
gli ormoni secreti dal lobo posteriore dell¹ipofisi e gioca un ruolo essenziale
nel mantenimento dell¹equilibrio idrico.
- Alcuni
suoi neuroni funzionano come ghiandole endocrine.
- Svolge
un ruolo fondamentale nei seguenti meccanismi:
-
risveglio;
-
regolazione appetito;
-
mantenimento della temperatura corporea nella norma.
6.5.4 Corpo
pineale
- Situato
al di sopra dei corpi quadrigemini del mesencefalo.
- Coinvolto
nella regolazione dell¹orologio biologico del corpo.
- Produce
alcuni ormoni - uno dei più notevoli è la melatonina.
6.6 Struttura
del cervello (telencefalo)
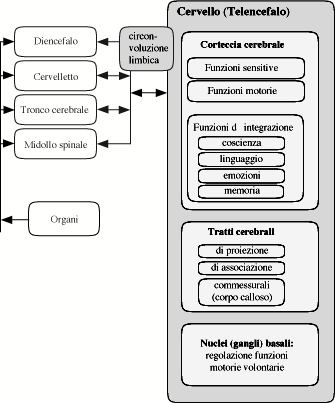
6.6.1 Corteccia
cerebrale
- Materia
grigia; forma la superficie esterna ed è dotata di sei strati di neuroni.
- La parte
più sviluppata e più craniale dell¹encefalo; consiste degli emisferi cerebrali
destro e sinistro; ciascun emisfero è suddiviso in cinque lobi (fig. 12-13).
6.6.1.1 Lobi
- Lobo
frontale.
- Lobo
parietale.
- Lobo
temporale.
- Lobo
occipitale.
- Insula
(isola di Reil).
6.6.1.2 Giri
o circonvoluzioni
Se ne danno qui alcuni nomi: giro precentrale; giro
postcentrale; giro del cingolo; giro dell¹ippocampo.
6.6.1.3 Solchi
Docce profonde.
6.6.1.4 Scissure
Le docce più profonde che suddividono ciascun
emisfero cerebrale in lobi; le scissure principali sono:
- Scissura
longitudinale (interemisferica) - è la più profonda; separa gli emisferi uno
dall¹altro.
- Solco
centrale (scissura del Rolando) - doccia tra i lobi frontale e parietale.
- Scissura
parieto-occipitale: separa il lobo occipitale dal lobo parietale.
6.6.2 Tratti
cerebrali e nuclei basali
Nuclei, tratti e corpo striato.
6.6.2.1 Nuclei
(o gangli) basali
Masse di sostanza grigia isolate all¹interno della
sostanza bianca di ciascun emisfero; comprendono:
- Il
nucleo caudato.
- Il
nucleo lenticolare (formato dal putemen e dal globo pallido).
- Il
nucleo amigdaloideo.
6.6.2.2 Tratti
cerebrali
Formati da fibre della sostanza bianca; se ne
distinguono di tre tipi (fig.
12-14).
- Tratti
di proiezione - assoni del complesso di fibre talamocorticali e delle fibre
discendenti del sistema motore (tratti piramidale ed extrapiramidale)
- Tratti
di associazione: vi sono numerosi tratti che collegano tra loro circonvoluzioni
diverse d¹uno stesso emisfero.
- Tratti
commessurali: si estendono da una circonvoluzione di un emisfero alla
circonvoluzione corrispondente dell¹emisfero controlaterale; formano il corpo
calloso e le commessure anteriore e posteriore.
6.6.2.3 Corpo
striato
Formato dal nucleo caudato, dalla capsula interna e
dal nucleo lenticolare.
6.7 Funzioni
della corteccia cerebrale
6.7.1 Aree
funzionali della corteccia
Alcune aree della corteccia sono preminentemente
impegnate in particolari funzioni.
6.7.1.1 Giro
postcentrale
Principale area sensitiva somatica generale, riceve
impulsi dai ricettori stimolati da caldo, freddo, tatto.
6.7.1.2 Giro
precentrale
Principale area motrice somatica; gli impulsi che
hanno origine in quest¹area discendono lungo i tratti motori e stimolano i
muscoli scheletrici.
6.7.1.3 Circonvoluzione
trasversa (di Herschl)
Area uditiva primaria.
6.7.1.4 Lobo
occipitale
Aree visive primarie.
6.7.2 Funzioni
sensoriali della corteccia
- Sensibilità
somatica - sensibilità tattile, di pressione, della temperatura, propriocettiva
e simili, che richiedono complessi organi di senso.
- La
corteccia contiene una ³mappa² sensitiva somatica del corpo.
- Le
informazioni inviate alle aree sensitive primarie sono poi inviate alle aree
sensitive di associazione e anche ad altre parti del cervello.
- Le
informazioni sensitive vengono confrontate e valutate; la corteccia integra
frazioni separate di informazioni in una percezione d¹insieme.
6.7.3 Funzioni
della corteccia motoria
Per effettuare movimenti normali devono entrare in
funzione diverse parti del sistema nervoso.
6.7.3.1 Giro
precentrale
Area motoria somatica primaria; controlla singoli
muscoli.
6.7.3.2 Area
motoria secondaria
Situata nel giro immediatamente anteriore al giro
precentrale; attiva simultaneamente
gruppi di muscoli.
6.7.4 Funzioni
di integrazione della corteccia
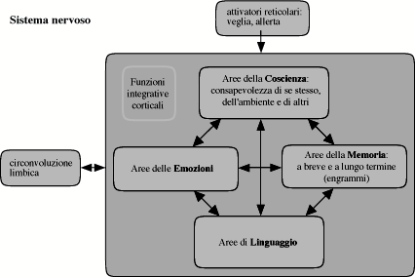
6.7.4.1 Coscienza
- Stato di
consapevolezza di sé, dell¹ambiente circostante e dell¹esistenza di altri.
- Dipende
dall¹attivazione dei neuroni corticali ad opera di impulsi che li raggiungono
attraverso il sistema reticolare attivatore.
Sul funzionamento della coscienza sappiamo poco o
niente. Certo è solo che la minima parte di funzioni corporee e gestionali é
accessibile al cosciente (sensitive e effettuate) e che la maggior parte si
svolge nell¹²inconscio².
Sul sistema reticolare attivatore i concetti correnti
sono due:
- Funziona
come sistema di risveglio per la corteccia cerebrale.
- Il suo
funzionamento è essenziale per mantenere lo stato di allerta e di coscienza.
6.7.4.2 Linguaggio
- Capacità
di parlare e di scrivere parole e capacità di comprendere il linguaggio scritto
e parlato.
- Centri
del linguaggio - aree nei lobi frontale, parietale e temporale.
- Nel 90%
delle persone i centri del linguaggio sono localizzati nell¹emisfero sinistro;
nel restante 10% trovansi nell¹emisfero destro o in entrambi.
- Afasie -
lesioni dei centri del linguaggio.
Sul funzionamento linguistico sappiamo poco o niente.
6.7.4.3 Emozioni
- L¹esperienza
soggettiva e le espressioni oggettive dell¹emotività coinvolgono il
funzionamento del sistema limbico.
Sul funzionamento delle emozioni sappiamo poco o
niente.
Sistema limbico - noto anche come ³il cervello delle
emozioni²:
- Molte
delle strutture del sistema limbico si trovano sulla superficie mediale del
cervello e sono: il giro del cingolo e l¹ippocampo.
- Queste
aree hanno connessioni primarie con altre parti del cervello come: talamo,
fornice, nuclei settali, nucleo amigdaloideo e ipotalamo.
6.7.4.4 Memoria
- Una
delle quattro attività cerebrali principali.
- La
corteccia è capace di immagazzinare e riutilizzare sia la memoria a breve sia
quella a lungo termine.
- Tra le
aree responsabili della memoria a lungo e a breve termine vi sono i lobi
temporali, parietali e occipitali.
- Engrammi
- Tracce strutturali nella
corteccia, espressioni della memoria a lungo termine.
- Il sistema
limbico del cervello gioca un ruolo chiave nelle funzioni della memoria.
Sul funzionamento della memoria non esistono modelli
approvati: non si sa come facciamo a memorizzare un numero telefonico.
6.7.5 Specializzazione
degli emisferi cerebrali
Gli emisferi destro e sinistro del cervello si
specializzano in funzioni differenti; tuttavia, entrambi i lati del cervello di
una persona normale comunicano tra loro per adempiere a funzioni complesse.
Certi autori spiegano così la specializzazione degli
emisferi:
- l¹emisfero
sinistro è specializzato nelle funzioni del tempo (susseguenza di percezioni e
azioni) mentre
- l¹emisfero
destro è specializzato nella percezione e attivazione contemporanea di stimoli.
6.7.5.1 Emisfero
sinistro (consentivo)
È responsabile
delle:
- Funzioni
del linguaggio.
- È
dominante per il controllo delle mani nei movimenti fatti insieme da entrambe,
e in quelli consecutivi o sequenziali.
6.7.5.2 L¹emisfero
destro (coordinato)
È responsabile della:
- Percezione
di certi tipi di stimoli acustici (p.es. accordi musicali).
- Percezione
tattile.
- Percezione
e visualizzazione delle correlazioni spaziali tutte.
- Esecuzione
contemporanea di diverse azioni (coordinazione).
6.7.6 Elettroencefalogramma
(EEG)
Registrazione dei potenziali elettrici del cervello -
consistono in onde registrate facendo uso di elettrodi sistemati su punti
diversi del cranio.
6.7.7 Onde
e attività
In base alla frequenza e all¹ampiezza si
differenziano quattro tipi di onde (fig. 12-20).
- Onde
beta - frequenza > 13 Hz e voltaggio relativamente basso; ³onde da attività
cerebrale².
- Onde
alfa - frequenza tra 8 e 13 Hz e voltaggio relativamente basso; ³onde da
relax².
- Onde
teta - frequenza da 4 a 7 Hz e voltaggio basso; ³onde da assopimento².
- Onde
delta - frequenza < 4 Hz e voltaggio alto; ³onde da sonno profondo².
7.0 Vie
sensitive somatiche
7.1 Aree
sensitive
Affinché la corteccia cerebrale possa adempiere alle
sue funzioni sensoriali, prima di tutto devono giungere informazioni dai
recettori periferici alle aree sensitive della corteccia, tramite le vie
sensitive del nevrasse (fig. 12-21).
7.2 Pools
principali di neuroni
Sono da considerare tre pools principali di neuroni.
7.2.1 Neurone
sensitivo
(Protoneurone) conduce impulsi dalla periferia (il
pericario ha sede nei gangli spinali) al sistema nervoso centrale.
7.2.2 Neurone
della via sensitiva
(Deutoneurone)
- Ha sede
nel midollo spinale o nel tronco cerebrale e invia i propri assoni al talamo.
- Il
pericario e i dendriti del deutoneurone si trovano nella sostanza grigia del
midollo spinale o in alcuni nuclei del tronco cerebrale.
- Gli
assoni si impegnano nei tratti ascendenti che percorrono il midollo spinale e
attraversano il tronco cerebrale per terminare nel talamo, dove fanno sinapsi
coi dendriti o col pericario del III gruppo di neuroni sensitivi.
7.2.3 Neuroni
sensitivi di III ordine
- Conducono
impulsi dal talamo al giro postcentrale del lobo parietale.
- I fasci
di assoni dei neuroni di III ordine formano le vie talamocorticali.
- Tali
assoni attraversano la capsula interna per raggiungere la corteccia cerebrale.
7.3 Incrocio
di vie sensitive
Le vie sensitive destinate alla corteccia cerebrale
sono crociate come pure le corrispondenti vie motrici (vedi anche tratti
piramidali):
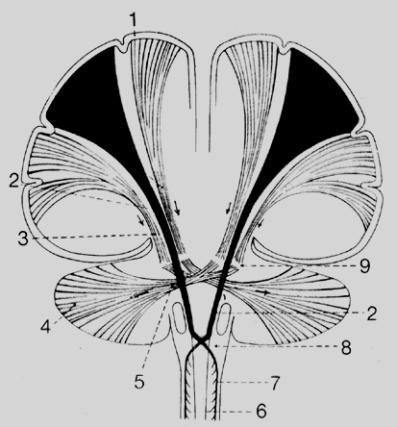
1) Corteccia cerebrale 4) Cervelletto 7)
Tratto corticospinale piramidale laterale
2) Fibre corticospinali 5) Peduncolo med. 8) Incrocio
piramidale motorio
3) Fibre corticopontine 6) Tratto cortic. pir. 9) Nuclei del
ponte
7.4 Vie
di sensibilità tattile e di pressione
Due sono le vie che conducono gli impulsi della
sensibilità tattile e della pressione:
Il sistema del lemnisco mediale.
- Consta
di tratti che hanno formato i fascicoli gracile e cuneato nel midollo spinale e
che hanno fatto relais sui neuroni di II ordine dei nuceli del Goll e di
Burdach del bulbo.
- Gli
assoni di questi neuroni di II ordine si decussano nel bulbo e divengono
ascendenti formando il lemnisco mediale.
- Funzioni
- trasmettere impulsi della sensibilità tattile discriminata e della pressione
oltre alla sensibilità propriocettiva (cinestesica) cosciente.
Vie spinotalamiche - provvedono alla trasmissione
della sensibilità tattile, non discriminata,e della pressione.
8.0 Vie
motrici somatiche
8.1 Aree
motorie - muscoli scheletrici
Affinché la corteccia cerebrale possa espletare le
sue funzioni motorie, gli impulsi devono essere condotti dalle aree motorie
fino ai muscoli scheletrici percorrendo le vie motrici somatiche.
8.2 Vie
motrici complesse e semplici
Il sistema motorio è costituito da neuroni che
conducono impulsi dal sistema nervoso centrale ai muscoli scheletrici; alcune
delle vie motrici sono alquanto complesse, altre sono molto semplici.
8.3 Via
finale comune
Principio della via finale comune - principio cardine
delle vie motrici somatiche; solo una via finale comune, l¹insieme dei neuroni
inferiori del sistema motore, conduce gli impulsi direttamente ai muscoli
scheletrici.
8.4 Classificazione
di vie motrici somatiche
Le vie motrici somatiche possono essere classificate
in due modi: tratti piramidali e tratti extrapiramidali (fig. 12-22).
8.4.1 Tratti
piramidali
Organizzano una via motrice diretta corticospinale.
- Circa
3/4 delle fibre si decussano a livello del bulbo, discendono nel midollo
spinale come tratto corticospinale crociato e contraggono sinapsi coi neuroni
inferiori controlaterali all¹emisfero cerebrale di origine.
- Circa
1/4 delle fibre non decussa nel bulbo, ma decussa poi, in prevalenza nel
midollo, segmento per segmento; poche fibre restano omolaterali ai neuroni superiori
di origine.
8.4.2 Tratti
extrapiramidali
Organizzano una via motrice multineuronale i cui
effetti, in ultima analisi, si scaricano anch¹essi sui neuroni motori
inferiori.
- Comprendono
tutti gli altri tratti motori ad eccezione dei piramidali.
- Nell¹ambito
dell¹encefalo, organizzano importanti circuiti di relais tra aree motorie della
corteccia, nuclei basali, talamo, cervelletto e formazione reticolare del
tronco cerebrale.
- Nell¹ambito
del midollo spinale, i tratti più importanti sono i tratti reticolospinali.
- Gli
impulsi che percorrono le vie extrapiramidali sono responsabili della
produzione di attività motorie d¹insieme e automatiche.
- La
conduzione lungo i tratti extrapiramidali ha un ruolo importante anche nelle
reazioni motorie a input emotivi.
- Programma
motorio - insieme di comandi coordinati che controllano le attività motorie
programmate, mediate dalle vie extrapiramidali.
9.0 Modificazioni
nel corso della vita
9.1 Sviluppo
e degenerazione
Le più ovvie modificazioni cui è soggetto il sistema
nervoso centrale nel corso della vita sono lo sviluppo e la degenerazione.
9.2 Sviluppo
del nevrasse
Lo sviluppo del nevrasse ha inizio già nell¹utero
materno.
9.3 Mancanza
di sviluppo
Il mancato sviluppo risulta evidente nei neonati per
la mancanza delle funzioni integrative complesse.
- Linguaggio
- Memoria
- Comprensione
delle correlazioni spaziali
- Attitudini
motorie più complesse.
9.4 Sviluppo
di funzioni complesse
Le funzioni complesse si sviluppano nel corso del
raggiungimento dell¹età adulta.
9.5 Degenerazione
Nell¹età avanzata - degenerazione dei tessuti.
- Degenerazione
grave - incapacità di adempiere alle funzioni complesse.
- Degenerazione
lieve - perdita temporanea della memoria o difficoltà nell¹esecuzione di
compiti motori complessi.
10.0 Sistema
nervoso centrale e corpo nell¹insieme
10.1 Regolazione
funzioni del corpo
Il sistema nervoso centrale funge da regolatore
fondamentale delle funzioni del corpo; essenziale per la sopravvivenza.
10.2 Integrazione
di informazioni
Il sistema nervoso centrale è capace di integrare
frammenti di informazioni provenienti da tutto il corpo, dare ad esse un senso,
prendere decisioni.
11.0 Alterazioni
del sistema nervoso centrale
Lesioni, incidenti, paralisi, demenza, convulsioni.
11.1 Lesioni e
malattie
I neuroni vengono definitivamente distrutti da
lesioni o da malattie.
11.2 Incidenti
cerebrovascolari (ictus)
Emorragia cerebrale o blocco del circolo sanguigno
(per embolo o trombo).
- Un danno
che colpisce aree motorie del cervello determina una paralisi che interessa il
lato del corpo controlaterale alla sede della lesione.
- Emiplegia
- paralisi di un intero lato del corpo.
11.3 Paralisi
cerebrale
Malattia spastica dell¹infanzia dipendente da un
danno ai tessuti cerebrali.
- Danno
permanente e non progressivo nelle aree di controllo motorio del cervello,
presente alla nascita o subito dopo e permanente per il resto della vita.
- Cause
possibili - infezioni prenatali o malattie della madre, traumi meccanici alla
testa del feto durante il parto, veleni che danneggiano i nervi, anossia
cerebrale o altri fattori.
- Paralisi
spastica - paralisi caratterizzata da contrazioni involontarie dei muscoli
colpiti: quattro tipi:
- Emiplegia
- paralisi di un intero lato del corpo.
- Paraplegia
- paralisi di entrambi gli arti inferiori.
- Triplegia
- paralisi di entrambi gli arti inferiori e di un arto superiore.
- Tetraplegia
- paralisi di tutti e quattro gli arti.
11.4 Demenza
- Termine
generico per indicare varie malattie degenerative che hanno per risultato la
distruzione di neuroni cerebrali che compromettono la materia, la durata
dell¹attenzione, le capacità intellettive, la personalità e il controllo
motorio.
- Malattia
di Alzheimer - demenza dovuta a lesioni che si sviluppano nella corteccia
cerebrale nell¹età media della vita; causa non esattamente nota e trattamenti
terapeutici non efficaci.
- Malattia
di Huntington - malattia ereditaria caratterizzata da corea (un¹attività
motoria incoercibile e senza un fine determinato - una discinesia); progredisce
fino alla demenza e alla morte.
- Sindrome
di immunodeficienza acquisita (AIDS) - neuroni infettati da virus HIV il quale
causa degenerazione progressiva dei tessuti cerebrali, quindi demenza.
11.5 Disordini
convulsivi
Anomalia comune del sistema nervoso con crisi di
contrazioni tonico-cloniche; brusca accensione di attività neuronali abnormi:
- Le
convulsioni possono essere gravi o lievi
- Epilessia
- episodi convulsi cronici a causa ignota; trattabili con farmaci
anticonvulsivanti
- Elettroencefalografia
(EEG) - metodo per diagnosticare e valutare l¹epilessia e altri disordini
convulsivi.
Pics properties
executed
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |


