|
|
Medicina popolareper autodidatti
agosto 8, 2005 |
|
Indice della pagina 1.0 Cellule nervose 2.0 Nervi e tratti 3.0 Riparazione delle fibre nervose 4.0 Funzionamento di cellule nervose 5.0 Impulsi nervosi 6.0 Potenziale d¹azione 7.0 Trasmissione sinaptica 8.0 Neurotrasmettitori 9.0 Modificazioni nel corso della vita 10.0 Quadro generale 11.0 Meccanismi di malattia |
AF 3.11 Cellule nervose
NeuroniAnatomia neurologica © Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 19.1
|
INDICE: Cellule nervose
AF 3.11
1.0 Cellule
nervose
1.1 Cellula
nervosa tipo
1.2 Neuroglia
1.2.1 Astrociti
1.2.2 Microglia
1.2.3 Cellule
ependimali
1.2.4 Oligodendrociti
1.2.5 Cellule
di Schwann
1.3 Neuroni
1.3.1 Neurofibrille
1.3.2 Corpi
di Nissl
1.3.3 Dendriti
1.3.4 Assone
1.4 Classificazione
dei neuroni
1.5 Arco
riflesso
2.0 Nervi
e tratti
2.1 Nervi
2.2 Tratti
2.3 Materia
bianca
2.4 Materia
grigia
2.5 Nervi
misti
3.0 Riparazione
delle fibre nervose
3.1 Proliferazione
3.2 Riparazione
SNP
3.3 Condizioni
di riparazione SNP
3.4 Stadi
di riparazione SNP
3.5 Riparazione
nel SNC
4.0 Funzionamento
di cellule nervose
4.1 Neurone
4.2 Sequenza
dei neuroni
5.0 Impulsi
nervosi
5.1 Potenziale
di membrana
5.2 Potenziale
di riposo (PR)
5.3 Potenziali
locali
6.0 Potenziale
d¹azione
6.1 Potenziale
d¹azione
6.2 Meccanismo
che provoca un potenziale d¹azione
6.3 Periodo
refrattario
6.4 Conduzione
del potenziale d¹azione
7.0 Trasmissione
sinaptica
7.1 Struttura
della sinapsi
7.2 Meccanismo
della trasmissione sinaptica
7.3 Sommazione
8.0 Neurotrasmettitori
8.1 Neurotrasmettitori
8.2 Classificazione
dei neurotrasmettitori
8.3 Acetilcolina
8.4 Amine
8.5 Amminoacidi
8.6 Neuropeptidi
9.0 Modificazioni
nel corso della vita
9.1 Sviluppo
del tessuto nervoso
9.2 Circuiti
neurali
9.3 Sinapsi
elettriche
9.4 L¹accrescimento
10.0 Quadro
generale
10.1 Neuroni
10.2 Neuroni
sensitivi
10.3 Neuroni
motori
10.4 Effettori
10.5 Neurotrasmettitori
10.6 Memorizzazione,
apprendimento
11.0 Meccanismi
di malattia
11.1 Neurogliali
11.2 Neuronali
11.3 Tumori
maligni
11.4 Tumori
del sistema nervoso centrale
11.5 Tumori
del sistema nervoso periferico
11.6 I tumori gliali
11.7 Neurofibromatosi multipla
1.0 Cellule
del sistema nervoso
Neuroni e neuroglia.
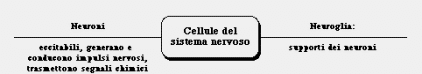
1.1 Cellula nervosa tipo
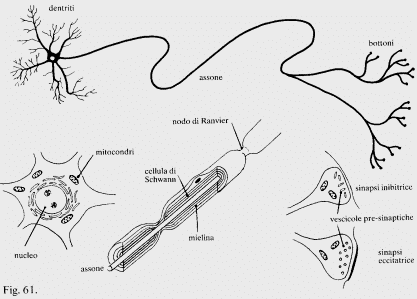
1.2 Neuroglia
Le cellule di neuroglia sono elementi di supporto dei
neuroni.
Cinque principali tipi di neuroglia (fig. 11-2).
1.2.1 Astrociti
- Le
più grandi e numerose cellule di neuroglia dalla forma stellata.
- Formano
guaine attorno ai capillari del SNC che,
per le giunzioni strette fra le
cellule
endoteliali dei capillari costituiscono la barriera emato-encefalica
1.2.2 Microglia
- Cellule
piccole e solitamente quiescenti.
- Nei
tessuti infiammati del SNC, divengono di maggiori dimensioni, si
mobilizzano
e sono capaci di fagocitosi.
1.2.3 Cellule
ependimali
- Somigliano
a cellule epiteliali e formano il sottile strato che tappezza le cavità
ventricolari
del SNC.
- Alcune
producono il liquido contenuto in queste cavità; altre ne permettono la
sua
circolazione.
1.2.4 Oligodendrociti
- Più
piccoli degli astrociti e con pochi prolungamenti.
- Avvolgono
le fibre nervose della sostanza bianca del nevrasse e producono
la loro guaina
mielinica.
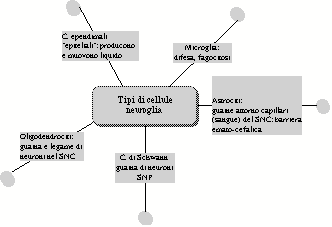
1.2.5 Cellule
di Schwann
- Si
trovano soltanto nel sistema nervoso periferico.
- Avvolgono
le fibre dei nervi periferici e formano la loro guaina mielinica.
- Gli intervalli tra le cellule di
Schwann sono denominati nodi di Ranvier.
1.3 Neuroni
Cellule eccitabili che danno inizio e poi conducono
gli impulsi che rendono possibili le funzioni del sistema nervoso. (fig. 11-3)
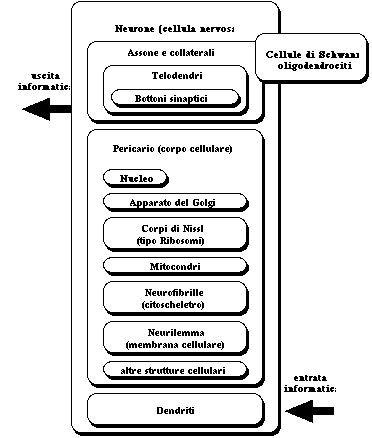
1.3.1 Neurofibrille
- ³Fasci²
di sottili microtubuli e microfilamenti che formano il citoscheletro dei
neuroni
e che, dopo fissazione dei tessuti, appaiono come neurofibrille.
- Il
citoscheletro consente il rapido trasporto di molecole dal pericarione
all¹estremità
terminale
degli assoni e viceversa.
1.3.2 Corpi
di Nissl
- Forniscono
le molecole proteiche necessarie per la trasmissione dell¹impulso
nervoso
da un neurone all¹altro (neurotrasmettitori).
- Forniscono
le proteine per mantenere e rigenerare le fibre nervose.
1.3.3 Dendriti
- Ogni
neurone ha uno o più dendriti che si ricongiungono al corpo cellulare.
- Generano
un potenziale nervoso verso il pericarione dei neuroni.
- Le
estremità distali dei dendriti dei neuroni sensitivi sono ricettrici.
1.3.4 Assone
- Processo
singolo che ha origine dal cono iniziale dell¹assone; spesso è ricoperto
dalla guaina mielinica (fig. 11-4).
- Conduce
impulsi nervosi in direzione centrifuga rispetto al pericarione.
- Le
estremità distali degli assoni sono i teleodendri che terminano con bottoni
sinaptici.
1.4 Classificazione
dei neuroni
Classificazione in base alla struttura - tiene conto
del numero dei processi (fig. 11-5).
- Multipolari un
assone e diversi dendriti
- Bipolari un
assone e un dendrite; un numeroso gruppo di neuroni
- Unipolari dal
corpo cellulare emerge un unico processo che poi si divide quasi
subito
in un assone e in un dendrite.
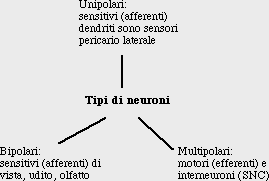
Classificazione in base alla funzione
- Neuroni afferenti (sensori) conducono
impulsi dai sensori (recettori) tramite il mi- dollo
spinale al cervello;
- Neuroni efferenti (effettori) conducono
impulsi dal cervello o dal midollo spinale
ai
muscoli o alle ghiandole.
1.5 Arco
riflesso
Un circuito per la conduzione di impulsi per e dal
sistema nervoso centrale, con l¹impulso che ha avuto origine nei recettori e
termina sugli effettori.
Arco a tre neuroni:
È il più comune; consistente in neuroni afferenti,
interneuroni, neuroni efferenti (fig. 11-6).
- Neuroni afferenti conducono
impulsi dai recettori al SNC.
- Neuroni efferenti conducono
impulsi dal SNC agli effettori (tessuto muscolare e ghiandole).
- Interneurone: neurone
di relais che connette un neurone afferente (sensibile) con
un efferente (motorio) .
Arco a due neuroni:
La forma più semplice; consistente in un neurone
afferente e in uno efferente.
Sinapsi:
- Sedi ove
gli impulsi nervosi vengono trasmessi da un neurone all¹altro
- Situate
tra il bottone sinaptico di un neurone e i dendriti o corpi cellulari di un
altro neurone.
2.0 Nervi e tratti
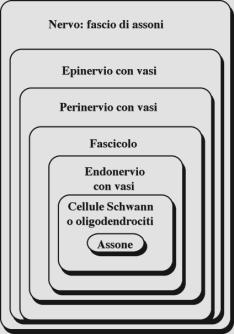
2.1 Nervi
Fasci di fibre nervose periferiche tenute insieme
da diversi strati di tessuto
connettivo (fig. 11-8).
- Endonervio strato
delicato di connettivo fibroso che circonda
ciascuna
fibra nervosa.
- Perinervio tessuto
connettivo che avvolge interi fascicoli di
fibre
nervose.
- Epinervio strato
fibroso che circonda numerosi fascicoli nervosi
e
vasi sanguigni per formare il ³nervo².
2.2 Tratti
Entro il SNC i fasci di fibre nervose sono denominate
tratti invece di nervi.
2.3 Materia
bianca
- SNP nervi mielinici
- SNC tratti mielinici (o vie nervose)
2.4 Materia
grigia
È formata dai corpi cellulari e da fibre amieliniche.
- SNC è organizzata in nuclei
- SNP è organizzata in gangli
2.5 Nervi
misti
Contengono sia fibre sensitive sia motrici
- Nervi
motori nervi
con predominanza di fibre motrici.
- Nervi
sensitivi nervi
con predominanza di fibre sensitive.
3.0 Riparazione
delle fibre nervose
3.1 Proliferazione
I neuroni maturi hanno perduto ogni capacità di
effettuare la divisione cellulare, quindi il danno al tessuto nervoso può
essere permanente.
3.2 Riparazione
SNP
I neuroni hanno limitata capacità di riparare i
propri danni.
3.3 Condizioni
di riparazione SNP
Se il danno non è esteso, i corpi cellulari
(pericarione), i neurilemma sono integri, e non si è formato tessuto
cicatriziale, le fibre nervose possono essere riparate.
3.4 Stadi
di riparazione SNP
Stadi della riparazione di un assone in un neurone
motore periferico:
- Dopo il
danno, il segmento distale di un assone e la corrispondente guaina mielinica
degenerano.
- I
macrofagi rimuovono i detriti.
- Il
restante neurilemma e l¹endonervio formano un tunnel che si estende dalla sede
della lesione all¹effettore.
- Nel
tunnel crescono nuove cellule di Schwann che delimitano la via per la
ricrescita dell¹assone.
- Il
pericarione interessato riorganizza i suoi corpi di Nissl e fornisce le
proteine necessarie ad allungare il restante segmento sano dell¹assone.
- Appare
una ³gemma² di assone.
- Quando
questa ³gemma² raggiunge il tunnel incomincia a crescere.
- Le
cellule del muscolo scheletrico si atrofizzano (se non sottoposte ad adeguato
trattamento fisioterapico) finché non si ristabilisce la connessione nervosa.
3.5 Riparazione
nel SNC
Nel SNC, è impossibile che abbia luogo una
riparazione analoga delle fibre nervose danneggiate.
4.0 Funzionamento
di cellule nervose
4.1 Neurone
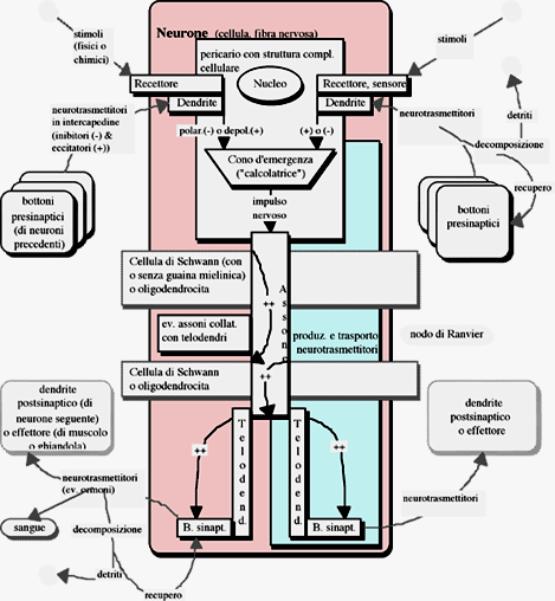
4.2 Sequenza dei neuroni
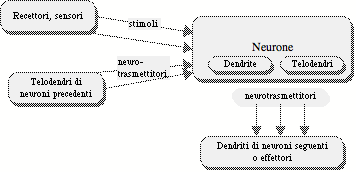
5.0 Impulsi
nervosi
5.1 Potenziale
di membrana
- Tutte le
cellule viventi mantengono una differenza nella concentrazione di ioni attraverso la membrana.
- Potenziale
di membrana - un modesto eccesso di ioni carichi positivamente all¹esterno
della membrana e un modesto eccesso di ioni carichi negativamente all¹interno
(fig. 11-10).
- La
differenza di carica elettrica è denominata potenziale perché è un tipo di
energia immagazzinata.
- Membrana
polarizzata - una membrana che ha un potenziale di membrana.
- La
grandezza della differenza di potenziale tra le due superfici di una membrana
polarizzata viene misurata in volt (V) o millivolt (mV); il segno del voltaggio
di una membrana indica la carica della superficie interna di una membrana
polarizzata.
5.2 Potenziale
di riposo (PR)
- Potenziale
della membrana plasmatica di un neurone quiescente, che non conduce
impulsi; tipicamente è di -70 mV.
- Il
modesto eccesso di ioni positivi sulla superficie esterna della membrana è
determinato primariamente da meccanismi di trasporto ionico.
- Pompa
sodio-potassio.(fig. 11-11)
- Meccanismo
di trasporto attivo nella membrana plasmatica che trasporta Na+ e K+ in opposte
direzioni e in quantità differenti.
- Si
determina uno squilibrio nella distribuzione di ioni positivi col risultato che
l¹interno comincia a diventare
leggermente negativo rispetto all¹esterno.
- Anche le
caratteristiche di permeabilità selettiva della membrana contribuiscono a
mantenere un modesto eccesso di ioni positivi sulla superficie esterna.
5.3 Potenziali
locali
(prevalentemente zona dendriti/pericarione)
- Potenziali
locali - modeste oscillazioni rispetto al potenziale di riposo in una specifica
regione della membrana plasmatica. (fig. 11-13)
- Eccitazione
- quando uno stimolo fa scattare l¹apertura di altri canali Na+, consentendo al
potenziale di membrana di salire verso lo zero (depolarizzazione).
- Inibizione
- quando uno stimolo fa scattare l¹apertura di addizionali canali K+,
aumentando il potenziale di membrana (iperpolarizzazione).
- I
potenziali locali si definiscono potenziali graduati perché l¹ampiezza della
deviazione dal potenziale di riposo è proporzionale all¹intensità dello
stimolo.
6.0 Potenziale
d¹azione
(Prevalentemente zona cono d¹emergenza/assone).
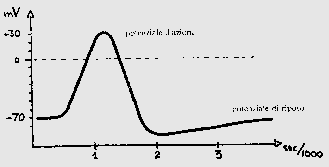
6.1 Potenziale
d¹azione
è il potenziale di membrana di un neurone che conduce
un impulso; noto anche come impulso nervoso.
6.2 Meccanismo
che provoca un potenziale d¹azione (fig. 11-15)
- Quando
uno stimolo adeguato fa scattare l¹apertura di canali Na+, consentendo al Na+
di diffondersi rapidamente all¹interno della cellula, provocando una depolarizzazione
locale.
- Quando
viene raggiunto il potenziale di soglia si aprono canali addizionali di Na+ e
questo entra nelle cellule, provocando ulteriore depolarizzazione.
- Il
potenziale d¹azione è una risposta tipo tutto-o-nulla.
- Canali
Na+ voltaggio-dipendenti restano aperti solo per 1 millisecondo prima che si
chiudano automaticamente.
- Dopo che
il potenziale d¹azione ha raggiunto il picco, la membrana comincia a tornare ai
valori del potenziale di riposo quando si aprono i canali K+ consentendo la fuoriuscita
di K+; il processo è noto come ripolarizzazione.
- Fa
seguito un breve periodo di iperpolarizzazione, quindi è restaurato il
potenziale di riposo a opera delle pompe sodio-potassio.
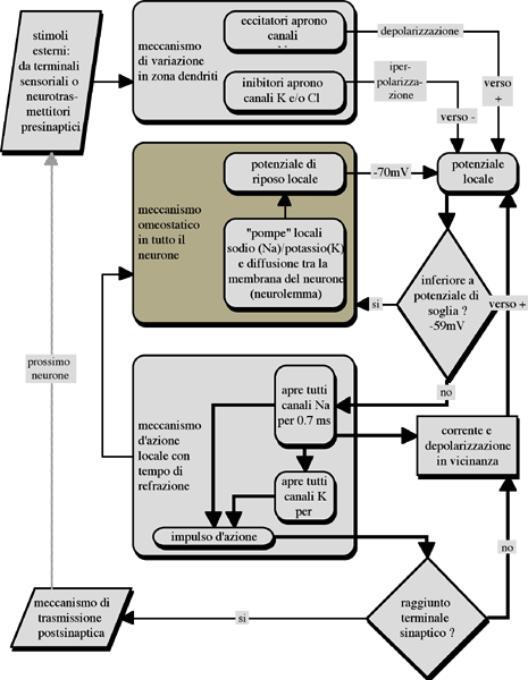
6.3 Periodo
refrattario (fig.
11-16)
- Periodo
refrattario assoluto: breve periodo (durata circa 1/2 ms) durante il quale
un¹area localizzata della membrana di un neurone resiste a una successiva
stimolazione, non rispondendo allo stimolo per quanto intenso questo possa
essere.
- Periodo
refrattario relativo: tempo durante il quale la membrana si sta ripolarizzando
e si sta restaurando il potenziale di riposo pochi millisecondi dopo il periodo
refrattario assoluto; una risposta è possibile solo a uno stimolo molto
intenso.
6.4 Conduzione
del potenziale d¹azione
- Al picco
del potenziale d¹azione la polarità della membrana plasmatica è invertita
rispetto a quella del potenziale di riposo.
- L¹inversione
della polarità provoca un flusso di corrente tra la sede del potenziale
d¹azione e le regioni adiacenti della membrana, facendo scattare l¹apertura dei
canali Na+ dei segmenti successivi; questi segmenti successivi presentano
anch¹essi un potenziale d¹azione. (fig. 11-17)
- Il ciclo
continua a ripetersi nel senso di propagazione centrifuga nell¹assone.
- Il
potenziale d¹azione non procede mai all¹indietro a causa del periodo
refrattario.
- Nelle
fibre mieliniche, le cariche elettriche della membrana possono esserci solo ai
nodi di Ranvier; questo tipo di conduzione dell¹impulso lo si definisce
conduzione/saltatoria (fig. 11-18)
- La velocità della conduzione nervosa dipende dal
diametro e dalla presenza o assenza della guaina mielinica saltatoria.(fig.
11-18).
7.0 Trasmissione
sinaptica
Struttura, meccanismo, sommazione.
7.1 Struttura
della sinapsi (fig.
11-19)
- Bottone
sinaptico -piccolo rigonfiamento all¹estremità di una branca terminale
(telodendro) dell¹assone di un neurone presinaptico, contenente vescicole piene
di neurotrasmettitore.
- Fessura
sinaptica -intervallo tra il bottone sinaptico e la membrana plasmatica di un
neurone postsinaptico.
- Membrana
plasmatica del neurone postsinaptico (dendrite, pericario) -contiene molecole
proteiche che funzionano da ricettori per i neurotrasmettitori.
7.2 Meccanismo
della trasmissione sinaptica
La sequenza degli eventi è la seguente:
- Il
potenziale d¹azione raggiunge un bottone sinaptico causando la rapida entrata
di ioni di calcio all¹interno del bottone sinaptico.
- L¹aumento
della concentrazione del calcio fa scattare il rilascio del neurotrasmettitore
per esocitosi.
- Le
molecole del neurotrasmettitore si diffondono attraverso la fessura sinaptica e
si legano alle molecole ricettrici provocando l¹apertura dei canali ionici.
- L¹apertura
dei canali ionici produce un potenziale postsinaptico: o un potenziale
postsinaptico eccitatorio (PPSE) o un potenziale postsinaptico inibitorio
(PPSI).
- L¹azione
del neurotrasmettitore termina rapidamente sia perché le molecole del
neurotrasmettitore vengono recuperate in parte all¹interno del bottone
sinaptico, sia perché vengono metabolizzate in composti inattivi.
7.3 Sommazione
(fig. 11-21)
- Sommazione
spaziale -somma degli effetti di un certo numero di bottoni sinaptici attivati
simultaneamente e sistemati in modo da stimolare in sedi differenti una
membrana postsinaptica e provocare un potenziale d¹azione.
- Sommazione
temporale -quando i bottoni sinaptici stimolano un neurone postsinaptico in
rapida successione, i loro effetti possono sommarsi entro un breve periodo di
tempo e produrre un potenziale d¹azione.
8.0 Neurotrasmettitori
Classificazione, acetilcolina, amine, amminoacidi,
neuropeptidi
8.1 Neurotrasmettitori
Sostanze per mezzo delle quali i neuroni comunicano
con un altro; vi sono più di 30 composti noti per essere neurotrasmettitori e
una dozzina di altri si sospetta che possano esserlo.
8.2 Classificazione
dei neurotrasmettitori
Di solito classificati in base alla:
- Funzione
di un neurotrasmettitore determinata dal ricettore postsinaptico; le due
principali classificazioni comprendono neurotrasmettitori eccitatori e inibitori.
- Struttura
chimica: il meccanismo per cui il neurotrasmettitore provoca un cambiamento; vi
sono quattro classi principali; poiché le funzioni di specifici
neurotrasmettitori variano a seconda della sede, li si classifica di solito in
base alla natura chimica.
8.3 Acetilcolina
- Struttura
chimica unica: acetato (acetil coenzima A) e colina (lecitina).
- L¹acetilcolina
è inattivata dall¹acetilcolinesterasi, con molecole di colina che vengono
staccate e recuperate nel bottone sinaptico per ricombinarsi con l¹acetato.
- Presente
in varie sedi, spesso con un ruolo eccitatore, ma a volte inibitore.
8.4 Amine
- Sintetizzate
da molecole di amminoacidi.
- Si
trovano in varie regioni del cervello, interessano l¹apprendimento, le
emozioni, il controllo motorio ecc.
8.5 Amminoacidi
- Si
considera che siano tra i neurotrasmettitori più comuni nel SNC.
- Nel SNP
gli amminoacidi vengono immagazzinati nelle vescicole sinaptiche e utilizzati
come neurotrasmettitori.
8.6 Neuropeptidi
- Formati
da polipeptidi.
- Possono
essere secreti per sé, oppure come secondo o terzo neurotrasmettitore; in
questi casi, i neuropeptidi agiscono da neuromodulatore, un ³cotrasmettitore²
che regola gli effetti del neurotrasmettitore rilasciato insieme ad essi.
9.0 Modificazioni
nel corso della vita
9.1 Sviluppo
del tessuto nervoso
- Deriva
dall¹ectoderma.
- Avviene
con rapidità nell¹utero materno e nei primi due anni di vita.
9.2 Circuiti
neurali
Le cellule del sistema nervoso organizzano circuiti
neurali nel corpo
9.3 Sinapsi
elettriche
- Si
formano e riformano finché il sistema nervoso è intatto.
- Vengono
sostituite da sinapsi chimiche quando si stabiliscono connessioni permanenti.
- La
formazione di nuove sinapsi stimola l¹apprendimento e la memoria.
9.4 L¹accrescimento
È causa di degenerazione del sistema nervoso e porta
alla senilità
10.0 Quadro
generale
10.1 Neuroni
I neuroni agiscono come marchingegni per raccogliere,
valutare e sommare degli stimoli, generare ev. impulsi elettrici, condurli a
distanze notevoli e trasmetterli ad altri neuroni o effettori.
10.2 Neuroni
sensitivi
Agiscono da ricettori che rilevano i cambiamenti
dell¹ambiente interno ed esterno; portano informazioni ai meccanismi
integratori del SNC
10.3 Neuroni
motori
Le informazioni, dopo elaborazione e analisi, consentono
di dare una risposta ad appropriati effettori per mezzo dei neuroni motori
10.4 Effettori
Il neurotrasmettitore fa scattare una risposta per
restaurare l¹omeostasi
10.5 Neurotrasmettitori
Se i neurotrasmettitori vengono rilasciati nel
sangue, vengono chiamati ormoni
10.6 Memorizzazzione,
apprendimento
I neuroni sono responsabili delle risposte adeguate
agli stimoli; i circuiti sono capaci di memorizzare, apprendere nuove risposte,
generare il pensiero ecc. Il meccanismo di memorizzazione è sconosciuto.
11.0 Meccanismi
di malattia
Alterazioni delle cellule del sistema nervoso.
11.1 Neurogliali
Molte malattie del sistema nervoso interessano la
neuroglia piuttosto che i neuroni. Alterazioni midiniche come Mb. Parkinson,
Sclerosi multipla,
11.2 Neuronali
- Tumori
che hanno origine da strutture del sistema nervoso.
- Si
sviluppano dalla neuroglia, dalle membrane di avvolgimento e dai vasi
sanguigni.
- Glioma
-tumori cerebrali molto comuni sono solitamente benigni; è difficile il
trattamento poiché si sviluppano in aree profonde del cervello.
11.3 Tumori
maligni
I tumori più maligni del sistema nervoso sono tumori
secondari dovuti a metastasi di cellule cancerose di polmoni, mammelle e altri
organi.
11.4 Tumori del
sistema nervoso centrale
- Astrocitoma
- glioma originante dagli astrociti; sono tumori cerebrali a lenta crescita e
infiltranti che si sviluppano solitamente nella quarta decade della vita.
- Sintomi
- crisi epilettiche, mal di testa o deficit neurologici indicativi dell¹area
coinvolta.
- Glioblastoma
- multiforme forma maligna di astrocitoma che irradia nella materia bianca del
cervello; la rimozione chirurgica è difficile e la sopravvivenza media è
inferiore a 1 anno.
- Ependimoma
- tumore neurologico originante dalle cellule di rivestimento, comune nei
bambini. Ostruisce le vie di flusso del liquido cerebrale essendo causa di
ipertensione endocranica con conseguenti danni neurologici; la correzione
chirurgica porta a una sopravvivenza media postoperatoria di circa 5 anni.
- Oligodendroglioma
-glioma di oligodendrociti, interessa la parte anteriore del cervello; picco
d¹incidenza a 40 anni di età; sopravvivenza media 10 anni.
11.5 Tumori del
sistema nervoso periferico
- Neurinoma
dell¹acustico -lesione delle cellule di Schwann dell¹ottavo paio di nervi
cranici; è un piccolo tumore.
- Sintomi
-difficoltà nel decifrare il linguaggio attraverso l¹orecchio interessato,
vertigini, tinnito, e perdita lenta, ma progressiva dell¹udito.
- Il
tumore può essere asportato mediante microchirurgia.
11.6 I tumori
gliali
Possono svilupparsi entro o sui nervi cranici o in
altre regioni del SNP.
11.7 Neurofibromatosi
multipla
Malattia ereditaria caratterizzata da numerosi
neuromi fibrosi distribuiti nel corpo; i tumori sono solitamente benigni ma
possono essere causa di grave deturpazione della fisionomia dei soggetti
colpiti.
Pics properties
executed
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. GFDL Gnu Free Documentation
License Il materiale contenuto in questo sito può essere
usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |


